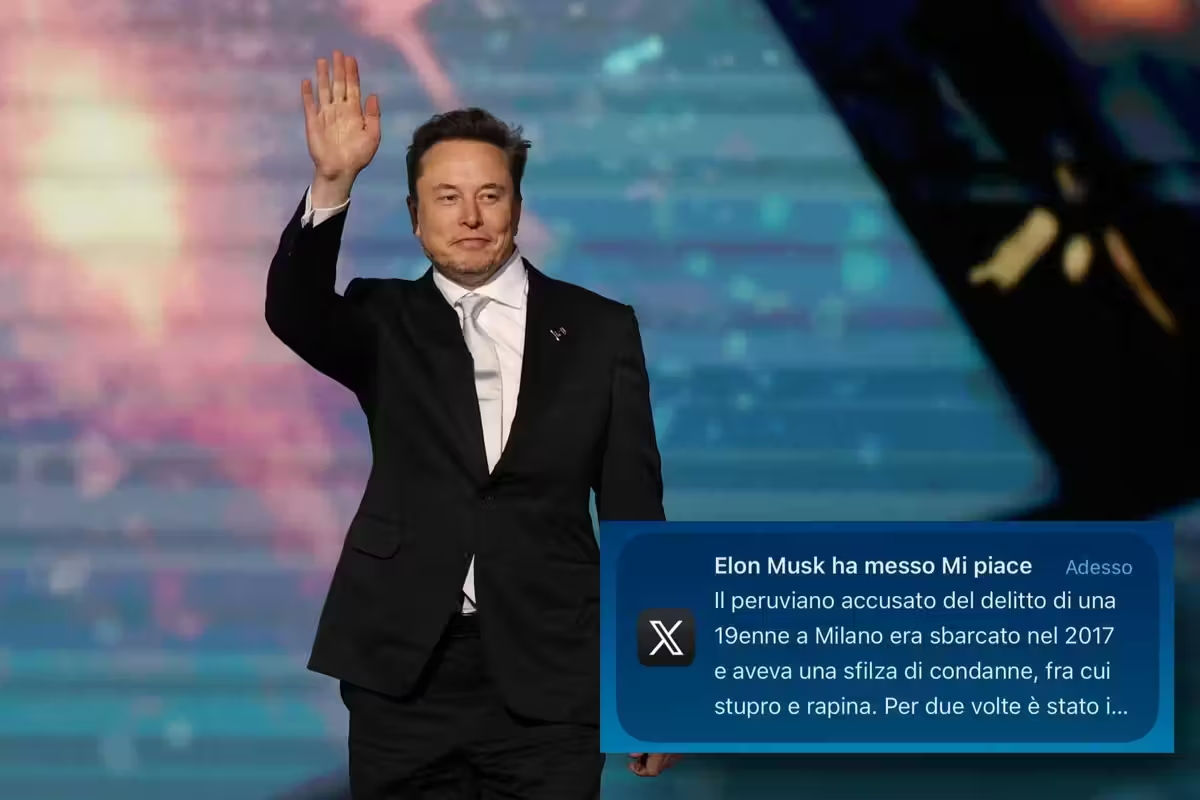Papa Francesco rottama i movimenti. Dopo dieci anni i capi devono lasciare

Per un «sano ricambio», si potrebbe riassumere così l'intento del decreto pubblicato ieri dal Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita. I capi al vertice del governo dei movimenti ecclesiali, «associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero», hanno i giorni contati, o meglio la stessa persona potrà restare al comando del movimento «per un periodo massimo di dieci anni consecutivi».
Ma allora don Julián Carrón, che è presidente della Fraternità di Comunione e liberazione dal 2005, decade? E Giovanni Ramonda, eletto nel 2008 successore di don Oreste Benzi nella Associazione papa Giovanni XXIII? Secondo le nuove regole dovranno «provvedere a nuove elezioni entro e non oltre 24 mesi», appunto per «promuovere un sano ricambio», dice il decreto nella premessa. Inoltre, d'ora in avanti i mandati nell'organo centrale di governo possono durare massimo cinque anni.
Se il ricambio sarà «sano» si vedrà, intanto sarà certamente «ricambio», anche per favorire un passaggio «generazionale». L'orizzonte sembra un po' in stile rottamazione di sapore grillino, visto che gli obiettivi hanno un retrogusto aziendalista che non è usuale nel mondo dei movimenti ecclesiali. Si citano «l'opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo», «la necessità di prevedere mandati di governo tali da consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell'associazione», manca solo il conflitto di interessi e la separazione delle funzioni e il menù sarebbe completo.
Per carità, se il fondatore è vivente resta in carica, se il Dicastero lo dispensa. E ci mancherebbe altro, provate a immaginarvi un San Francesco di Assisi, per dire, sottoposto al voto e alle correnti per la successione… forse non sarebbe un gran servizio reso allo Spirito santo. Perché questi movimenti non sono Ong, né Srl, né partiti e l'organizzazione democratica, a cui il Decreto invece si impegna, non può ingabbiare il «carisma». Si tratta di realtà comunitarie, diceva Giovanni Paolo II, che tanto si è speso per i movimenti, generate da «un carisma preciso», dotato di una propria «originalità», «donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati» dall'azione dello Spirito.
Ma d'altra parte non si può nascondere che il rischio di utilizzare il «carisma» per accomodarsi in qualche poltrona o poltroncina esiste. Il rischio che il «carisma» delle origini si perda è una realtà per i movimenti, con il fondatore scimmiottato o tradito, utilizzato da qualche ventriloquo che confonde il suo pensiero con quello originale del fondatore.
Il mondo dei movimenti è stato fondamentale per la Chiesa degli anni Ottanta e Novanta, fino ai primi 2000, quando in piena crisi post conciliare ha rappresentato una realtà che ha tenuto in piedi una certa vitalità ecclesiale nella società e nella cultura. Poi l'appannamento, che in alcuni casi è stato anche dettato dalla successione dopo il fondatore, un parto sempre difficile come insegna anche la storia degli ordini religiosi.
Di certo i movimenti non possono diventare chiesuole nella Chiesa, o sviluppare forme identitarie che finiscono per cadere nel rischio deplorato da San Paolo che ricordava ai Corinzi che «quando uno dice: “Io sono di Paolo", e un altro: “Io sono di Apollo"», si finisce per essere «semplicemente uomini». Papa Francesco, in un suo famoso discorso alla Fraternità di Cl nel 2015, questa la definì «spiritualità di etichetta». Ma fu allo stadio Olimpico di Roma nel 2014 che disse davanti al Rinnovamento nello Spirito santo che «nessuno può dire: “Io sono il capo". Voi, come tutta la Chiesa, avete un solo capo, un solo Signore: il Signore Gesù». E disse di fare attenzione che «tante volte, i responsabili» diventano «controllori della grazia di Dio», decidendo del cammino delle persone.
La severità di Francesco nei confronti dei movimenti è certamente più alta di quella dei suoi due immediati predecessori, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, i quali appunto vedevano in questi gruppi la forma più incisiva di esperienza ecclesiale e in un certo senso anche una risposta alla crisi della fede. Bisogna riconoscere che papa Francesco ha le sue ragioni e l'esperienza dei movimenti necessita di una certa purificazione, senza buttare il bambino con l'acqua sporca. Il Decreto di ieri interviene al cuore del governo di queste realtà offrendo anche spunti di buon senso organizzativo, tuttavia è chiaro che per essere missionari nel senso evangelico del termine non basta la sanità procedurale e una buona elezione democratica tra i membri.