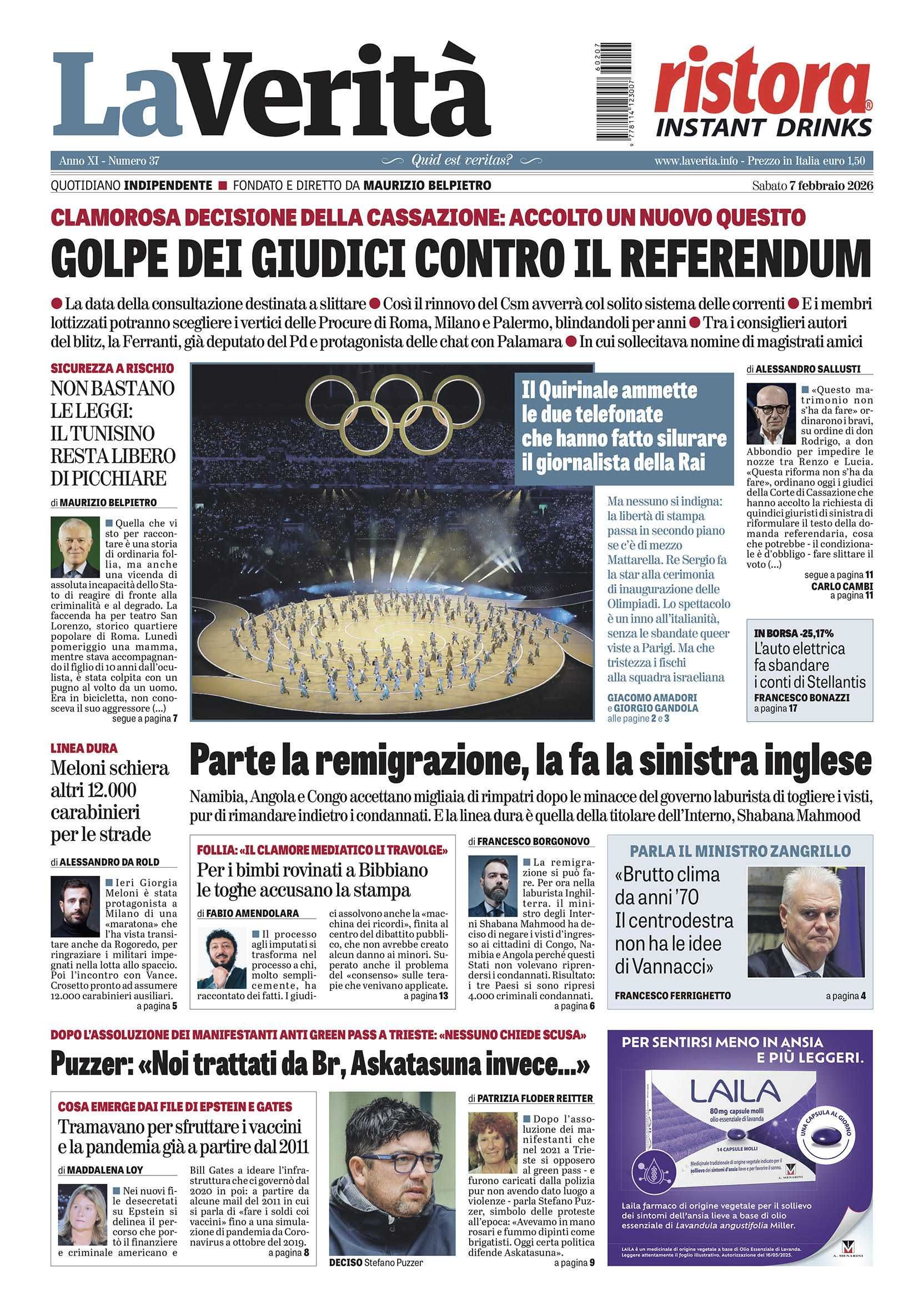«Da due anni e mezzo stiamo vivendo una crisi che non è solo sanitaria ma intellettuale, caratterizzata dall’impossibilità di contraddittorio scientifico e dall’imposizione di un pensiero unico da parte di governi e media che sopravvalutano esperti da loro stessi nominati e screditano ogni voce dissonante. Questa è stupidità».
È una lettura ampia e severa della pandemia quella di Laurent Mucchielli, direttore di ricerca presso il Centro nazionale della ricerca scientifica di Francia, sociologo, autore di decine di pubblicazioni.
Nel 2020, perplesso davanti alla gestione politica dell’emergenza Covid, con una équipe di ricercatori e medici ha avviato un’indagine scientifica indipendente: ne è emerso The Covid Doxa, libro in due volumi che raccoglie i risultati del loro lavoro.
Cosa significa «doxa del Covid»?
«La “doxa” è un concetto filosofico ripreso dal sociologo francese Pierre Bourdieu, con cui si designa il discorso dominante su un dato argomento, in un certo contesto temporale. È dominante perché è il racconto dell’élite, che attraverso questo racconto si autolegittima: la doxa è la narrazione che indica alla popolazione che cosa sia, per lei stessa, buono e giusto. La sociologia della dominazione descrive proprio come certe élite impongano non solo meccanismi economico-sociali ma anche mentali, inculcando una data visione del mondo, e considerino il popolo stupido».
Come è stata applicata la doxa alla pandemia di Covid?
«Partendo da un’analisi strutturale della narrazione che è stata fatta, abbiamo individuato quattro convinzioni su cui essa poggiava: l’idea che l’epidemia rappresentasse una minaccia per l’intera umanità; l’idea che non ci fossero cure mediche per i malati; l’idea che l’unica maniera per contenere l’epidemia fossero i lockdown; l’idea che il solo modo per sconfiggere l’epidemia fosse l’arrivo di un vaccino miracoloso. Queste quattro affermazioni sono tutte discutibili, sia in linea di principio che empiricamente, alla luce delle conoscenze disponibili».
Siamo stati esposti ad una sequenza narrativa insomma?
«Sì, e l’affermazione del direttore dell’Oms a febbraio 2020 secondo il quale il coronavirus era “un pericolo mortale per l’umanità” è stato il punto di partenza: ha seminato subito l’emozione più forte, ovvero la paura di morire. Ancora oggi ci sono persone che non sono uscite da questo stadio e sono come bloccate; è un sentimento che trascende le categorie sociali e prescinde dalla cultura, perché paralizza il lobo frontale, sede della riflessione. Questo è stato un passaggio fondamentale. Diffondendo l’idea che non si sapesse come curare il nuovo virus, dalla paura si è poi passati al terrore e quindi alla necessità di ricorrere al lockdown quale unica misura di contenimento della diffusione. Infine, ultimo passaggio e deus ex machina del racconto, si è annunciato l’arrivo del vaccino quale soluzione. Questa storia, che non nulla a che fare con il complottismo, è stata raccontata fin dall’inizio ed è testimoniata dai discorsi di capi di governo, ministri, autorità».
La vostra analisi smonta tutte le quattro convinzioni. Cominciamo dalla prima: era falso far credere che saremmo morti tutti.
«Fin da subito si è saputo che la stragrande maggioranza della popolazione era asintomatica e che solo una piccola parte, fragile, anziana, con comorbilità e un sistema immunitario compromesso, era esposta alla malattia grave. Trattare tutti indistintamente come potenziali vittime era dunque o un errore o una bugia. Lo aveva scritto, fin da aprile 2020, uno dei più grandi epidemiologi del mondo, John Ioannidis».
La seconda affermazione della narrazione - non ci sono cure - cosa ha comportato?
«Il consiglio era di non fare nulla finché la situazione non fosse degenerata: una aberrazione medica, un rifiuto di curare contrario all’etica. Tutti i medici, una cinquantina tra generalisti e specialisti, che abbiamo intervistato per lo studio e che avevano curato i pazienti Covid fin da subito con antibiotici e altri farmaci conosciuti e sicuri, ci hanno detto di aver sperimentato una mortalità quasi nulla nella loro pratica. Non solo: nelle linee guida sanitarie ufficiali, era stata completamente abbandonata anche ogni consueta prevenzione generale. Un sistema di corruzione ha osteggiato le terapie economiche per sostituirle con altre molto più costose, nell’interesse dell’industria farmaceutica».
Con il lockdown si entra nel cuore della propaganda. Perché?
«Perché essendo una misura politica, richiedeva una giustificazione: per promuoverlo, i governi hanno assicurato, con l’appoggio di scienziati compiacenti, che avrebbe “salvato vite”, laddove in nessun paese occidentale questa misura ha inciso sulla scomparsa o l’attenuazione dell’epidemia. Non solo: i governi non hanno mai neanche cominciato a valutare scientificamente le ricadute sociali, educative e psicologiche dei lockdown a breve, medio e lungo termine. Che sono la realtà con la quale dovremo confrontarci per anni, penso in primis alle conseguenze dell’abbandono scolastico».
Ultimo capitolo: l’arrivo del vaccino.
«Il vaccino salvatore è il gran finale per il quale è stata scritta tutta la storia: è la questione sulla quale non si può esprimere alcun dubbio pena la definizione di novax, complottista, terrapiattista, da parte di politici e giornalisti divenuti propagandisti. Siccome ora sappiamo che il vaccino non protegge dalle forme gravi nella misura inizialmente indicata, non impedisce di contagio e presenta un numero di effetti avversi gravi senza precedenti, di conseguenza deve venir meno la bugia dell’altruismo ampiamente usata e va abbandonata l’idea di vaccinare il cento per cento della popolazione, in nome del principio di precauzione».
Che idea si è fatto di questa vicenda?
«Che siamo davanti al più grande scandalo sanitario della nostra storia. E che la gestione catastrofica di questa crisi va analizzata con coraggio, senza concessioni. Non per cercare colpe ma per non commettere gli stessi errori nelle epidemie future».