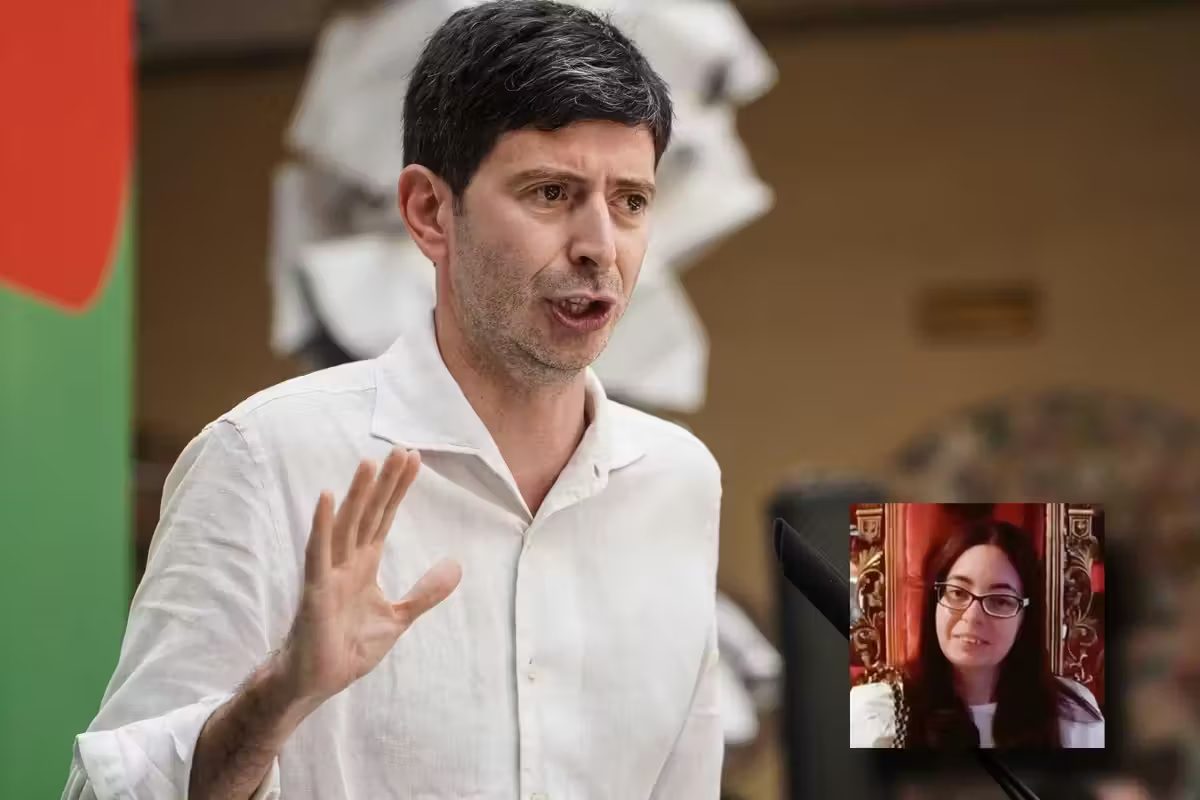Ottant’anni fa il regalo a Hitler che spalancò la botola dell’inferno

«Se fosse scoppiata una guerra [nel 1938] né la nostra frontiera occidentale né quella polacca avrebbero potuto essere difese adeguatamente, e non c'è dubbio che se la Cecoslovacchia si fosse difesa, saremmo stati arrestati dalle sue fortificazioni, perché non avevamo i mezzi per sfondarle». Le parole del feldmaresciallo Erich von Manstein all'udienza del 9 agosto 1946 del processo di Norimberga ribadivano che con il Patto di Monaco (29-30 settembre 1938) le democrazie avevano perso un'occasione unica per liberarsi dell'hitlerismo, perché l'attacco alla Cecoslovacchia (Fall Grün) sarebbe naufragato per ammissione degli stessi vertici della Wehrmacht.
La rete fortificata cecoslovacca era articolata in migliaia di bunker di ultimissima generazione che costituivano un elaborato sistema di ingegneria militare a protezione vicendevole: un gioiello tecnologico persino più avanzato della più nota Linea Maginot, con gallerie sotterranee dove correvano trenini per il trasporto rapido di truppe e munizioni, torrette servoassistite e ascensori elettrici per il rifornimento di proiettili, aria condizionata e potabilizzatori d'acqua. I bunker più grandi erano autentiche cittadelle autosufficienti profonde fino a 50 metri, perfettamente attrezzate.
Con il Patto di Monaco inglesi e francesi, nel nome dell'appeasement acconsentirono ad amputare i Sudeti, facendoli annettere al Reich, e consegnando così con essi tutta la corona di fortificazioni. La Ceco-Slovacchia, come era stata costretta a rinominarsi, era diventata indifendibile. Adolf Hitler lo sapeva benissimo, Neville Chamberlain ed Édouard Daladier, che avevano abbandonato quel Paese nonostante trattati e promesse a difenderlo, facevano finta di non saperlo. Il momento più propizio per il Führer arriverà il 15 marzo 1939: ottanta anni fa le colonne della Wehrmacht invadevano senza colpo ferire l'ultima democrazia della mitteleuropa e Hitler poteva fare il suo ingresso trionfale al Castello di Praga, tra la neve che scendeva dal cielo e le lacrime che scendevano dal volto dei praghesi ammutoliti per quello sfacelo. La Cecoslovacchia nata dalle ceneri della prima guerra mondiale spariva dalla cartina d'Europa: la Slovacchia prendeva la sua strada sotto tutela hitleriana e con la guida nominale di monsignor Jozef Tiso, Boemia e Moravia diventavano Protettorato del Reich, dapprima con la gestione del diplomatico Konstantin von Neurath e successivamente, poiché ritenuto troppo morbido verso la resistenza, col pugno di ferro di Reinhard Heydrich, l'artefice della soluzione finale, passato alla storia con i soprannomi di belva bionda, boia, macellaio di Praga.
Il 15 marzo l'Europa aveva imboccato la via del non ritorno e quella data segna il principio della fine. La chiave di volta era stata la Cecoslovacchia, sacrificata all'illusione della peace in our time. Nel 1938 le divisioni dell'esercito cecoslovacco avevano la più alta potenza di fuoco di qualsiasi omologa unità europea. Le armi di cui disponeva erano di primissimo livello: l'ottima mitragliatrice Bren che equipaggerà gli inglesi era un progetto cecoslovacco, e il nome derivava dalle iniziali della città di Brno dove era stato progettata e la ditta britannica Enfield che la assemblerà; i carriarmati cecoslovacchi erano persino superiori ai Panzer I e II tedeschi del 1938-9, tanto che continueranno a essere costruiti durante tutta la seconda guerra mondiale per equipaggiare le divisioni corazzate tedesche; i cannoni Škoda, che erano stati il nerbo dell'artiglieria austroungarica, erano di livello (gli italiani utilizzeranno le prede di guerra del primo conflitto durante tutta la seconda guerra mondiale); l'industria era moderna, sviluppata e avanzata, e il suo apporto risulterà tutt'altro che secondario nell'alimentare la macchina bellica tedesca. Il sistema di fortificazioni varato nel 1935 per proteggersi dalle minacce tedesche correva lungo la frontiera nordoccidentale con migliaia di fortezze, bunker e casematte di varie tipologie: invisibili dall'alto, erano una trappola mortale per le fanterie e un ostacolo invalicabile per i mezzi. La Repubblica di Edvard Beneš aveva fatto le cose per bene, stanziando cifre mostruose, portando migliaia di tonnellate di ferro e di cemento in boschi e foreste, e tenendo sistematicamente lontano dai cantieri operai e tecnici sudeti, ovvero i tedeschi etnici che avrebbero potuto rivelare a Berlino dettagli coperti da segreto militare.
Le linee fortificate, senza sparare un colpo, saranno consegnate assieme ai Sudeti. I tedeschi nei boschi e al riparo da occhi indiscreti potranno sperimentare nuove strategie d'attacco e le micidiali cariche cave che consentiranno a un pugno di paracadutisti di espugnare nel 1940 il forte belga di Eben Emael, ritenuto imprendibile. I soldati si erano allenati su bersagli reali, tant'è che i bunker portano i segni inequivocabili di cannonate e cariche esplosive che dovevano testarne la resistenza 80 anni fa. Oggi le inutilizzate linee fortificate sopravvissute al tempo e agli eventi sono diventate un suggestivo richiamo turistico sia per chi ama il contatto con la storia, sia per chi è affascinato dalle passeggiate in una natura rigogliosa. Quei bunker, se fossero stati attaccati, come ha sottolineato Manstein a Norimberga, avrebbero cambiato il corso della storia. Ma le democrazie, pur di non impegnarsi in un conflitto locale e limitato, avevano sciaguratamente scelto di barattare qualche mese di effimera pace con la possibilità concreta di scongiurare il disastro epocale della seconda guerra mondiale.