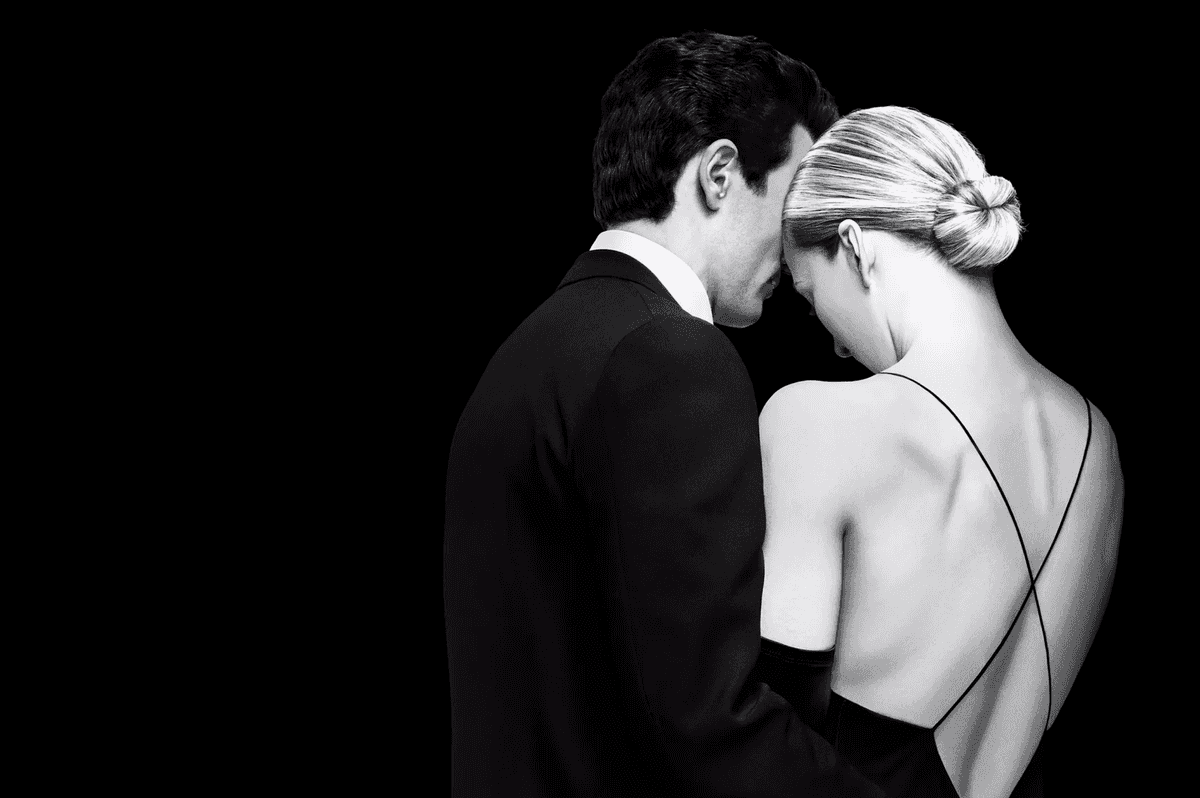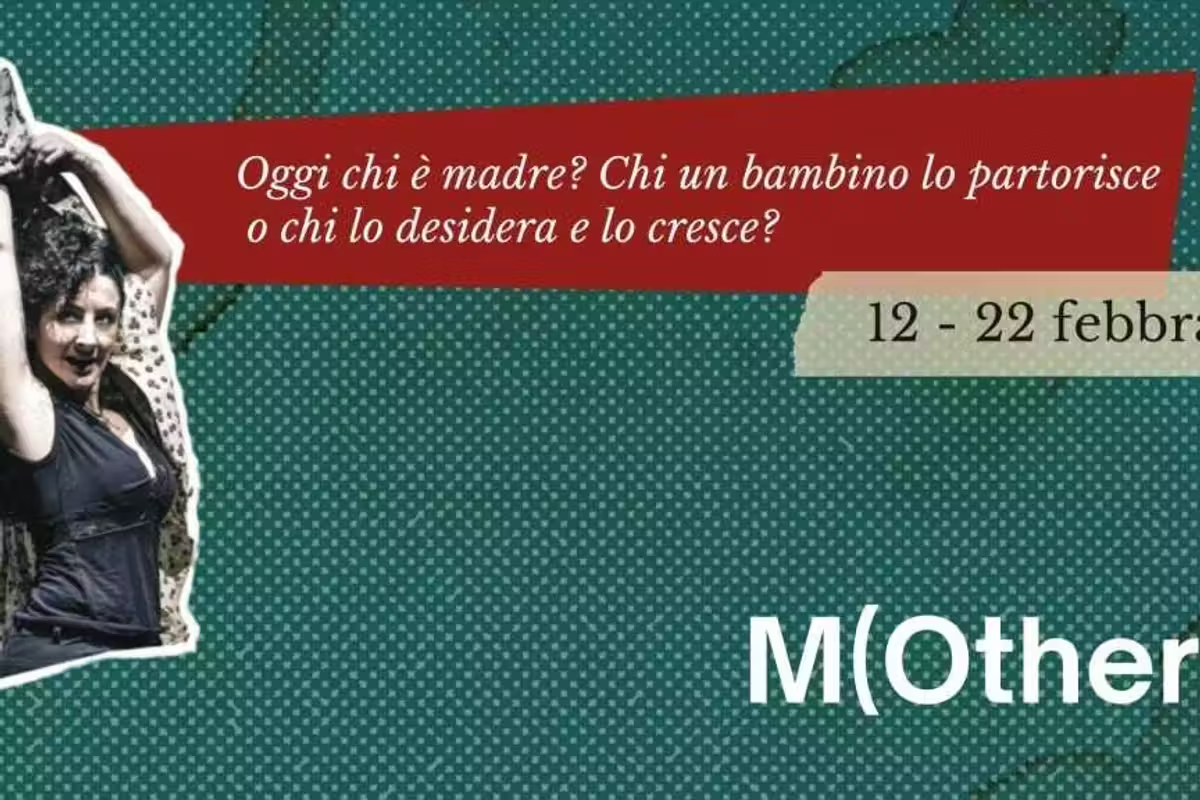Ormai la sinistra ha «dimenticato» decenni di pacifismo per puro interesse

Ma dov’è finito il tradizionale pacifismo che caratterizzava, in tutta l’Europa occidentale, con varie sfumature, la politica delle sinistre e, segnatamente, quella dei partiti comunisti che, specie in Italia e in Francia, hanno avuto per lunghi anni largo seguito popolare? La domanda appare legittima, a fronte della vera e propria psicosi bellicista che, da quando è iniziata, nel febbraio del 2022, la guerra tra la Russia e l’Ucraina, ha contagiato pressoché tutte le sinistre europee, sia di governo che di opposizione, unite nel rifiutare ogni ipotesi di cessazione negoziata del conflitto e nel sostenere non solo la necessità di un sempre maggiore sostegno militare all’Ucraina ma anche quella di un massiccio riarmo dei paesi europei aderenti alla Nato (ormai quasi tutti), in vista di un attacco militare da parte della Russia, dato quasi per certo in un futuro più o meno prossimo. E in quest’ottica si accetta, da parte loro, anche la prospettiva, un tempo rifiutata con orrore, di un dispiegamento di armi atomiche sul suolo europeo e, quindi, di un loro possibile impiego, sempre a fronte dell’ipotetico attacco russo. Si potrebbe pensare che un tale mutamento d’indirizzo trovi la sua spiegazione nell’essersi la Russia dimostrata uno stato aggressore, a fronte del quale, quindi, sarebbe giustificato e, anzi, doveroso l’impiego della forza. Ma la spiegazione non regge alla luce dei precedenti storici. Anche nel 1939, infatti, vi era stata l’aggressione di uno Stato, la Germania nazista, nei confronti di un altro Stato che era la Polonia. Ma alla guerra che, conseguentemente, Francia e Gran Bretagna avevano dichiarato alla Germania, il partito comunista francese mostrò una tale avversione che il governo presieduto da Edouard Daladier si vide costretto a metterlo fuori legge, dopo aver vietato la pubblicazione del quotidiano L’humanitè, che ne era l’organo ufficiale.
La sua linea politica, infatti, rischiava di ulteriormente debilitare il già scarso spirito combattivo delle forze armate e di buona parte dell’opinione pubblica, assai sensibile al famoso detto lanciato, secondo le più attendibili ricostruzioni storiche, dal deputato socialista Marcel Déat fin dal maggio del 1939, secondo cui non valeva la pena di «morire per Danzica». Ed è di tutta evidenza che l’adozione di quella linea politica ad altro non era dovuta se non al fatto che la guerra alla Germania appariva contraria agli interessi dell’Urss che, a seguito del patto Ribbentrop-Molotov del 24 agosto 1939, aveva avuto mano libera nell’occupare la parte orientale della Polonia, dopo che quella occidentale era stata occupata dai tedeschi. Lettura, questa, che trova conferma, se mai ce ne fosse bisogno, nel fatto che solo dopo l’inopinato attacco tedesco all’Urss, nel giugno del 1941, l’atteggiamento del partito comunista francese ebbe a cambiare radicalmente. Ed è ancora in piena consonanza con gli interessi geo-politici e militari dell’Urss ed anche della Cina, divenuta comunista sotto Mao Tse Tung, che, nel dopoguerra, tanto il partito comunista francese quanto quello italiano (riemerso dalla clandestinità cui era stato costretto durante il regime fascista) ebbero a manifestare il loro «pacifismo» , con la fiera e intransigente opposizione a tutto ciò che era o appariva contrario agl’interessi del blocco comunista, a cominciare dalla creazione ed ai successivi allargamenti della Nato per passare, poi, alla guerra americana nel Vietnam ed all’ installazione in Europa dei cosiddetti «euro-missili» americani, in contrapposizione a quelli schierati dall’Urss.
Si ricorderà, a quest’ultimo proposito, il famoso slogan «meglio rossi che morti», che figura, con il punto interrogativo, come titolo di un libro di Paolo Pillitteri, pubblicato nel 1982. Eppure, all’epoca, il pericolo rappresentato dall’Unione Sovietica per la libertà dei popoli e delle nazioni non era certo minore di quello oggi rappresentato dalla Russia. Basterebbe ricordare la sanguinosa invasione dell’Ungheria da parte dell’Armata rossa nel novembre del 1956, dopo che il capo del governo ungherese, Imre Nagy, giunto al potere sull’onda della rivoluzione popolare contro la dittatura comunista, aveva preannunciato l’uscita del suo paese dall’alleanza militare (il cosiddetto Patto di Varsavia) che riuniva, all’epoca, l’Urss ed i paesi dell’Europa orientale da essa, di fatto, controllati. Evento, questo, che non suscitò alcuna opposizione da parte dei partiti comunisti italiano e francese, fatta salva quella di alcuni singoli esponenti che decisero, in conseguenza, di allontanarsene. E non più che una blanda dissociazione fu quella manifestata dagli stessi partiti a seguito del brutale intervento militare sovietico che, nel 1968, pose fine alla «Primavera di Praga», cioè al tentativo di parziale liberalizzazione del regime comunista cecoslovacco, portato avanti dal presidente Aleksander Dubcek.
Oggi i partiti comunisti sono pressoché scomparsi, ma la loro eredità, specie in Italia, è ancora assai presente in quelli che, con varie approssimazioni, possono dirsi «di sinistra». Con essa è rimasta, perciò, anche la tendenza a considerare la pace come un valore non assoluto ma subordinato a determinati interessi politici, in funzione dei quali, quindi, essa può, a seconda delle circostanze, essere invocata o rifiutata. E l’interesse politico che attualmente fa pendere la bilancia in favore del rifiuto è quello a rendere il più possibile profondo ed incolmabile il fossato tra la Russia ed il resto dell’Europa, essendo la prima attualmente vista come il principale ostacolo alla piena ed incontrastata affermazione non solo degli assetti di potere economico-finanziari che dominano in tutto l’Occidente, senza più alcuna sostanziale distinzione tra destra e sinistra, ma anche degli pseudo «valori» che, in quei medesimi assetti, trovano il loro più forte e sicuro sostegno: omosessualismo, transgenderismo, femminismo d’assalto, diritto incondizionato all’aborto, diritto al suicidio assistito, diritto allo «sballo» con ogni tipo di droga, abolizione dei vincoli familiari, ambientalismo anti umano, immigrazionismo indiscriminato. Il fatto che la Russia sia un paese a scarso livello di democrazia è, sotto questo profilo, del tutto indifferente. Opponendosi a quei «valori» essa sarebbe, infatti, da considerare «nemica» anche se le normali libertà democratiche vi fossero pienamente garantite, così come, per analoghe ragioni, è considerata una nemica da combattere, sia pure, ovviamente, con mezzi diversi dalle armi quali, in particolare, i ricatti economici , l’Ungheria governata da Viktor Orban, nonostante che nessuno possa seriamente sostenere che vi sia, in essa, un deficit di libertà democratiche. Pacifismo e bellicismo altro non sono, dunque, nelle sinistre, se non due facce della stessa medaglia. Ma la medaglia, in sé, comunque la si giri, è del tutto priva di valore.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione