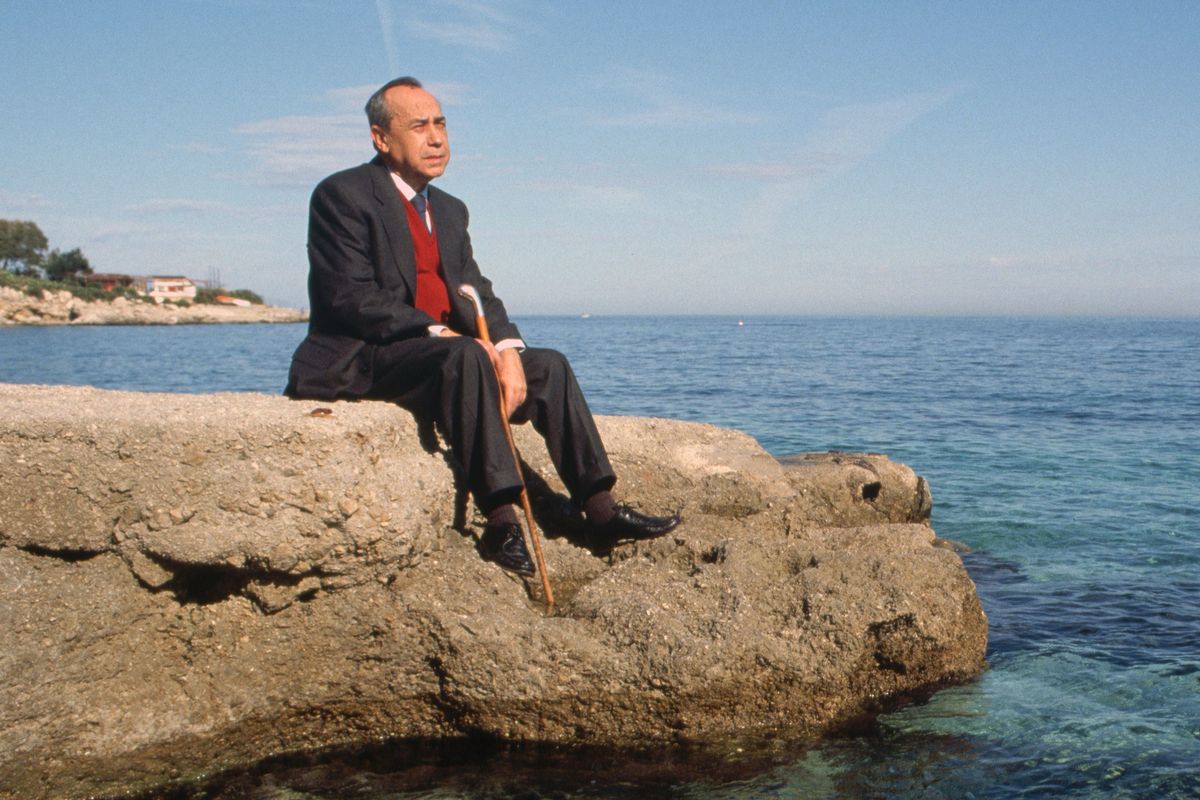
«Il tirocinio di chi lavorerà con la libertà delle persone dovrebbe includere tre giorni di permanenza in una struttura detentiva. Solo tre giorni di vita da detenuto. Dopo sarebbe meno probabile un uso disattento - a volte capita ancora, pur essendo la nostra magistratura molto sensibile alla cultura dei diritti - delle misure cautelari». Proposta presentata da Gianrico Carofiglio in un’intervista alla Stampa del dicembre 2022 come «una provocazione». Non originale, in verità. In quanto ricalcante quella formulata 40 anni prima, in modo meno involuto, da Leonardo Sciascia, di cui ricorre oggi il 35esimo anniversario della morte (Palermo, 20 novembre 1989).
Corriere della sera, 7 agosto 1983. Il romanziere-saggista di Racalmuto si occupa del calvario giudiziario di Enzo Tortora, che conosce dagli anni Cinquanta, arrestato - con telecamere al seguito - il 17 giugno 1983 perché accusato di affiliazione alla camorra, spacciatore di droga e consumatore in proprio. Con una stoccata obliqua a Enzo Biagi, che su Repubblica del 24 giugno 1983 si era domandato: «E se Tortora fosse innocente?», Sciascia dichiara: «Io non me lo chiedo. Sono certo che lo è». Per poi continuare: «Ogni cittadino, che faccia un lavoro dipendente o che ne eserciti uno in proprio, sa che di ogni errore deve rendere conto e pagarne il prezzo». Ma per una toga non è così, anzi: «Qualunque errore commesso non sarà remora alla sua carriera, che automaticamente percorrerà fino al vertice». Come uscirne? «Un rimedio, paradossale quanto si vuole, sarebbe quello di far fare ad ogni magistrato, una volta vinto il concorso, almeno tre giorni di carcere tra i detenuti comuni, preferibilmente in carceri famigerate come Ucciardone e Poggioreale. Sarebbe indelebile esperienza, da suscitare acuta riflessione e doloroso rovello ogni volta che si sta per firmare un mandato di cattura o per stilare una sentenza». Come alternativa a quella che lui stesso etichetta come «utopia», si potrebbe prevedere la responsabilità civile dei magistrati: «Cioè dare a ogni cittadino ingiustamente imputato, una volta che viene prosciolto per più o meno assoluta mancanza di indizi, la possibilità di rivalersi su coloro che lo hanno di fatto sequestrato e diffamato, senza possibilità di rivalsa. Il che non appartiene alla civiltà, al diritto, ma alla barbarie e alla giungla». Però. «Sequestrato e diffamato». Un vero e proprio manifesto del garantismo. Che spiega la fama di Sciascia «polemista scomodo», come si usa pigramente definire chi, intellettualmente onesto, non le manda a dire, non facendo sconti neppure alla propria fazione. Del resto, Sciascia amava un aforisma dello scrittore francese George Bernanos: «Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli».
Fatevi un regalo: procuratevi il doppio volume di Todomodo, quattordicesima edizione della rivista internazionale di «studi sciasciani», fondata da Francesco Izzo e curata dall’associazione Amici di Leonardo Sciascia, pubblicata da una piccola quanto raffinata casa editrice di Firenze, la Leo. S. Olschki Editore. Un numero tutto da leggere, in non mancano gli accenti critici nei confronti della... critica, che ha palesemente ignorato il valore dello scrittore. Gianfranco Contini, ad esempio, nella sua antologia per le scuole del 1968, Letteratura dell’Italia unita (1861-1968), semplicemente lo ignora. E Sciascia era già Sciascia, avendo già pubblicato, per dire, Le parrocchie di Regalpetra e A Ciascuno il suo. «L’illustre critico», osserva Marcello D’Alessandra, «non si smentirà, dieci anni dopo, quando darà alle stampe lo Schedario di scrittori italiani moderni e contemporanei: Sciascia non esiste». Rimase ferito nell’orgoglio, Sciascia? Più che altro, considerò la non menzione con fatalistico distacco, intriso di sarcasmo: «Per Contini, grande filologo, grande critico, Luigi Pirandello è uno scrittore da folclore, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa un “romanzo da bancarella”, un piccolo libro... Lucio Piccolo (poeta siciliano, nda) diceva: “Noi siciliani siamo antipatici”».
Invece Sciascia è vivo, e lotta insieme a noi. Ancora oggi. Come studioso disincantato, capace di fotografare la realtà e i protagonisti del suo tempo trasfigurandoli in ambientazioni e maschere senza tempo. Una vitalità cui attinsero grandi autori di cinema, non a caso tutti malati di sana passione civile. Gianni Amelio nel 1990, con il film Porte aperte, interpreti Gian Maria Volonté ed Ennio Fantaschini. Elio Petri nel 1976, con Todo modo, attori principali: Marcello Mastroianni e Volonté. Francesco Rosi nello stesso anno, con Cadaveri eccellenti (unica pellicola ad avere titolo diverso dal romanzo da cui è tratto, Il contesto). Damiano Damiani nel 1968 con Il giorno della civetta, interpreti Franco Nero, Claudia Cardinale e uno strepitoso Lee J. Cobb nei panni del boss mafioso che, come immaginato da Sciascia, divide l’umanità in cinque categorie: «gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà».
Per questa sua conoscenza della Sicilia, dei riti e delle parole mafiose, Sciascia fu sfregiato - in siciliano: mascariato, cioè calunniato - come «oggettivamente mafioso» e «complice dei mafiosi» da «uomini perbene, ma ebbri di indignazione, quali Pino Arlacchi e Leoluca Orlando» (così il siciliano Francesco Merlo nella prefazione all’edizione 2002 del libro), con Giorgio Bocca che nel suo libro Il Provinciale riserva a Sciascia il seguente ritratto: «Non era mafioso ma pensava mafioso, aveva sensibilità mafiosa». E perché? Come mai finì sul banco degli imputati - in quanto «colluso» con Cosa Nostra - l’uomo che aveva messo in guardia (sempre ne Il giorno della civetta, ed era il 1960!) dalla velocità con cui «forse tutta l’Italia va diventando Sicilia», con «la linea della palma», ovvero la mafia, che sta risalendo la penisola, «ed è già oltre Roma»?
Per due articoli sul Corriere della Sera del gennaio 1987, il primo dei quali - il 10 gennaio - fu intitolato I professionisti dell’antimafia (definizione e titolo furono una scelta redazionale, non dello scrittore), dove Sciascia ribadiva - prendendo spunto da un libro sulla mafia al tempo del Duce e del «prefetto di ferro», Cesare Mori - il tema del trasformismo delle classi dirigenti siciliane, un pericolo per i destini della stessa antimafia. Sciascia fece l’esempio di un sindaco - e il riferimento a Orlando è ictu oculi - «che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi della città che amministra, si può considerare in una botte di ferro. Chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia correndo il rischio di essere marchiato come mafioso?». L’antimafia come salvacondotto, o come automatico lasciapassare «per far carriera nella magistratura, del prendere parte a processi di stampo mafioso», e qui il rimando è esplicito: «L’assegnazione del posto di procuratore della Repubblica a Marsala al dottor Paolo Emanuele Borsellino». Chi ha gridato allo scandalo ha deformato i suoi propositi e la stessa sostanza testuale del suo intervento, con vistosi effetti di travisamento dell’analisi filologica della motivazione a base del provvedimento. Ce l’aveva con Borsellino, Sciascia? No. Niente di personale. Era un’avvertenza «culturale». Se si «aggiustano» le regole perché bisogna inginocchiarsi davanti al totem dell’antimafia, ecco che il rischio di trasformarla in «strumento di potere» si fa reale. Come si vide sotto il fascismo: attraverso l’alibi della guerra alla mafia, il regime poteva etichettare ogni dissenso come «mafioso». Punto su cui insisterà Sciascia nel secondo articolo, il 14 gennaio, rispondendo al fuoco alzo zero partito dal Coordinamento antimafia. Il cui comunicato, rileva lo scrittore, «è la dimostrazione esatta che sulla lotta alla mafia va fondandosi un potere che non consente dubbio, dissenso, critica. Proprio come se fossimo all’anno 1927». E su Borsellino: «Non ho messo in discussione la sua competenza: sono le modalità della sua nomina che mi sono apparse e mi appaiono preoccupanti».
Intravedeva la deriva, Sciascia (Borsellino e lo scrittore s’incontrarono, si parlarono e si chiarirono, come succede tra persone perbene). E la storia dei decenni successivi - con i magistrati antimafia passati alla carriera politica, con più di un «paladino» dell’antimafia finito inquisito a sua volta, con quasi trent’anni di processi sulla cosiddetta «trattativa Stato-mafia», smontati dalla Cassazione - gli ha dato ragione. Ma si sa: «Il fatto è che i cretini, e ancor più i fanatici, sono tanti», rileverà sardonicamente nell’introduzione al volume A futura memoria - Se la memoria ha un futuro (1989), «godono di una così buona salute non mentale che permette loro di passare da un fanatismo all’altro con perfetta coerenza, sostanzialmente restando immobili nell’eterno fascismo italico». Amen.






