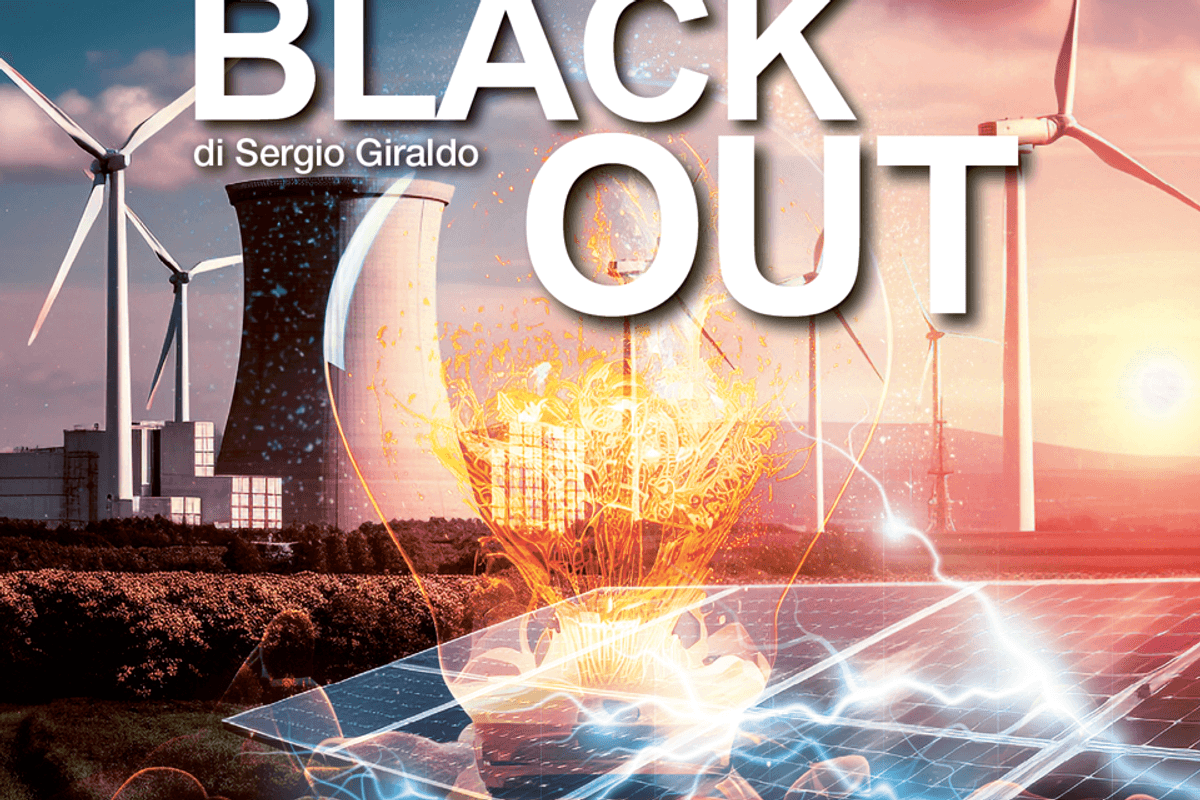Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi.
Ansa
Se avessero coraggio, oggi sarebbero in piazza per Catherine, allontanata dalla prole non da maschi feroci ma da altre donne. Ed è tempo anche di una presa di posizione forte da parte delle gerarchie ecclesiastiche.
Nel mare di retorica che sentiremo oggi in occasione della Festa della donna, sarebbe di conforto udire - tra le tante banalità - anche qualche parola un filo coraggiosa su una fetta di popolazione che è realmente discriminata e i cui diritti sono regolarmente calpestati. Sono le madri a cui lo Stato italiano toglie i figli, talvolta con l’uso della forza bruta talaltra con mezzi più subdoli.
E qui non c’entrano la mascolinità tossica e il patriarcato che vengono costantemente evocati quali mali profondi della nostra società. No, semmai qui c’entra uno Stato che - come tante istituzioni contemporanee - punta a farsi unica, grande madre pretendendo di educare i figli-cittadini in nome di un bene superiore noto a esso soltanto. Si separano madri e figli con la scusa del «superiore interesse del minore», cioè si sostiene che sia meglio per un bambino uniformarsi alle indicazioni di esperti di varia natura, della società di medicina e psicologia e delle organizzazioni internazionali piuttosto che essere amato ed educato dai suoi genitori, per quanto imperfetti possano essere.
Se avessero un poco di coraggio, oggi tutte le femministe del reame dovrebbero scendere in piazza a sostegno di Catherine Trevallion, simbolo di tutte queste madri separate a forza dalla loro prole. È una donna forte e tenace, con convinzioni robuste e il Tribunale dei minori dell’Aquila la punisce per questo. L’intera ordinanza che venerdì ha disposto il suo allontanamento dalla casa protetta di Vasto in cui da novembre è rimasta assieme ai suoi tre figli è un gigantesco atto di accusa contro di lei. Le rimproverano di essere rigida, di non aver obbedito alle indicazioni dei responsabili della struttura, di avere risposto male alle assistenti sociali. Le rinfacciano di voler vedere i suoi figli e di non volersi piegare dinnanzi alle istituzioni che - a differenza di lei - saprebbero che cosa è meglio per i suoi bambini. Sembra anche che cerchino di mettere suo marito contro di lei, e infatti ieri alcuni quotidiani insistevano sulla differenza di approccio fra Catherine e Nathan e addirittura parlavano di screzi nella coppia. Dopo aver separato genitori e figli, ora tentano di dividere mamma e papà.
Di fronte a questo scempio, dove sono tutte le eroiche paladine dell’indipendenza e della libertà? Dove sono le attiviste che si offendono se un uomo «spiega loro le cose» (è il temibile mansplaining) o se dimostra troppa affettata cavalleria? Tacciono, ovviamente. E, di nuovo, non sono maschi feroci a imporre tutto ciò a una donna coriacea: sono altre donne, giudici e assistenti sociali, curatrici e tutrici.
Se qualcuna parla, fra le varie attiviste e politiche che hanno fatto dell’orgoglio femminile una bandiera, è per lo più per rintracciare a Giorgia Meloni di occuparsi della famiglia nel bosco invece che di chissà che altro, come se questo caso e, più in generale, la giustizia minorile non fossero argomenti pregnanti. La verità è che a queste vestali della correttezza politica interessa un solo tipo di donna: quella che combatte il maschio e lotta a favore dell’aborto, e che magari rifiuta la maternità per principio. Catherine Trevallion è, invece, una donna d’un altro tempo, attaccata alla sua spiritualità e alla sua terra, capace di rinunciare alle lusinghe della modernità per curare la sua famiglia in un ambiente più sano. Scelte che, per la massa, sono sostanzialmente incomprensibili. Chissà, forse se si battesse contro il riscaldamento globale e la tirannia patriarcale può darsi che la sosterrebbero di più. Invece la abbandonano al suo destino.
A manifestare a favore della famiglia nel bosco davanti alla casa protetta di Vasto ieri c’erano donne di destra, persone comuni. Italiane e italiani indignati come i tantissimi che in questi giorni hanno commentato i nostri video e i nostri articoli. Non c’erano le sfegatate di Non una di meno e simili: quelle hanno altre meno nobili cause di cui occuparsi.
A dire il vero, la loro assenza non è l’unica che si nota. Si sente anche, e tanto, la mancanza di una presa di posizione forte da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Basterebbe notare che la casa di accoglienza che ha ospitato la madre e i bambini e i cui operatori hanno, poi, insistito per allontanarli è legata alla diocesi. L’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto è Bruno Forte, un intellettuale e una figura molto autorevole. Diverse settimane fa aveva espresso qualche pacato invito alla riflessione, aveva ricordato che le istituzioni hanno il compito di proteggere le famiglie e di non vessarle. Ebbene, sarebbe opportuno e molto utile che il monsignore ora prendesse posizione con toni decisi. La casa protetta e i suoi operatori non hanno difeso la famiglia, anzi sono andati allo scontro con Catherine, hanno inviato al tribunale le loro rimostranze, in parte francamente molto discutibili.
Oggi saranno in tanti a celebrare le donne, ma coloro che dovrebbero difendere la donna e la famiglia su questa vicenda appaiono piuttosto timidi. Cercano scappatoie, non vogliono inimicarsi le istituzioni, contribuiscono alla mostrificazione di Catherine. Ma basta leggere le carte e ripercorrere con un filo di onestà intellettuale tutto il percorso della famiglia nel bosco per comprendere che nel torto, qui, sono le istituzioni italiane. Ma manifestare contro il patriarcato, purtroppo, è più facile e richiede meno coraggio che manifestare contro un tribunale che distrugge una madre e una famiglia.
Continua a leggereRiduci
iStock
Il 22 e 23 marzo gli italiani non decideranno solo se mantenere in vita oppure no la riforma Nordio. E nemmeno voteranno per mostrare o meno il gradimento verso il governo Meloni. No, il referendum servirà soprattutto a stabilire se l’Italia è ancora una repubblica democratica oppure se si avvia a diventare una repubblica giudiziaria. Boom. Lo so che qualcuno penserà che io l’abbia sparata grossa. Tuttavia, penso che la mia non sia un’esagerazione e vi spiego perché. Mai si era vista, neppure ai tempi di «Resistere, resistere, resistere», slogan coniato dal procuratore generale di Milano, Francesco Saverio Borrelli, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel 2002, una tale mobilitazione del partito dei giudici. Mai avevo avuto la percezione così netta di un ordine dello Stato che si oppone a una riforma dello Stato. Il partito della magistratura, che per giunta non rappresenta tutta la magistratura ma soltanto la sua parte più estrema e radicale, si è messo alla testa di un movimento politico, radunando attorno a sé politici e professionisti, tra i quali una parte dell’avvocatura. Non sono il Pd o i 5 stelle a guidare l’opposizione alla riforma e al governo: è l’Anm, il sindacato delle toghe.
Nel passato, molte volte l’associazione nazionale si è opposta alle leggi discusse dal Parlamento e quasi sempre è riuscita a impedirne l’approvazione. Ma questa volta è diverso. Qui non siamo alle dichiarazioni dell’organizzazione di categoria e nemmeno alle singole interviste o dichiarazioni di questo o quel magistrato. Siamo arrivati a una vera e propria campagna referendaria, dove l’Anm si è trasformata in soggetto politico, scegliendo con cura gli slogan, investendo centinaia di migliaia di euro in comunicazione su autobus e nelle stazioni. Nemmeno ai tempi del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati assistemmo a una simile discesa in campo. Che, ribadisco, non è guidata dall’opposizione all’attuale maggioranza, cosa peraltro legittima, ma da giudici e pm, i quali non si fanno scrupolo di usare la menzogna, dicendo agli italiani che la riforma abolirà l’indipendenza della magistratura, mettendola agli ordini della politica. Pd e 5 stelle, ovvero i principali partiti dell’opposizione, non hanno guidato nemmeno per un istante il fronte che contrasta la riforma Nordio, ma ne sono stati succubi.
Per di più, a poche settimane dal voto, si sono intensificate le sentenze che paiono proprio voler contrastare politicamente la linea del governo in carica. Ricercati per assassinio, spacciatori, stupratori e pedofili in procinto di essere espulsi vengono rimessi in libertà, quasi che dai tribunali sia in atto un boicottaggio nei confronti dell’esecutivo, per alimentare ulteriormente lo scontro fra magistratura e governo, per di più su un tema sensibile come quello della sicurezza.
Dunque, il voto del 22 e 23 marzo non riguarderà solo il merito, ovvero la separazione delle carriere, i due Csm, l’Alta corte disciplinare e il sorteggio dei membri che ne dovranno fare parte. E nemmeno si tratterà di decidere se dare una spallata o meno a Giorgia Meloni. La vera scelta sarà tra una repubblica democratica, dove l’articolo uno della Costituzione è rispettato nella sua parte in cui recita che il popolo è sovrano, oppure una repubblica giudiziaria, dove ogni cosa, ogni decisione politica, ogni governo, è soggetto all’impostazione politica espressa dalla magistratura. Non è un mistero che ci fu un tempo, tra il 1992 e il 1994, in cui giudici e pm pensarono di sostituirsi ai partiti e di guidare il Paese. All’epoca, fior di magistrati dissero di essere pronti ad accettare alti incarichi istituzionali nel caso in cui fosse giunta la chiamata del presidente della Repubblica. Beh, ho la sensazione che quel tempo sia tornato e che, se vincesse il No, assisteremmo a un protagonismo giudiziario ancor più pressante. E i primi a doversi preoccupare dovrebbero essere gli esponenti dell’opposizione, perché l’Anm, da nuovo soggetto politico presenterà loro il conto. Nel caso di vittoria del No, sarà infatti una vittoria del partito delle toghe, che da li in poi si sentirà legittimato da un voto popolare.
Continua a leggereRiduci
L’1 e 2 giugno torna «Cantare amantis est». Jazz di lusso con Bollani, Rava e Metheny.
C’è un filo che parte da San Francesco e arriva a Giotto. E ce n’è un altro, più lungo, che dagli affreschi dedicati al Poverello d’Assisi nella Basilica di Santa Croce a Firenze raggiunge un protagonista della musica del Novecento come Paul Hindemith, il compositore tedesco che generò Nobilissima visione, «leggenda danzata» in sei quadri ispirata proprio da quella meraviglia. Ma ne esistono molti altri, infiniti. E forse non sono fili, ma raggi di luce. A suggerirlo è il genio di Dante, al quale bastano cinque parole, nell’undicesimo Canto del Paradiso, per descrivere l’impatto dell’alter Christus nella storia: «Nacque al mondo un sole». Da questo verso potentissimo riparte il Ravenna Festival, giunto alla sua trentasettesima edizione, che si aprirà il 21 maggio con il concerto di Anne-Sophie Mutter e della Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vasily Petrenko, proseguendo fino all’11 luglio con il coinvolgimento di oltre 1.000 artisti.
Per celebrare il patrono d’Italia, a 800 anni dalla morte, il Maestro Riccardo Muti dirigerà la sua amata Orchestra giovanile Luigi Cherubini proprio nella suite orchestrale di Hindemith (7 giugno), prima di dialogare con il filosofo Massimo Cacciari sull’influenza del padre del Cantico delle creature nell’opera di Dante Alighieri e Giotto (Muti e la Cherubini torneranno il 30 giugno al Palazzo De André con Verdi, Ravel e De Falla, mentre i professori d’orchestra il 14 giugno seguiranno la bacchetta di Kent Nagano). Pochi giorni prima, 1 e 2 giugno, il leggendario direttore replicherà quello che su queste colonne aveva definito «l’esperimento più bello della mia vita»: formare un unico immenso coro aprendo le porte a singoli cantanti e a piccole e grandi formazioni, di amatori o professionisti, provenienti da tutte le regioni d’Italia (l’anno scorso avevano risposto all’appello 3.116 voci, dai 4 agli 87 anni). Un viaggio nella coralità intitolato Cantare amantis est - «cantare è proprio di chi ama», come diceva Sant’Agostino - che prende la forma di una masterclass, libera e gratuita, su quattro capolavori: Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, Casta Diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, un estratto dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi e il Prologo dal Mefistofele di Arrigo Boito. Da non perdere anche l’ultimo appuntamento della rassegna con il Maestro Muti, il 2 luglio, con il progetto The Philharmonic Brass.
Nel vastissimo cartellone del festival, Francesco risuona ancora (dalla lauda italiana a Sora nostra morte corporale nel nome di Bach, fino a Francesco e il lupo) e rivive nel teatro (Il Santo folle, Lu santo Jullare Francesco), senza tralasciare l’inquadramento storico di Franco Cardini.
Da segnare in agenda per gli appassionati di jazz alcuni appuntamenti di lusso, a cominciare dalla Stefano Bollani All stars del 6 giugno (con Enrico Rava, Paolo Fresu - che torna il 2 luglio per un omaggio a Grazia Deledda insieme a Mariangela Gualtieri -, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni). Un concerto preceduto dalla proiezione (la prima in Italia) del film di Valentina Cenni, Tutta vita (a questo link un’anticipazione del gigante della tromba Enrico Rava, ospite del podcast Non sparate sul pianista: bit.ly/40OUNzM). Il 3 luglio arriva con Side-Eye III+ un monumento della chitarra come Pat Metheny, mentre il 9 il giovane virtuoso palermitano dell’elettrica Matteo Mancuso, in trio, dividerà il palco con Nik West (due date in collaborazione con Ravenna Jazz).
Dopo l’estate si ricomincia con la consueta Trilogia d’Autunno (13-17 novembre) nel segno di Mozart (La clemenza di Tito, Il flauto magico, Requiem), con la regia di Chiara Muti e l’Orchestra Cherubini guidata da Ottavio Dantone.
Continua a leggereRiduci