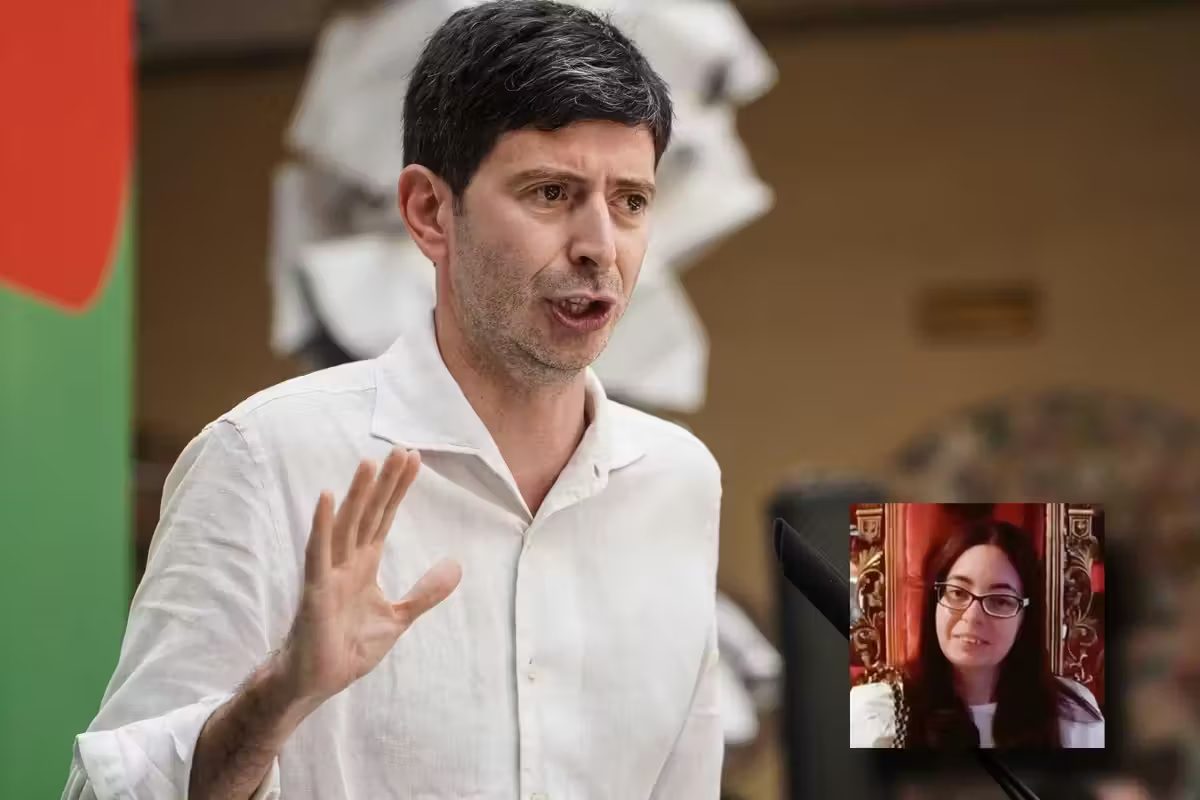Fra pochi giorni si celebrerà la fondazione di un partito che non c’è più ormai da trent’anni: il Pci. Il Partito comunista, infatti, nato a Livorno il 21 gennaio 1921 dalla scissione del Psi è morto, dopo il crollo del Muro di Berlino, esattamente il 3 febbraio 1991, nell’ultimo congresso del Pci (Rimini). Eppure, le trombe per celebrare un partito fantasma si sentono da mesi. Al punto che sono stati destinati nella finanziaria 2019 i fondi per le celebrazioni dell’«anniversario di interesse nazionale» al pari dell’Unità d’ Italia. Senza contare i contributi economici delle regioni rosse.
La domanda però che tutti ci poniamo è questa: siamo sicuri che i comunisti non esistano più? Sono scomparsi con il funerale al vecchio Pci di Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer, Achille Occhetto e dei due litigiosi gemelli Massimo D’Alema e Walter Veltroni? Sono stati cancellati dalle nuove formazioni (prima del Pds, poi Ds e infine del Pd, con la confluenza dell’ex corrente di sinistra dc, che aveva costituito la Margherita di Francesco Rutelli)? Sono spariti anche con il de profundis al partito di Armando Cossutta, dirigente comunista da sempre fedelissimo del Cremlino? Se fosse stato così perché tutto questo fervore per un anniversario che forse poteva interessare solo a qualche storico? C’è anche da aggiungere che un Partito comunista (con la sigla storica di Pci) esiste ancora: è quello della piccola ma attivissima formazione di Marco Rizzo. Ma, in realtà, a sopravvivere sul serio non sono solo i piccoli partiti e i gruppi di militanti marxisti leninisti (compresi quelli che si annidano nei centri sociali), ma tutti gli altri, cioè quelli che operano alla luce del sole con altre etichette politiche o addirittura senza mascherine con indicazioni di partito.
Del resto, vi ricordate il clamoroso caso di Walter Veltroni, discepolo di Enrico Berlinguer, braccio destro di Achille Occhetto, da sempre dirigente, prima della Fgci, poi del Pci, che si è sempre pavoneggiato - suscitando l’ilarità generale - con la dichiarazione di «non essere mai stato comunista» perché lui si è sempre definito kennediano. Purtroppo per noi, l’Italia è affollata di persone come Veltroni: nei partiti della sinistra (mi riferisco soprattutto al Pd e a Leu), nei giornali, nelle case editrici, alla Rai (ma anche nelle altre reti tv), negli organismi direttivi dei sindacati, nel mondo della cooperazione, negli enti locali, nelle Regioni, ovunque. Il mondo della cultura ha ereditato quella cultura comunista (che si è unita a quella cattolica integralista), riducendo sempre di più gli spazi per la cultura liberale, laica, riformista, radicale. In altre parole, ancora oggi - dopo tre decenni dalla fine del Pci - continua a permanere quella cultura, sedimentata per decenni, fatta di dogmi, di conformismo, di disciplina di partito, di linea ideologica «indiscussa», che rasenta il fanatismo e il settarismo ed esclude ogni forma di dissenso, di libertà di pensiero.
A questo punto, ricordiamo le origini del Pci, al teatro San Marco di Livorno. La scissione dal Psi avvenne sui famosi «21 punti di Lenin» che delimitavano le posizioni dei rivoluzionari (i comunisti), dai riformisti (i socialisti). Gli anarchici erano stati preventivamente allontanati bruscamente dal congresso socialista del teatro Goldoni. I comunisti erano appena un quarto degli iscritti al Partito socialista (58.783 su 216.337) e avevano già deciso tutto (Statuto del nuovo partito, organi di direzione, ecc.). Facevano capo ad Amadeo Bordiga (che guidò all’inizio il nuovo partito, poi venne espulso), il gruppo dell’0rdine Nuovo di Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e Angelo Tasca. E ancora i massimalisti di Anselmo Marabini, Antonio Graziadei e Nicola Bombacci (quest’ultimo divenne poi un dirigente fascista e fu fucilato dai partigiani) e la maggioranza della Fgsi (la federazione dei giovani socialisti). Che cosa si proponeva quel partito appena nato? Ecco un breve stralcio dal programma politico: «Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento, senza l’abbattimento violento del potere borghese… Dopo l’abbattimento del potere borghese, il proletariato non può organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell’apparato sociale borghese e con la instaurazione della propria dittatura…». Quante volte abbiamo ritrovato queste frasi degli emuli di Lenin sui documenti delle Brigate rosse, di Prima linea, negli anni di piombo o nei manifesti della galassia di gruppi estremisti, interni ed esterni al Pci?
Nel corso dei 70 anni il Pci fu leninista, stalinista, kruscioviano e infine gorbacioviano. Prima Togliatti e poi Berlinguer sventolarono ambiguamente la bandiera della «via italiana al socialismo», poi diventata anche «compromesso storico», per raggiungere comunque l’obiettivo della conquista del potere. Per questo traguardo, benedetto del resto anche da Iosif Stalin, i dirigenti delle Botteghe Oscure non consentirono deviazioni di percorsi e opinioni diverse da quelle ufficiali. Chi non si allineava veniva drasticamente messo ai margini, espulso dal partito e indicato al disprezzo dei militanti. È successo in passato anche ad Amadeo Bordiga, Angelo Tasca, Pietro Tresso, Alfonso Leonetti, Paolo Ravazzoli. E poi allo scrittore Ignazio Silone (conosciuto in tutto il mondo per le sue opere e candidato per dieci volte al Premio Nobel) e negli anni più recenti ad Antonio Giolitti, al gruppo del Manifesto (Rossana Rossanda, Aldo Natoli, Luigi Pintor, Lucio Magri, Luciana Castellina, Valentino Parlato e Lidia Menapace) e a tanti altri intellettuali e politici.
Il Pci fu comunque sempre allineato, fra molte contraddizioni, con Mosca, a parte qualche oscillazione berlingueriana («Sono più tranquillo con l’ombrello della Nato, piuttosto che con quello del patto di Varsavia»), anche durante la rivolta ungherese del 1956 e l’occupazione militare sovietica e la «primavera di Praga» del 1968, repressa dagli eserciti del patto di Varsavia. Botteghe Oscure, sede del Pci, reagì sempre con le espulsioni di chi protestava, difendendo ad oltranza le «ragioni» del Cremlino, anche perché aveva molto peso allora il ricatto delle sovvenzioni, che arrivavano in vari modi da Mosca. Nell’immediato dopoguerra i contributi al partito si raccoglievano anche in Italia, attraverso le tangenti che il Pci percepiva dalle aziende per l’export di prodotti italiani in Urss e negli altri Paesi dell’est.
Esiste una letteratura - con testimonianze e documenti molto attendibili - molto ampia in proposito. Il libro però più documentato e accurato è sicuramente quello di Valerio Riva, Oro da Mosca (Mondadori) di ben 882 pagine. Con l’aiuto di Francesco Bigazzi, un giornalista che lavorava a Mosca come corrispondente, era stato setacciato l’intero archivio sovietico (quando era ancora accessibile). Quel libro rappresenta quindi una miniera di notizie. Il fiume di denaro che da Mosca raggiungeva i «partiti comunisti fratelli», dal 1950 al 1990, raggiungeva i 4.000 miliardi di lire. Un quarto di questa gigantesca somma (esattamente 889 miliardi) arrivava nelle casse del Pci, in varie forme. Questa cifra, all’epoca di Nikita Krusciov (nel 1958), raggiunse addirittura il 70 per cento del totale. Questo «Fondo di assistenza internazionale» fu creato nel 1950 da Stalin e amministrato da Boris Nikolaevic Ponomariov, un uomo di grande potere nella nomenklatura sovietica. Pian piano, negli anni Ottanta i finanziamenti si vanno estinguendo. È sempre Armando Cossutta a riscuotere i sostanziosi bonus a favore del quotidiano Paese sera (diventato sempre più filosovietico) e il periodico Orizzonti. Ma nel 1986 il diplomatico Anatolij Dobrynin comunica a Cossutta che «la festa era finita» e cioè che il Pci doveva provvedere da solo al suo finanziamento. E questo si spiegava anche con le spinte autonomistiche, sempre più marcate, di Berlinguer.
Il centenario del Pci ci fa ricordare altri due punti roventi, che non hanno trovato spazio nei molti saggi in libreria di storici e giornalisti o perlomeno che sono stati appena sfiorati. Le ricordiamo brevemente. Il primo riguarda la lotta partigiana, che ha visto la partecipazione attiva dei militanti comunisti. E questo nessuno lo ha mai messo in discussione. Andrebbe però ridimensionato l’apporto dei partigiani in generale alla resistenza e soprattutto appare sovradimensionato il contributo dei partigiani comunisti. Non bisogna infatti minimizzare strumentalmente, come fanno gli storici di sinistra, il contribuito dei cattolici, dei socialisti e del partito d’azione (le brigate cattoliche, le Matteotti, quelle di Giustizia e libertà, quelle azzurre). Un rilievo particolare lo hanno avuto sicuramente gli ex militari (soldati e ufficiali dell’esercito), fuggiti in montagna per combattere contro i repubblichini. In questo scenario non vanno sottovalutate le deviazioni criminali delle bande Garibaldi, durante e subito dopo la fine della guerra: migliaia di assassini politici di gente inerme (fascisti, ma anche civili, compresi preti, suore, donne e bambini). Si è trattato di «vendette di classe»: sono stati uccisi il possidente, il sindaco del paese, il farmacista, l’agrario, ecc. Questi delitti sono avvenuti nel «triangolo della morte» in Emilia Romagna, ma anche in Toscana, in Lombardia, Piemonte e Liguria, come confermano i libri di Giampaolo Pansa, di Arrigo Petacco e di altri autori. Il numero delle vittime è imprecisato. Quello più attendibile si riferisce ad almeno 30.000. Gli assassini emigrarono nei Paesi dell’est, soprattutto in Cecoslovacchia e in Polonia. Di recente ho scoperto che un folto gruppo è emigrato anche a Cuba. Quasi tutti però rientrarono con l’amnistia di Palmiro Togliatti, che voleva soprattutto tutelare Francesco Moranino, poi diventato anche senatore, che si era macchiato di orrendi delitti.
Solo in chiusura vorremmo ricordare i genocidi e le persecuzioni che ricordano la Shoah. Anzi in molti casi superano gli orrori dei lager nazisti. Il riferimento è ai crimini del comunismo nel mondo. Ora comincia ad esserci una letteratura considerevole in proposito, ma se ne parla poco, per quel clima di conformismo e forse di rimozione dei crimini sempre vivo anche nel nostro Paese. Stiamo parlando, secondo Il Libro nero del comunismo di Stephane Courtois (Mondadori, edizione aggiornata), di 100 milioni di vittime (di cui 20 milioni solo nell’ex Urss, 65 milioni in Cina, 2 milioni in Corea del Nord,2 milioni in Cambogia, un milione nell’Europa dell’est, ecc.). Di questa tragedia il Pci e i comunisti italiani, anche dopo il crollo del Muro di Berlino, non hanno mai parlato. Anzi sono sempre pronti a smentire le cifre e a giustificare le scelte criminali di Mosca.
Una celebrazione che gronda lacrime e sangue, dunque, anche se il governo giallorosso la finanzia e benché il parlamento europeo di Strasburgo abbia approvato a grande maggioranza una mozione che equipara il nazismo al comunismo, condannando duramente entrambe le ideologie.