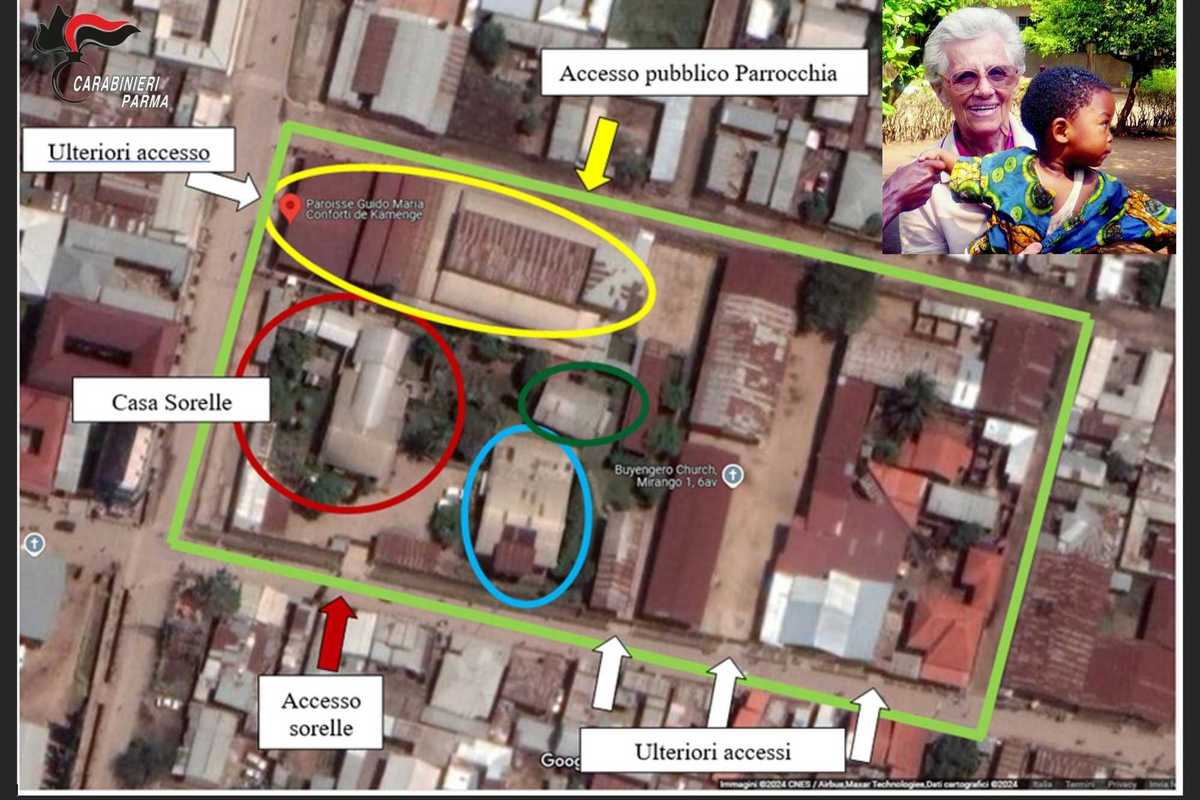Né con gli inquinatori né coi fan di Greta. Serve un’ecologia che parli ai popoli

Sembrano ormai lontanissimi i tempi delle enormi manifestazioni scaturite, a partire dal novembre 2018, da due dei più rilevanti fenomeni di protesta degli ultimi anni: il movimento Fridays for Future e i gilets jaunes. A scavare un solco con quel recente passato ha contribuito ovviamente l’irrompere della pandemia da Covid-19, con i suoi effetti sia sulle mobilitazioni di piazza sia sulle priorità politiche. Ma non solo: entrambi i movimenti sembrano essere arrivati all’esaurimento, anche se non è escluso che in futuro possano riattivarsi a fronte di stimoli analoghi a quelli che ne hanno sancito il successo.
Emblematico è il parallelo - anche temporale - tra due proteste che è difficile immaginare più diverse. Quella intrapresa da Greta Thunberg di fronte al Parlamento svedese, dal mese di agosto in poi, diventa un fenomeno di massa in novembre, con i primi scioperi studenteschi. Nello stesso mese, precisamente il giorno 17, incomincia la mobilitazione in Francia con i blocchi stradali e la prima vittima, una manifestante sessantatreenne investita da un’auto in Savoia (mentre a dicembre si conteranno ben dodici morti in Francia e altri tre in Belgio, con più di 1.800 feriti e 4.570 arresti).
Tanto gli obiettivi quanto i profili sociali dei partecipanti divergevano radicalmente. Una circostanza che ha portato i media a inquadrare fin da subito i due fenomeni secondo frame opposti: da un lato, la speranza dei giovani risvegliati, la piazza colorata e festante benedetta dal coro unanime della stampa e delle istituzioni; dall’altro, la rabbia degli sconfitti della globalizzazione, il fumo di auto e negozi in fiamme innalzato in una coltre di sdegno. I «domani che cantano» contrapposti agli ieri aggrappati a certezze troppo vecchie. Si è trattato dell’ulteriore atto di una polarizzazione che ormai investe qualsiasi ambito del politico, opponendo due fazioni quanto mai disomogenee al loro interno ma ab- bastanza riconoscibili negli assetti generali. Possiamo chiamarli «populisti» o «elitisti», «sovranisti» o «liberal», ma la sostanza non cambia. Nel gioco delle appropriazioni identitarie, l’ambientalismo passa ormai per essere uno dei cavalli di battaglia dei progressisti illuminati contro i «deplorevoli» di clintoniana memoria.
In Francia il filosofo Jean-Claude Michéa, socialista libertario e apologeta della rivolta in gilet jaune, ha coniato un’etichetta per definire un certo tipo di retorica ambientalista svincolata da considerazioni ulteriori sui sacrifici richiesti alle classi medie nel bilanciamento tra ecologia ed economia. È la gauche kérosène, cioè l’élite che vive nelle Ztl urbane tra viali alberati e lunghe piste ciclabili e si sposta soltanto in aereo, senza tuttavia rinunciare a puntare il dito contro i catorci inquinanti dei plebei, rei di non volersi convertire alla mobilità sostenibile per mancanza sia di mezzi finanziari sia di alternative trasportistiche.
Sebbene la protesta dei «gilet gialli» non sia davvero riconducibile a un unico fattore coagulante, è degno di menzione il fatto che a dar fuoco alle polveri fosse stato il rincaro dei carburanti (+14% sul gasolio e +7% sulla benzina) deciso dal governo Philippe come misura anti-inquinamento, insieme a una stretta sulle revisioni suscettibile di falcidiare metà del parco auto francese. […]
È lecito, da destra o da sinistra, contestare l’ipocrisia, l’inefficacia e l’iniquità di fondo di certo mainstream con una poco convincente verniciatura verde. Ma chi se ne occupa dovrebbe semmai porsi il problema di come declinare la riflessione in modo da assicurare al cittadino comune che il costo della transizione non peserà tutto intero sulle sue spalle e verrà invece saldato, in proporzione, anche dai grandi inquinatori.
A maggior ragione se consideriamo i risvolti «identitari» del problema, ossia le conseguenze dirette che la scomparsa di colture alimentari, la deforestazione o l’esaurimento delle risorse del terreno e delle falde acquifere produrranno in misura sempre più determinante sulle ondate migratorie.
Non è tuttavia ciò che vediamo accadere nel dibattito pubblico e sui social. Vale la pena citare, a tale riguardo, ancora de Benoist:
«Il dramma è che le persone di destra spesso pensano che a preoccuparsi del destino del pianeta sia il “mondialismo” (sì, l’inquinamento non si ferma ai confini!). Dato che amano contestare discorsi ufficiali, contestano persino quando ci sono le prove. Gli scettici climatici sono, a questo proposito, i migliori alleati delle multinazionali che distruggono la Terra. Confondono il tempo e il clima e credono che non valga la pena preoccuparsi del cambiamento climatico poiché “è naturale” (come tornado e terremoti!). Mi fanno pensare ai surrealisti, che sostenevano, in nome del “non conformismo”, che due più due potesse fare qualsiasi cosa, ma non quattro».
In ballo comunque non c’è solo la questione di quel che Timothy Morton ha definito l’«iperoggetto» riscaldamento globale, ma anche i riscontri innumerevoli e incontrovertibili che abbiamo a disposizione ormai da decenni sul deterioramento della fertilità dei suoli, l’inquinamento di aria e acqua, la progressiva scarsità di risorse idriche in molte aree del mondo, il crollo della fertilità in altre e la scomparsa accelerata di molte specie animali e vegetali nell’ambito della sesta estinzione di massa.
Per rispondere a tutto questo, anche in relazione ad altre problematiche di primo piano come l’immigrazione, serve un ambientalismo che ritrovi sintonia di lessico e concetti con le preoccupazioni della gente comune. Un ambientalismo del 99%, «populista», o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare. Che riscopra gli aspetti rivendicativi del pensiero ecologista e sappia indossare all’occorrenza il gilet giallo della protesta.