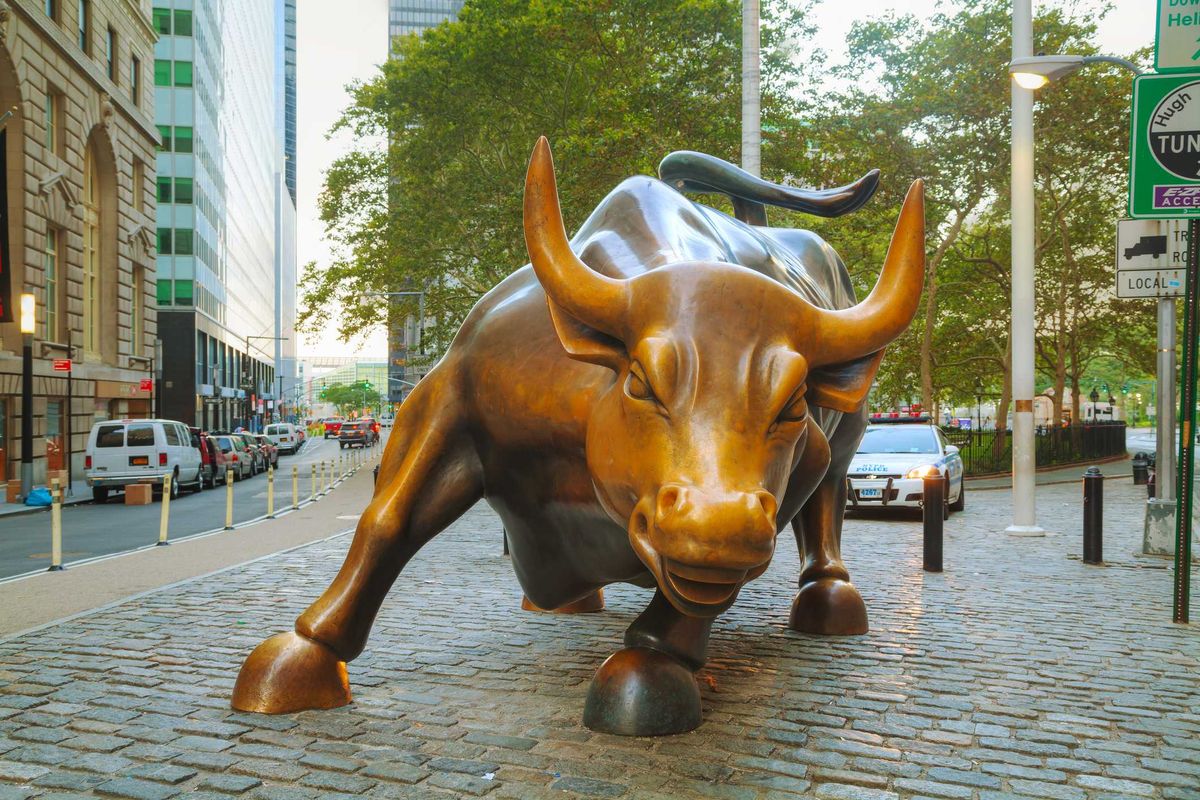2018-06-21
Un gioco al massacro chiamato meritocrazia
Tutti la invocano, ma pochi hanno davvero capito di che cosa si tratti. Non è un modo per premiare i più bravi o i più dotati, ma uno strumento di potere che misura individui (e pure Stati) in base alle performance. E a standard decisi da chi comanda.Quante volte lo abbiamo sentito ripetere? «In Italia serve più meritocrazia!», hanno gridato, per anni, politici di ogni colore. Sembrava che tutti i mali del nostro Paese derivassero dalla carenza di meritocrazia. Giusto ieri, Vanity Fair ha pubblicato un'intervista alla giornalista Maria Cristina Origlia, «vice presidente del Forum della Meritocrazia». La sua associazione non profit, un paio d'anni fa, ha creato il Meritometro, ovvero «uno strumento quanto più oggettivo possibile per misurare il grado di meritocrazia in Italia e non solo». «I risultati del Meritometro», spiega la Origlia, «mostrano con estrema chiarezza un deficit dell'Italia su tutti i fattori presi in considerazione dall'indicatore, segnalando una sostanziale stagnazione da cui non riusciamo a muoverci dal 2014 ad oggi». Le dichiarazioni della giornalista riassumono perfettamente l'ideologia meritocratica. «Misurare è sempre il punto di partenza migliore», dice la signora. «Non si può cambiare una situazione se non se ne conoscono i numeri e il peso rispetto ad altre realtà confrontabili». Ecco il punto: misurare, valutare, classificare. È l'ossessione del nostro tempo. Tutto deve essere valutato, affinché se ne possano misurare le performance. «Che sia a scuola, nelle aziende o nella pubblica amministrazione», ha scritto il pedagogista Francesco Codello, «la valutazione si presenta oggi come una retorica dell'oggettività, come una modalità incontestabile che intende rapportare ogni cosa al suo valore e, pertanto, al suo costo. Ma di fatto questi sistemi si propongono di misurare ciò che non è misurabile, cioè di dare un valore quantitativo a una qualità». La critica alla meritocrazia non è certo recente. Si può dire che l'abbia creata, nel 1958, lo studioso Michael Young, autore di un romanzo distopico intitolato L'avvento della meritocrazia, da poco ripubblicato e dalle Edizioni di Comunità. Come ha scritto il filosofo Roberto Esposito, al «paradiso meritocratico» immaginato da Young si arrivava per gradi: «Prima costruendo una scuola iperselettiva, contro la “fede cieca nell'educabilità della maggioranza"; poi subordinando il sapere di tipo umanistico a quello tecnico scientifico; infine sostituendo i più giovani agli anziani, meno pronti a imparare e dunque retrocessi a funzioni sempre più umili. Il risultato complessivo è la sostituzione dell'efficienza alla giustizia e la riduzione della democrazia ad un liberalismo autoritario volto alla realizzazione dell'utile per i ceti più abbienti». È proprio ciò che è accaduto in Occidente negli ultimi decenni. Dietro la bellissima parola «merito», infatti, si nasconde un triste gioco di potere. I criteri in base ai quali si stabilisce chi sia meritevole e chi no sono, sostanzialmente, decisi da chi detiene il comando. La partita, insomma, è truccata: il più meritevole è colui che più si conforma alla logica dominante. È lo studente che eccelle nei test a crocette, il lavoratore più disponibile e via dicendo. Su questo argomento ha scritto parole illuminanti Il Pedante, che i lettori della Verità conoscono bene. «Chi parla di meritocrazia parla di test, performance, rating, ranking, references e via anglizzando nel tentativo di dare una definizione tecnica e ideologicamente apolide del meglio, cioè dei migliori», ha spiegato. «La meritocrazia ama dunque la tecnica, ma anche i tecnici amano la meritocrazia. Il mito di una società meccanicisticamente governata dai migliori secondo un criterio di bene sottratto alle idee è lo stesso che sostiene il delirio tecnocratico, cioè totalitario». Le applicazioni pratiche di questo modello le vediamo un po' ovunque. Nella scuola prima di tutto, dove il bambino che non rispetta gli standard prestazionali viene immediatamente certificato, trattato come una sorta di malato, uno «difficile», inadatto. Ma l'ideologia meritocratica si applica negli ambiti più diversi. Colpisce persino gli Stati: la Grecia, per esempio, non ha rispettato gli standard di «merito» decisi a livello europeo, dunque andava in qualche modo punita. Discorsi analoghi li abbiamo sentiti anche riguardo all'Italia: «Ha vissuto al di sopra delle sue possibilità», si è detto. Non ha fatto i compiti a casa, dunque bisogna che intervengano «i migliori» (cioè i tecnici) per rimetterla in riga. Alcune delle più efficaci argomentazioni di Michael Young vengono riprese oggi da due intellettuali francesi di vaglia, ovvero la filosofa Angélique Del Rey (autrice di La tirannia della valutazione, Eleuthera) e Bénédicte Vidaillet (di cui è appena uscito in Italia Valutatemi! Il fascino discreto della meritocrazia, Novalogos). Scrive quest'ultima: «Con il pretesto di valutare, si normano, si dirigono, si prescrivono e si inquadrano i comportamenti». Soprattutto, però, si trova una gigantesca giustificazione all'ingiustizia. In una società «meritocratica», se non ottieni risultati è colpa tua. Sei tu che «non ti meriti» di avere uno stipendio adeguato o addirittura un lavoro. Sei tu a non essere adatto, a non rispettare lo standard. Se non esistono uguali possibilità per tutti, non è colpa del modello di governo che viene applicato, ma è colpa del singolo che risulta perdente nel gioco al massacro della competizione sfrenata. Un gioco in cui i più deboli perdono sempre.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.