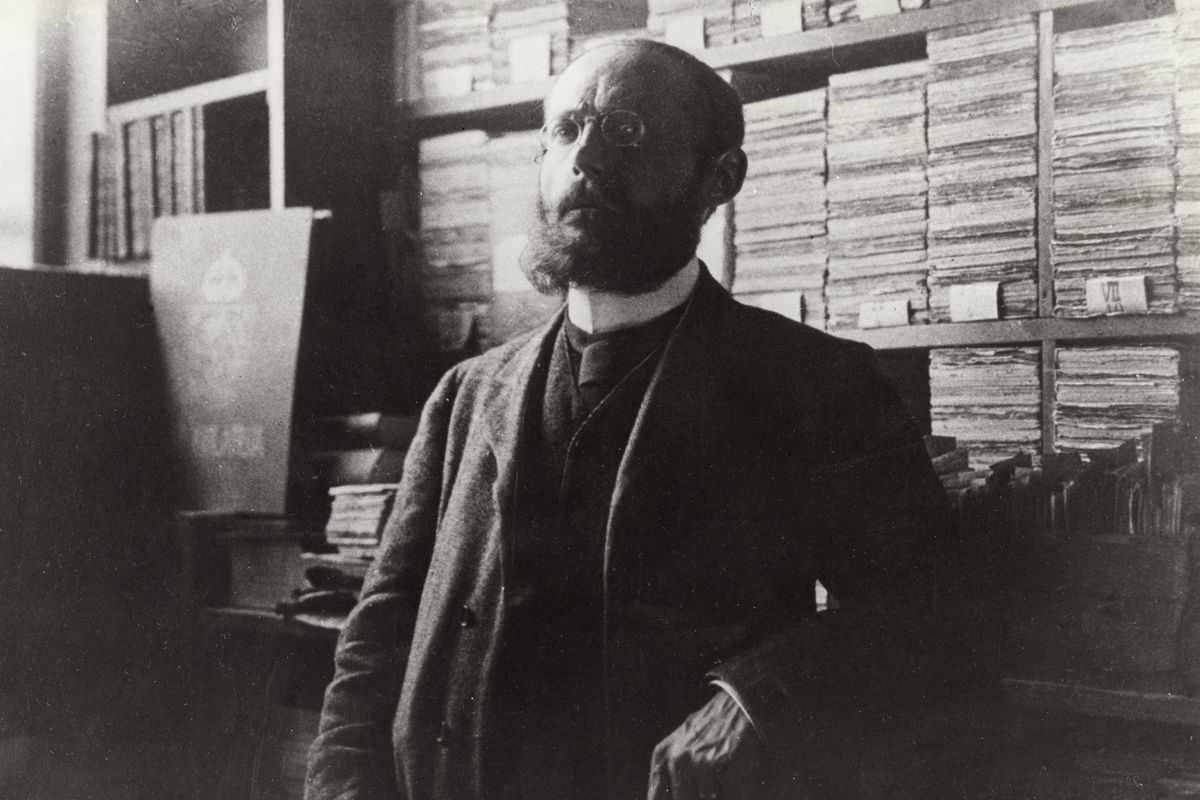
«Péguy ha visto la natura del disastro a cui andava incontro la società basata sul culto del denaro». (Carlo Bo)
Se in politica la sua vis polemica si scatena contro gli anti-dreyfusardi, siano essi socialisti, monarchici o cattolici, in campo culturale lei individua lucidamente un responsabile del dramma della miseria economica, umana e sociale in cui versa la Francia di fine ’800/inizio ’900: il mondo moderno.
«Questo disamore generale verso il lavoro è la tara più profonda, la tara fondamentale del mondo moderno».
Viene istintivo classificarla come anti-moderno. Invece per lei Finkielkraut conia un termine, l’incontemporaneo (le mécontemporain) per indicare l’impossibilità di essere moderni, vale a dire di «lasciar fare al tempo», di assoggettarsi all’ideologia, o meglio, alla religione del progresso per la quale «dopo è sempre meglio che prima». Un’illusione che verrà stroncata dalle guerre mondiali, ma che perdura ancora oggi nell’idea scientista secondo la quale le conquiste della scienza e della tecnologia possono essere estese a tutti gli ambiti dell’esistenza (la storia, la psicologia, la società, la politica, la religione).
«La principale malattia del mondo moderno è la colpevole prevalenza dell’astrazione sulla vita. È una realtà monca, una realtà ridotta ad aspetti quantitativi».
Lei però non disprezza la scienza, si aggiorna costantemente sui suoi avanzamenti, ma considera questa estensione una pretesa abusiva, che genera una concezione dell’uomo e dei suoi rapporti che capovolge e nega quelle che hanno fatto fiorire le grandi civiltà del passato.
«La scienza può chiarirla, sorvegliarla, controllarla, corroborarla, ma la scienza non fa la vita».
È per questo che lei parla di barbarie? Esse non sarebbero la nostra preistoria, ma una triste possibilità che ci accompagna e che si attua nella «villania» degli uomini moderni.
«Il moderno non cerca di formare una ragione a immagine del mondo, ma di costruire un mondo a immagine della ragione».
Cioè?
«L’uomo non ascolta più la realtà. L’uomo moderno pretende di rifare la creazione del Creatore e pensa che la sua creazione sarebbe stata cento volte più bella, perché infinitamente più regolare invece la vecchia creazione è sporca di linfa e di vino, ansimante, vibrante, piena di latte e di sangue. All’esperienza così com’è, come esce dal ventre della natura, terrosa esperienza, la scienza moderna sostituisce, anche in campi non strettamente scientifici, l’esperimento in laboratorio, l’esperienza come non è, lavata, ripulita, vestita elegante».
Prendo a prestito una sua immagine, un’immagine efficace: l’uomo moderno dopo la rivoluzione industriale lavora il ferro, non più il legno e la pietra, non più la materia prima nella quale il colpo dello scalpello lascia un segno irreversibile, ma una materia seconda, duttile, malleabile, intercambiabile, sempre disponibile ed eternamente trasformabile. In questo il mondo moderno non ha fatto che radicalizzarsi; malleabile non è solo la materia ma l’umanità stessa si pensi, come esempio estremo, alla realtà delle manipolazioni genetiche.
«Il mondo sarà giudicato sulla base di ciò che ha reso commerciabile o non».
Non di sola filosofia si tratta. Nei rapporti tra gli uomini, nella città (non armoniosa) subentra il criterio della misura. Tutto diventa misurabile. È quello che lei chiama il dominio del denaro.
«Tutto l’avvilimento del mondo moderno, tutta la svendita del mondo moderno, tutto l’abbassamento del prezzo deriva dal fatto che il mondo moderno ha considerato negoziabili quei valori che il mondo antico e il mondo cristiano consideravano non negoziabili. Questa universale negoziazione ha prodotto questo universale avvilimento».
Nasce da questa mercificazione la «villania» che lei denuncia: il potere specificamente moderno di fare qualunque cosa di ogni cosa.
«Il mondo moderno avvilisce tutto. Una sola cosa non ha avvilito, anzi ha reso totalmente dominante: il denaro».
Il suo è un disprezzo totale?
«Intendiamoci, il denaro è altamente rispettabile, non lo si dirà mai abbastanza, quando è il prezzo del pane quotidiano. Il denaro non è affatto disonorante quando è il salario, la retribuzione, la paga, quando in sostanza è il trattamento economico, quando è poveramente guadagnato. In questa accezione il denaro è onorevole, onesto. È decoroso».
Come è successo invece che il denaro è diventato fine a sé stesso?
«Tutto ciò che doveva servire soltanto allo scambio ha completamente invaso il valore da cambiare. Non bisogna dunque dire soltanto che nel mondo moderno la scala dei valori è stata sconvolta. Bisogna dire che essa è stata annientata. Perché lo strumento di misura, di scambio, di valutazione ha invaso tutto il valore che doveva servire a misurare, scambiare, valutare. Lo strumento è diventato la materia e l’oggetto e il mondo. È come se l’orologio si mettesse a essere tempo».
Il frutto esistenziale e sociale del positivismo materialista ci si rivela nella sostituzione del popolo con la borghesia, che si impone come nuovo protagonista nella storia, come il nuovo attore e fautore del progresso assicurato dai futuri successi della scienza e della tecnica applicata al mondo del lavoro e alla società.
«Mi ripeto, la borghesia ha lo scopo del denaro».
È bene chiarire che con «borghesia» lei non individua una categoria economico-sociale (anche gli operai in questo senso voglio, giustamente, diventare borghesi) ma una predisposizione culturale e morale per cui l’uomo non ha altro scopo che l’accumulazione e il potere. Il disordine sociale. Le ingiustizie, le disuguaglianze, la perdita di dignità del lavoro che ne segue sono evidenti. Allora il potere, politico, civile, economico e anche ecclesiastico, si danno da fare per sistemare le cose. Come una massaia che «rassetta» nel disordine generale.
«Ma questo rassettare in un mondo in cui Dio è il denaro, è come sistemate il letame in fondo al giardino».
La sua città armoniosa non sembra puntare su un cambiamento della situazione, quanto su una su una rivoluzione delle coscienze. Ma è socialismo questo?
«La rivoluzione sociale o sarà morale o non sarà».





