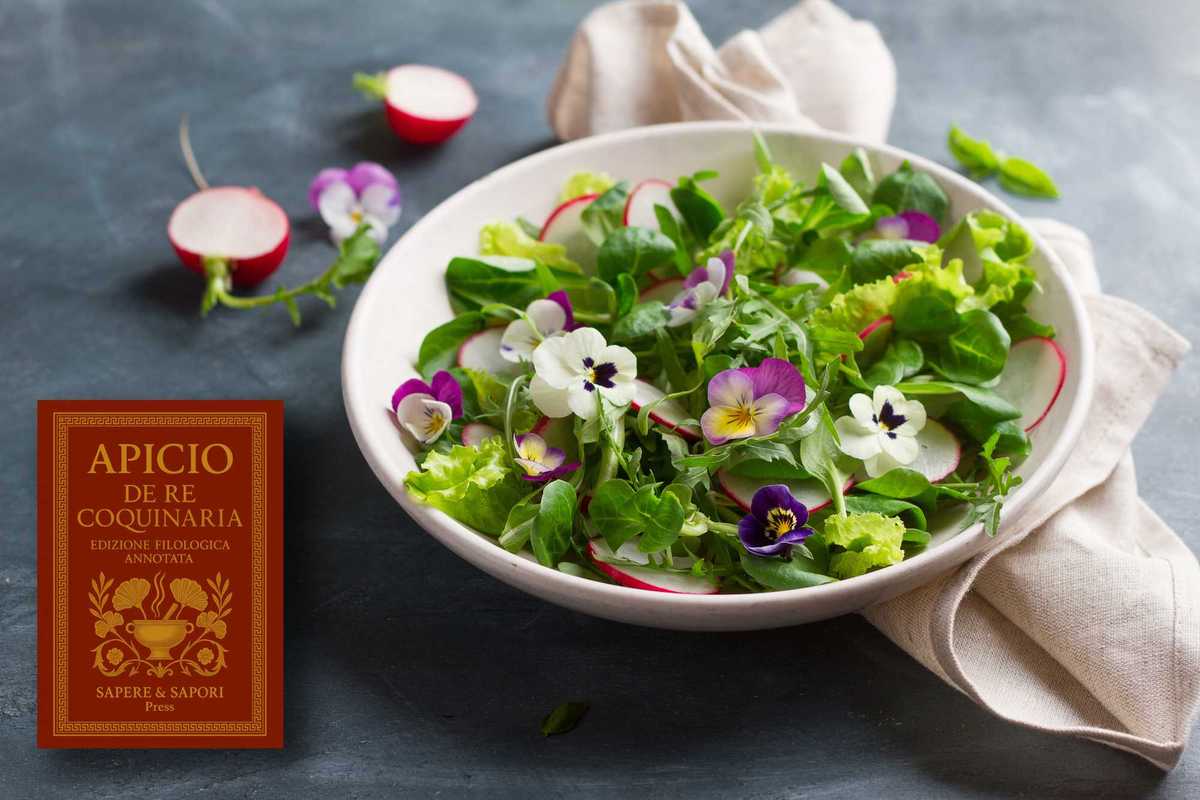Se vi fate un panino con il prosciutto di Cinta e lo accompagnate con un bicchiere di Chianti è sicuro che andrete a intasare le terapie intensive e questo in tempo di virus cinese pare brutto. Parola di Commissione europea che dice che vino e salumi provocano il cancro. Magari Bruxelles fa fatica a frasi dare i vaccini dalla Pfizer, ma se c'è da stangare il Barolo o il salame di Felino non si tira mai indietro. Ora vediamo come la mettono i nostri europeisti impegnati a far di Conte, ma poco attenti a difendere gli interessi della nostra economia in quel di Bruxelles mentre in Francia sono già pronti a fare le barricate.
Viene da chiedersi se Paolo Gentiloni, il nobiluomo del Pd che sorveglia i conti pur stando al guinzaglio di Vladis Dombrovskis si sia accorto del piattino che gli hanno preparato. La guerra all'agricoltura mediterranea è cominciata da un pezzo nelle sacre stanze dell'Europa, è passata per il cosiddetto Nutriscore fatto apposta per compiacere le multinazionali del cibo che sono anche le multinazionali delle medicine. Ma siccome l'etichetta a semaforo ancora non ha raggiunto il suo scopo ecco il nuovo progetto: si chiama Europe's Beating Cancer Plan e sarà presentato oggi, in occasione della giornata mondiale contro il cancro da Ursula von der Leyen.
Il piano lo ha anticipato www.winenews.it solitamente molto bene informato su tutto quello che riguarda vino e dintorni. Il sito di Alessandro Regoli annuncia: «Sulle bottiglie ci saranno le etichette dissuasive come quelle che ora si applicano alle sigarette ed è previsto l'azzeramento di tutti i fondi promozionali a vantaggio di alcolici e dunque del vino oltre a penalizzazione per i salumi e per le carni rosse». Tutto questo in ossequio alle direttive dell'Oms – l'Organizzazione mondiale della sanità, quella che loda i cinesi che hanno dato l'allarme sulla pandemia con almeno quattro mesi di ritardo – che un giorno dice che la carne rossa fa venire il cancro e l'altro sostiene che il consumo, non l'abuso, di vino favorisce l'insorgenza di tumori. E così l'Europa si allinea, anzi fa di più. Come nota Luigi Scordamaglia che ha protestato con una lettera inviata insieme a Coldiretti alla Commissione europea: «Il piano non ha nessun senso. Intanto ci sono evidenze scientifiche che indicano che il consumo moderato di vino aiuta la salute e non il contrario, poi in Italia il consumo di carne rossa è al di sotto della dose consigliata dai medici e la stessa Oms dice che non ci sono evidenze di cancerosità delle carni trasformate, ma indica un consumo moderato. Ora», osserva ancora Scordamaglia, «togliere soldi all'informazione al consumatore significa ottenere esattamente lo scopo opposto a quello dichiarato dalla Commissione: cioè educare al consumo. La verità è che c'è ancora e di nuovo un attacco al made in Italy». Nell'Europe's Beating Cancer Plan è previsto l'obbligo di etichettare vini salumi e carni come nocivi alla salute, l'azzeramento di tutti gli «stimoli al consumo di alcol attraverso i programmi di promozione dei prodotti agricoli Ue» e ovviamente di tutti i sostegni alla produzione.
Per gli agricoltori significa una mazzata da ko, vuol dire che la cosiddetta Ocm vino (organizzazione comune di mercato) salta per aria e che si perdono alcuni miliardi di sostegno. Per il made in Italy agroalimentare il colpo è durissimo: al di là dei mancati sostegni il danno d'immagine è enorme. L'agroalimentare italiano vale all'incirca un quarto del nostro Pil: 180 miliardi di fatturato diretto che generano un valore aggiunto di 119 miliardi per un complessivo fatturato di filiera che sfiora i 600 miliardi di euro. L'esportazione vale 44,6 miliardi, nel caso del vino l'export è il 53,% del fatturato delle cantine, per i salumi (un comparto 8 miliardi) l'export vale 2,2 miliardi e per le carni la quota estera è circa l'11% sui 30 miliardi di fatturato. Dal campo alla tavola il comparto vale 3,4 milioni di occupati.
In Francia sono già pronti a fare le barricate e nei giorni scorsi Ignacio Sanchez Recarte, segretario generale del Comité Européen des Enterprises Vins si chiedeva: «Perché se la Commissione europea è così fiera del nostro cibo, propone di fermare la promozione Ue per vino, spirits, birra e carne rossa nello Europe's Beating Cancer Plane?». In Italia solo la Coldiretti per ora ha lanciato l'allarme. Il presidente Ettore Prandini ha scritto a Paolo Gentiloni, che non ha accusato ricevuta, per dire : «Fermate questa penalizzazione, già il Covid ha messo a terra la filiera del vino e l'agroalimentare di grande qualità, ora si colpiscono prodotti simbolo con l'Italia che il principale produttore europeo di vino, ma anche il Paese più ricco di piccole tipicità tradizionali che così rischiano invece di essere condannate all'estinzione». Ed in effetti la contraddizione della Commissione è palese. Da una parte assegna Dop a pioggia a salumi e vini, dall'altra dice che sono potenziali bombe per la salute. Ma la verità probabilmente è un'altra. È che la Commissione vuole drasticamente ridurre i fondi per la politica agricola comunitaria. Si sapeva già che l'effetto Brexit avrebbe costretto a una riduzione del 15% dei fondi agricoli, ma ora c'è da finanziare il Recovery Fund e c'è da farsi belli con il green new deal che prevede che le mucche inquinano, i maiali sono nemici degli ambienti, il vino va sostituito con gli integratori delle multinazionali e la dieta vegana è quella politicamente corretta. Perciò basta inventarsi una nuova pandemia: Barbera e michetta sono peggio del virus cinese.