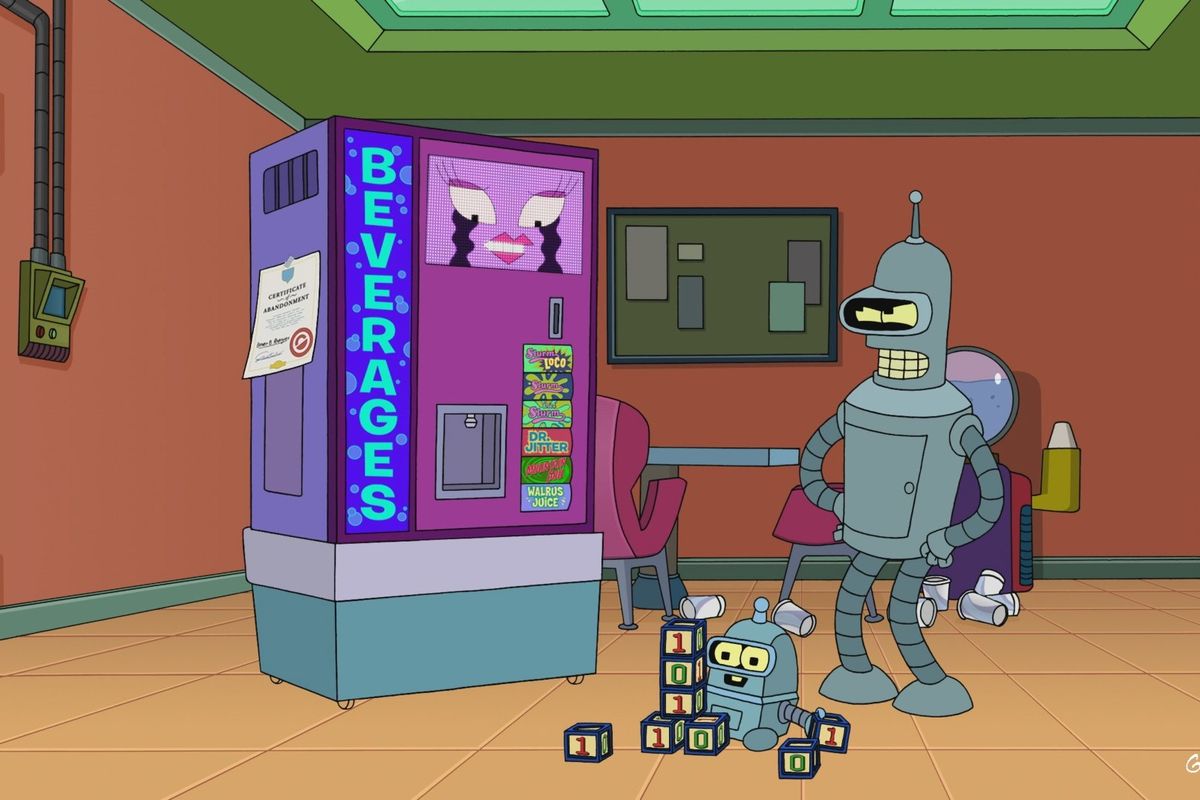
Non passa giorno senza annunci di nuove e audaci applicazioni dell'intelligenza artificiale: quella che guiderà le automobili, guarirà gli infermi, gestirà i risparmi, scriverà libri, dimostrerà teoremi irrisolti. Che farà di tutto e meglio, sicché i suoi cantori immaginano tempi prossimi in cui l'uomo diventerà «obsoleto» e sarà sostituito dalle macchine e dal «governo dei robot». Questo parlare di cose nuove non è però nuovo. La proiezione fantatecnica incanta il pubblico già da almeno due secoli da quando cioè «la religione della tecnicità» ha fatto sì che «ogni progresso tecnico [apparisse alle masse dell'Occidente industrializzato] come un perfezionamento dell'essere umano stesso» (Carl Schmitt) e gli ha conferito l'illusione di un moto inarrestabile e glorioso.
Per intelligenza artificiale (IA) si intendono le tecnologie in grado di simulare abilità, ragionamento e comportamento degli esseri umani: in piccolo, ciò che già fa una calcolatrice (che simula l'abilità del calcolo) o un Pc. Più che introdurre una rivoluzione, il concetto di IA sembra allora identificare lo sforzo e l'auspicio di sviluppare tecnologie sempre più sofisticate e potenti. Che poi queste ultime finiscano per replicare alcune funzioni della mente umana è già in definizione, perché concepite fin dall'inizio con quell'obiettivo. Ciò che appassiona delle più recenti applicazioni è la crescente capacità di elaborare input non rigidamente formalizzati, in primis il linguaggio. L'assalto cibernetico a questo impervio monte, che tanto ricorda l'impresa babelica, è solo ai suoi timidi inizi ma, per quanta strada si possa percorrere, resteremmo comunque lontani dalla meta.
Perché l'intelligenza non si limita a risolvere i problemi ma li pone, e li dispone secondo gerarchie. In ciò è condizionata e finalizzata dal soggetto che la esprime, ne è definita anche etimologicamente perché è l'espressione dei suoi fines: dei limiti che ne tracciano l'identità irripetibile e indivisibile - desideri, paure, relazioni, credenze ecc. Se la competenza logico-matematica è terreno comune a uomini e macchine, il suo esercizio è asservito alle gradazioni e alla mutevolezza della condizione di ciascuno. Una macchina non può ragionare come un uomo semplicemente perché non è un uomo, proprio come il bambino dell'Apostolo non può ragionare come un adulto. Occorre allora chiedersi il perché di questa finzione, di negare il naturale rapporto di complementarietà tra i domini ontologico e procedurale con la pretesa che possano, anzi anzi debbano, confondersi e sostituirsi.
Azzardo due risposte. Se il soggetto intelligente guarda dentro (intus legit) la propria condizione per formulare gli obiettivi da sottoporre ai processi computazionali delegabili a un algoritmo, resta aperto il problema di chi detterebbe, ex multis, gli obiettivi alle macchine affinché le si possa chiamare «intelligenti». Come il «pilota automatico» di Mario Draghi, l'IA guiderà da sola e supererà ogni ostacolo, sì, ma verso quale meta? Inevitabilmente quella iscritta nel codice dai suoi committenti, che governando il codice godranno del privilegio di imporre i propri modelli a tutti. Dalle sofisticazioni tecniche emergerebbe allora una più lineare dinamica di dominio dell'uomo sull'uomo, dove la citata finzione non sarebbe altro la pretesa tecnocratica di incapsulare interessi e moventi particolari in una procedura sedicente inalterabile e necessaria.
La seconda ipotesi chiama in causa il limite dell'uomo. Molti indizi fanno temere che, nel sentire comune, la riduzione del corredo soggettivo e plurale delle intelligenze umane in un sottogruppo di procedure sia intesa non già come un impoverimento, ma come un salutare superamento della imprevedibile complessità di pensiero del formicaio umano, e quindi dei «pericoli» che vi si anniderebbero. La macchina non «tiene famiglia» e non ha nulla da perdere né da guadagnare, e quindi – si pensa – non può che fare «la cosa giusta» per tutti. Dalla tentazione di separare anzitempo la zizzania dal grano scaturisce l'illusione di distillare processi cognitivi e decisionali infallibili, disattivando tutto ciò che può generare l'«errore»: fragilità, affetti, inclinazioni, dolo ma anche, e in ultima istanza, la libertà di ciascuno. Si è però visto che l'unità indissolubile di intelligenza e soggetto rende vana questa illusione, il cui solo risultato può essere quello di spostare l'arbitrio in poche mani potenti, omologando il resto.
Ma poco importa. Più forti sono il disgusto e la paura dell'indisciplinabile incognita uomo, il desiderio di spuntarle le armi incatenandola e negandola nella sua essenza distintiva - quella pensante - e la brama di spegnere il coro dissonante delle intelligenze per ridurle alla sincronia delle marionette.
In ciò è rivelatorio che quasi tutto ciò che oggi si fregia dell'etichetta di IA è ben lontano dal requisito di portare la macchina nel modus cogitandi degli esseri umani per mettersi al loro servizio. All'opposto, le sue applicazioni implicano la necessità o l'obbligo che siano gli uomini ad adeguarsi alle procedure della macchina. Se davvero avessimo a che fare con un'intelligenza umanoide di silicio che mima la nostra mente, perché dovremmo lamentare la mancanza di «cultura digitale»? Non dovrebbe toccare al calcolatore il compito di assorbire la nostra cultura? E perché insegnare il «coding» ai bambini? Non dovrebbero essere i robot a parlare la nostra lingua? E ancora, dannarci con procedure telematiche, moduli online, assistenti automatici, Pec, app, Pin, Spid, registri elettronici e stravolgere il nostro modo di lavorare e di pensare per servire a un circuito la «pappa pronta» da digerire? Perché trasmettergli le nostre fatture nell'unico formato che riesce a comprendere, quando uno studente di ragioneria sarebbe in grado di decifrarle in ogni loro variante? E spendere tempo, quattrini e salute nervosa per imparare tutte queste cose? Sembra insomma che la celebrata umanizzazione della macchina si stia risolvendo nel suo contrario: in una macchinizzazione dell'uomo. Che l'impossibilità ontologica di portare i circuiti nei nostri ranghi stia producendo il risultato inverso di fletterci, costi quel che costi, alla rigida cecità della loro legge.
Certo, possiamo raccontarci che questi sono solo paradossi transitori. Ma la verità è che l'IA è la nostra intelligenza, l'IA siamo noi. Non ci parla dei progressi dell'informatica ma di un auspicato «progresso» dell'uomo chiamato a spogliarsi dei suoi difetti - cioè di sé stesso - per rivestirsi della stolta obbedienza, della prevedibilità e della governabilità dei dispositivi elettronici. Se nella prima fase questa transizione si è imposta con la seduzione dei suoi vantaggi, in quella successiva deve forzare la mano magnificando i suoi benefici e rendendoli in ogni caso obbligatori, con qualsiasi pretesto. È la fase attuale: quella del 5G, degli elettrodomestici e delle automobili in rete, dei telefoni che non si spengono mai, della telematizzazione kafkiana dei servizi pubblici e, insieme, dei mal di pancia di chi incomincia a preoccuparsi. Nel frattempo qualcuno già scopre le carte della terza e ultima fase, quella in cui gli esseri umani dovranno accogliere le macchine anche nel proprio corpo e non più solo nei pensieri, con l'«internet dei sensi» e l'impianto di processori collegati agli organi o al cervello. Con tanti saluti ai computer che diventano intelligenti, l'intelligenza diventerà un computer e l'uomo «sarà allora bardato di protesi prima di diventare egli stesso un artefatto... Poi, divenuto ormai inutile alle proprie creazioni, scomparirà» (Jacques Attali).
Questa riflessione non sarebbe completa senza interrogarsi sul perché di questo processo. Certo, a qualcuno non dispiacerà l'idea di tracciare, controllare e condizionare azioni e pensieri di ogni singolo individuo, né di assoggettare i popoli a processi e processori automatici. Ma anche questo incubo non sarebbe nuovo. Più misterioso è invece l'assenso di chi ci si presta: dai politici che assecondano le mode globali ai cittadini stessi che si immaginano pionieri di un'ubertosa età del silicio. Il problema, irriducibile alla propaganda, è quello di una civiltà che nel desiderio di superare l'umano si scopre profondamente scontenta di sé. Una civiltà delusa e incapace di raggiungere gli obiettivi che si è imposta, ma altrettanto incapace di respingerli e di riconoscerli come ostili a sé. Che immagina allora che l'anello marcio della catena siano proprio i suoi membri: gli uomini deboli e irrazionali. Nasce da qui, dalla percezione strisciante di un fallimento epocale, l'illusione di salvarsi incatenando i passeggeri ai sedili per espiare la «vergogna prometeica» (Günther Anders) di non essere all'altezza delle proprie creature. Per comprendere le radici di questa disperazione è quindi inutile interrogare gli ingegneri. Le tecnologie, intelligenti o meno, sono il pretesto di una fuga da sé che andrebbe affrontata almeno abbandonando la tentazione di soluzioni «perfette» e perciò estranee al mistero irriducibile dell'umanità che vive nella quantità mentre aspira all'innumerabile. Rimarrà il compromesso di una vita non certo geometrica e rassicurante, ma proprio per questo possibile, forse anche degna di essere vissuta.






