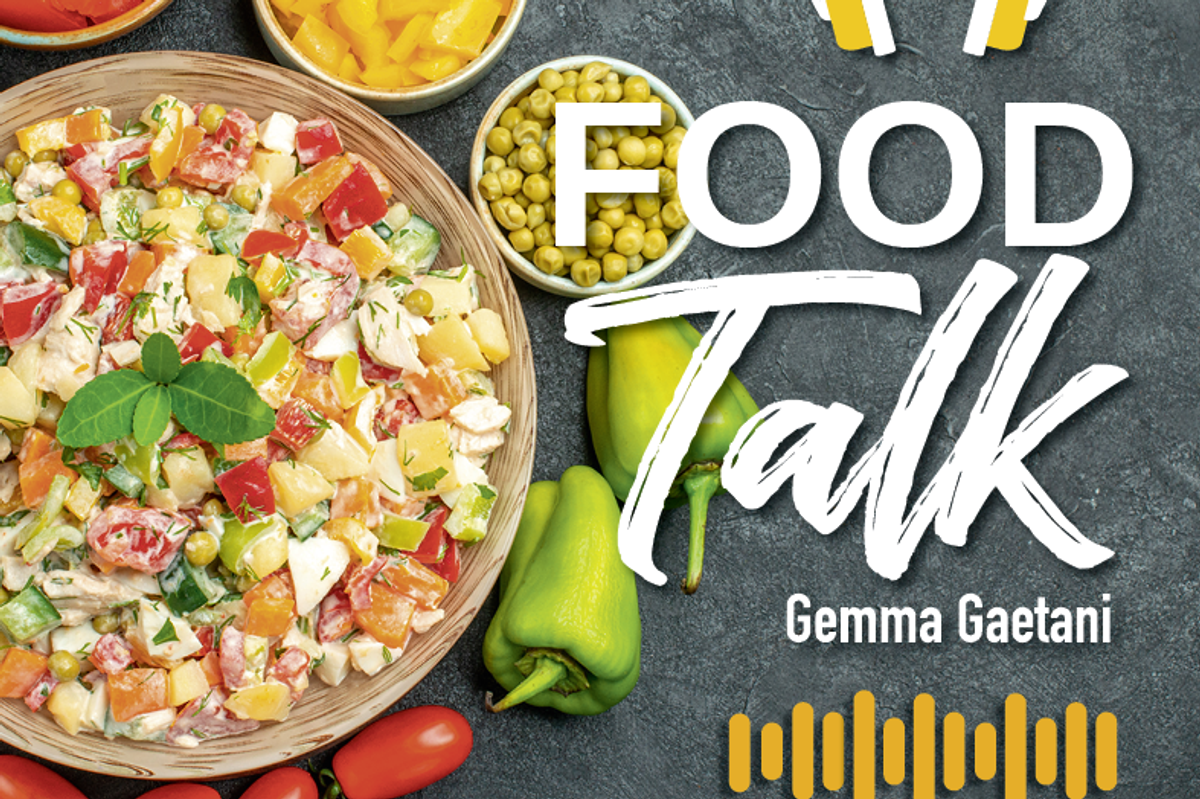Le università piegate al clima di paura mentre dovrebbero educare al coraggio
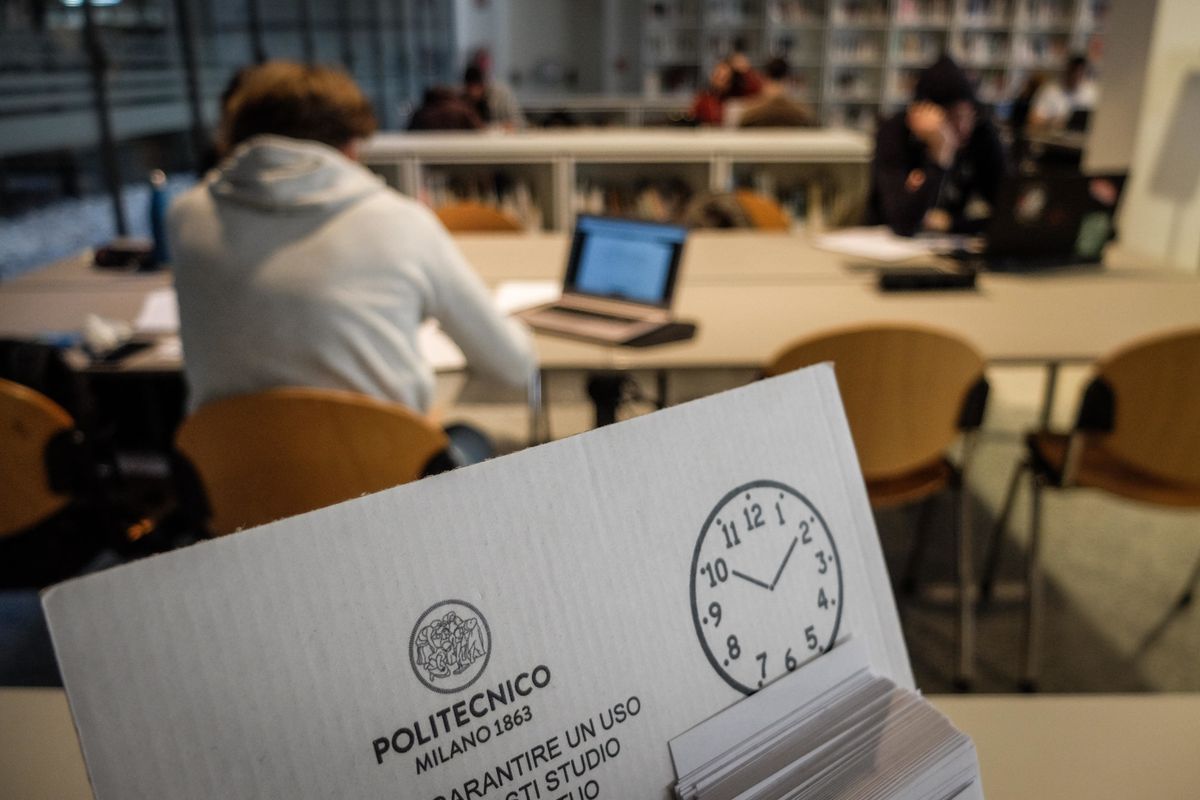
Si può argomentare se abbiano mai chiuso, ma se così fosse stato è certo che i centri di massaggio cinese riprenderanno servizio prima delle Università. Magari rispettando le distanze sociali. Potrebbero anche questi essere i risultati della penetrazione cinese via Covid-19.
Le Università, come tutto il mondo dell'istruzione, sembrano aver deciso di soccombere alla paura del virus rifugiandosi in una lunga distanza sociale temporale (anche il tempo è percezione, cultura e dunque socialità!) che porta al 2021 un barlume di ripresa «per tutti» in aula. I documenti degli atenei parlano sempre di una attività in presenza avviata con «gradualità» e «prudenza», giustificando questa posizione attendista con una «missione (che) non si limita alla trasmissione di saperi ma alla formazione di cittadini attivi e responsabili».
Insomma, per tutti gli Atenei nostrani la responsabilità del cittadino studente si promuove e si dimostra stando a casa. E, a onor del vero, questa posizione è condivisa da tante università straniere, tra queste le inglesi e le americane.
Leggendo meglio le diverse offerte formative, agli studenti e alle loro famiglie è spesso lasciata la scelta di frequentare una lezione contingentata nel numero dei partecipanti oppure seguirla in diretta da casa: si riconosce la possibilità di avere paura a venire in città, a Milano in Università, e di avere paura di stare anche a distanze rispettabili.
Ecco dunque che generalmente la paura diventa la possibilità legittima di bigiare i corsi.
Mi chiedo: quanti lavoratori hanno paura ad andare al lavoro ma ci vanno perché è un loro dovere? E sarebbe etico dare loro la possibilità di non lavorare in nome della loro paura? Ma ricevere egualmente lo stipendio?
La paura è una reazione all'incertezza che si combatte con le regole e con la conoscenza. Esattamente quello che le Università sono chiamate a fare nella loro missione e che non solo ora rinunciano a fare, ma utilizzano anche come giustificazione alla loro rinuncia.
Le ragioni di questo atteggiamento si trovano sia nella deriva dell'istruzione universitaria di questi anni sia nella strumentalizzazione della pandemia.
Il primo aspetto rimanda a una Università interpretata come alta scuola professionale per tutti che ha abbandonato i propri orientamenti educativi: è l'educazione che si conquista con la sofferenza del dovere che si distingue dalla formazione che richiede la sola fatica dello studio. Si tratta di sforzi differenti che richiedono sia una diversa applicazione da parte dello studente sia una diversa didattica da parte del docente, che nelle buone Università si incontrano. Ma non nella Fase 3 del Covid, a quanto pare. Tale orientamento funzionale è coerente con la nuova figura dello studente consumatore, quindi pagatore, dell'istruzione, la cui soddisfazione è l'orientamento delle strategie di ogni ateneo: il timore è il calo delle iscrizioni dovuto al malcontento che rumoreggia magari via social. Le strategie educative sono state sostituite, infatti, dalle strategie di marketing universitario che devono intercettare e contenere quei rumori che potrebbero danneggiare la vendita del prodotto.
E che cosa più della paura incide sui consumi? Dunque, si legittimi la paura di venire a Milano e Roma, a Napoli e a Venezia o dovunque: la paura che non si misura ma si sente ci terrebbe nel rifugio casalingo. La «gradualità della ripresa» legittima proprio ogni conseguenza soggettiva del provare paura, senza che l'istituzione educativa si prenda la responsabilità di dare una visione del mondo coraggiosa ai suoi studenti. Università da anni pavide e rinunciatarie che tuttavia salvano le chiappe dalle pezze dovute alle mancate rette in cambio della rinuncia a educare al coraggio, che richiede più responsabilità della paura.
D'altra parte, la paura che diventa terrore è il secondo aspetto da considerare nel leggere il traballante riavvio del sistema dell'istruzione che, per primo, dovrebbe sostenere il nuovo mondo post covidiano, invocato da tutti.
E qui devo fare io per primo un «mea culpa»: ho sempre sostenuto che gli insegnamenti della gestione della comunicazione di crisi del dopo Chernobyl non erano abbastanza conosciuti per governare la crisi Covid-19, molto simile a quella di allora. Ma comincio a pensare di essermi sbagliato: e se invece, quegli insegnamenti fossero conosciuti tanto bene da decidere di evitarli strategicamente per ottenere, dallo sfruttamento della crisi cinese, gli effetti che si voleva ottenere?
Perché, cari lettori, se la paura dell'evento sorprendente può governare i primi tempi, ormai da settimane viviamo in un terrore raccontato e mediatizzato che non ha alcuna connessione con la realtà di questi giorni ma ha effetti drammatici sulla realtà quotidiana dei prossimi giorni.
Il terrore è comunicazione perché vive di minaccia, che non è una azione ma il racconto di essa: vi invito a leggere le interpretazioni dei numeri di questi tempi e i commenti da ville e tappeti rossi istituzionali e mediali chiedendovi di cercare il dato di realtà.
Introvabile al di fuori di quelle narrative.
Dunque, il terrore e la paura forse sono la cifra stilistica del governo opportunistico del Covid-19 alla quale, soffro a dirlo, anche le Università si sono adeguate per garantire la cassetta. E pensare che proprio le Università furono quella rete di relazioni, tessuta insieme da studenti e professori, che sopravvisse alle pestilenze e anche alle svolte autoritarie.