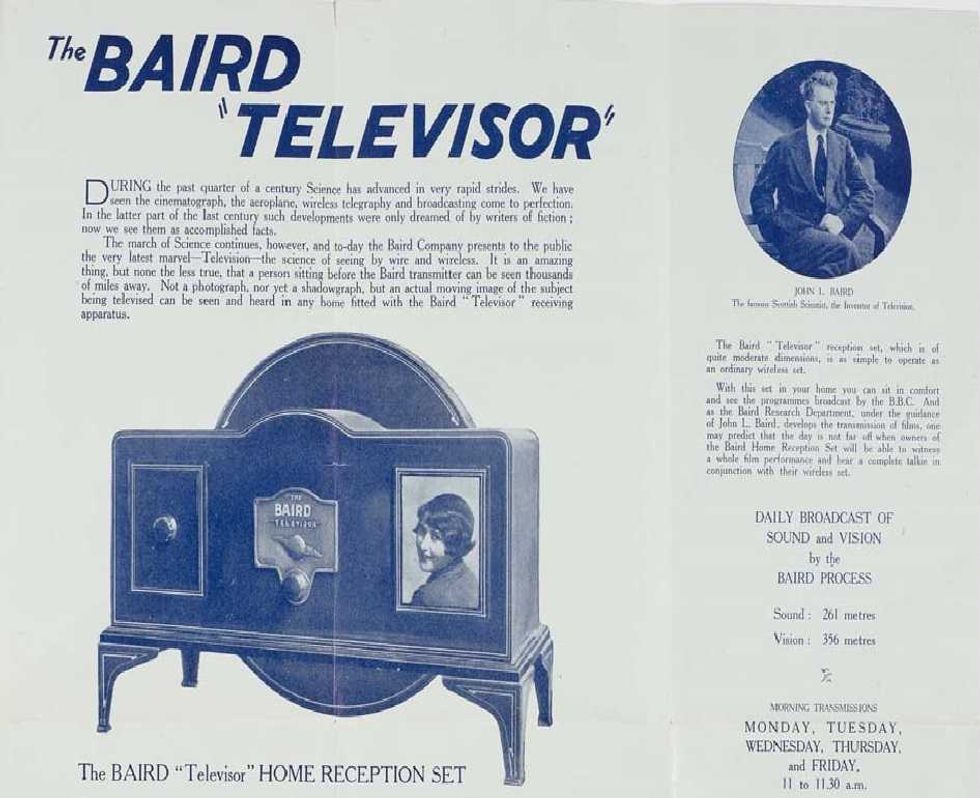I contraccolpi del conflitto russo-ucraino hanno improvvisamente scoperchiato la pentola a pressione del deficit italiano di materie prime agricole essenziali per la produzione di alimenti d’uso quotidiano, che si affianca a un’allarmante penuria di fertilizzanti e alla fame di energia delle aziende agricole, costrette a confrontarsi con debiti da pagare e costi alle stelle di metano ed elettricità. Ora, il granaio piange e anche il portafoglio di chi fa la spesa. Quali sono le più urgenti risposte a questa impasse? Parola a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e imprenditore agricolo.
I fatti dicono che l’Europa non è stata lungimirante.
«Ha certamente sbagliato. Stiamo parlando di una stagione lontana, si giungeva da un periodo prolungato di eccellenza. L’Europa era a 12 Paesi, non a 27. Si è cercato di mantenere un equilibrio economico senza tener conto della politica agraria sottostante. Oggi abbiamo 27 modelli di agricoltura, ciascuno diverso dall’altro. Il mercato non si è più governato secondo i bisogni europei, ma rincorrendo quello globale. Oggi non si produce più ciò che il mercato richiede, ma anche beni non essenziali. Quindi siamo costretti ad acquistare fuori continente».
Qual è, dunque, secondo lei, il rimedio?
«Ho incontrato i commissari europei all’Agricoltura. Ci vuole una politica incentrata sulla food security. Bisogna tornare a parlare di produzione. C’è stata una mancanza di pianificazione produttiva influenzata dalla «Farm to fork». Ho chiesto che l’attuale Pac (Politica agricola comune, ndr) sia semplificata. Vanno liberati 9 milioni di ettari per la coltivazione, da destinare a cereali e semi oleosi».
Anche in agricoltura si produce energia, attraverso le centrali a biomasse e a biogas. Ma è una goccia nell’oceano delle necessità. E utilizzare mais ceroso o sorgo non sottrae superfici destinate a cereali a uso alimentare?
«L’agricoltura contribuisce a un nuovo modello che vuole un mondo più pulito. In Italia ci sono 1.400 impianti a biogas che producono energia, ma ciò soddisfa solo lo 0,1% del fabbisogno del settore. Non c’è un problema di sottrazione di terreni per coltivazioni alimentari. All’energia sono destinati soprattutto sottoprodotti agricoli e scarti. Se riscriviamo la nuova Pac incentrandola su 4 colture, grano, mais, soia e girasole, non ci sarà mai un problema di mancanza per le destinazioni energetiche. Se gli agricoltori sapranno produrre fotovoltaico, biogas e biofuel, i costi di produzione dei beni agricoli si abbasseranno».
Quanto l’agricoltura italiana dipende dal petrolio?
«Totalmente. Ed è molto energivora. Trattori a gasolio, serre riscaldate attraverso il gasolio, irrigazione garantita da motori a gasolio. Il resto è energia elettrica legata al gasolio. Il caro-energia, per l’agricoltura italiana, è un disastro assoluto».
L’improvviso rincaro del prezzo del pane, al dettaglio, è da ricondursi a fenomeni speculativi?
«Sì, certamente. Sui mercati finanziari sono in atto rilevanti fenomeni speculativi. Ci sono investitori che speculano sulla fame e ciò non è etico. Il mercato reale sottostante risente dell’andamento dei mercati finanziari e ciò penalizza sia i consumatori finali sia alcuni produttori agricoli, come quelli zootecnici».
Per i periodi di crisi, come quello attuale, non si dovrebbe far affidamento su stock di cereali di scorta?
«Ho segnalato ai commissari che non esiste un sistema europeo di rilevamento delle scorte e non si conosce la loro entità. Sarebbe necessario un obbligo di scorte. Ogni Stato membro deve acquistare singolarmente da fuori Europa, quando invece si potrebbe fare collettivamente. Abbiamo un sistema europeo che definisce gli standard sanitari, ma non c’è la volontà di definire un modello unico di acquisto».
Siamo alla vigilia della semina del mais che sarà raccolto a settembre. L’Italia dipende sempre più dall’import per circa il 50% e dati Ismea rilevano che l’Ucraina è il secondo fornitore di mais dell’Italia. Cosa fare?
«Dobbiamo fare come la Spagna, che ha chiesto l’autorizzazione di importare mais dalle Americhe, in deroga ai regolamenti. Le coltivazioni di mais in Italia sono scese del 20%, perché ciò non era conveniente. Bisogna renderle remunerative. Deve essere urgentemente approvata la possibilità di utilizzare biotecnologie per avere un mais più resistente alle malattie, meno idro-esigente, non Ogm e con maggiori rese».
Per il frumento tenero, essenziale per industria e artigianato della panificazione e biscotti, com’è messa l’Italia?
«Siamo facilitati, perché, primo, mancano tre mesi ai raccolti e dunque possiamo pianificarli e, secondo, per le semine di settembre potremo aumentare le superfici di grano tenero destinate alla panificazione».
E per quello duro, basilare per la produzione di pasta, un segmento in cui primeggiamo?
«Qui Russia e Ucraina non c’entrano. Noi importiamo da Stati Uniti, Canada, Kazakistan e non ci sono grandi preoccupazioni per l’approvvigionamento. Per i prezzi, sì, poiché gli stock sono diminuiti a causa degli eventi climatici avversi nell’ovest del Canada e in Australia. Anche per quelli energetici, essendo l’industria pastaria vorace di energia e metano per molitura ed essiccazione. Ma ciò si tradurrà in un aumento di 1-2 centesimi per un piatto di pasta».
Lo zucchero scarseggia. L’Italia dipende pressoché totalmente dall’import. In Italia oggi restano solo due zuccherifici attivi, della bolognese Coprob.
«È stata un’ennesima scelta sbagliata dei nostri politici, che hanno guardato solo al breve periodo. È stato destrutturato un modello produttivo, che aveva il suo centro in Veneto, Emilia Romagna e parte della Lombardia. I nostri bieticoltori non sono più concorrenziali e Coprob si deve confrontare con un mercato in cui Francia, Germania e India la fanno da padrone».
Le ripercussioni della guerra sui fertilizzanti. Come si tampona?
«L’Italia dipende quasi esclusivamente dal mercato russo, principale produttore di matrici per fertilizzanti azotati e a base di potassio. Ci sono prodotti alternativi del nord-Africa, ma di qualità inferiore. I prezzi dei fertilizzanti, in primavera sono triplicati, proprio quando servono di più. Una crisi perfetta. Il governo ha dato l’ok per l’uso, in alternativa, di sottoprodotti come il digestato».
Quali sono le colture più necessarie e remunerative su cui, allo stato attuale, le aziende agricole possono puntare?
«Devono coltivare quelle che il mercato reale richiede e non seguire mode o tendenze. La priorità è su cereali e semi oleosi anche per contrastare il rischio zootecnico del Paese. E poi bisogna potenziare l’ortofrutta, nella quale siamo secondi al mondo dopo la Spagna».
Le tante piccole aziende agricole italiane sono oberate di debiti e a rischio scomparsa.
«È necessario uscire da quella logica secondo cui si può fare tutto da soli. Le piccole aziende sono sempre più marginali. Il mondo è globalizzato e fatto di concorrenze spietate. Servono alleanze, accorpamenti, contratti di filiera. Quanto ai debiti, un provvedimento del governo consente di diluirli, con garanzia pubblica, dal breve al medio e lungo periodo».
Nei supermercati assistiamo a rincari generalizzati sui prodotti alimentari. Ma le catene della grande distribuzione non potrebbero essere più solidali con i consumatori? E che diciamo degli agricoltori, da sempre anello debole nella catena del prezzo?
«Bisogna imparare dagli altri. In Francia e Spagna, c’è una legge che stabilisce regole per la ripartizione del valore nella filiera. Ci dev’essere anche da noi. In questi giorni abbiamo proposto al governo di erogare un contributo per la spesa delle famiglie meno abbienti».
Il governo che ha risposto?
«Non ha risposto, al momento. Ma lo solleciteremo».
Confagricoltura ha sempre manifestato apertura nei confronti di materia prima proveniente da seme geneticamente modificato, Ogm. La normativa italiana li proibisce, ma la soia utilizzata nei mangimi zootecnici e importata, spesso è Ogm.
«Certo, in Italia ne è vietata la produzione, ma non l’utilizzo. Studi che ne comprovino la dannosità per la salute non ne esistono, anche se ci rimettiamo alla scienza. Bisognerebbe guardare più all’interesse generale che alle specificità».