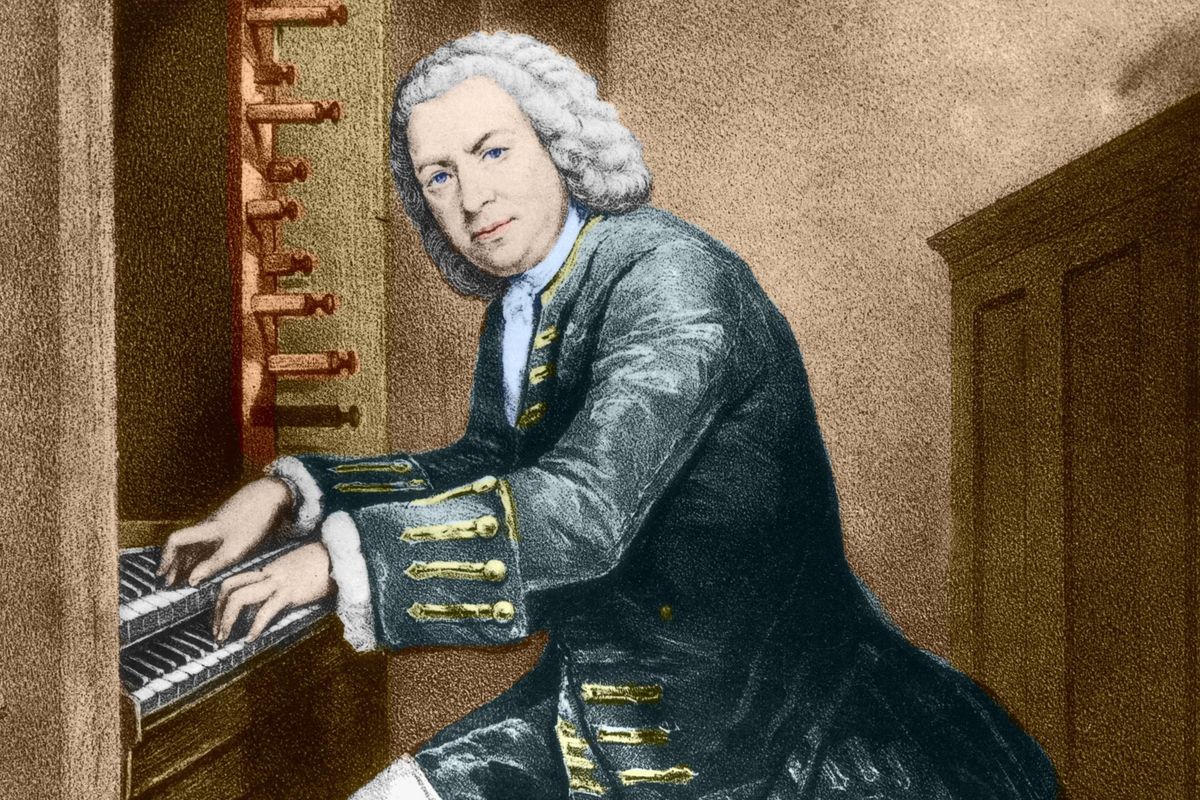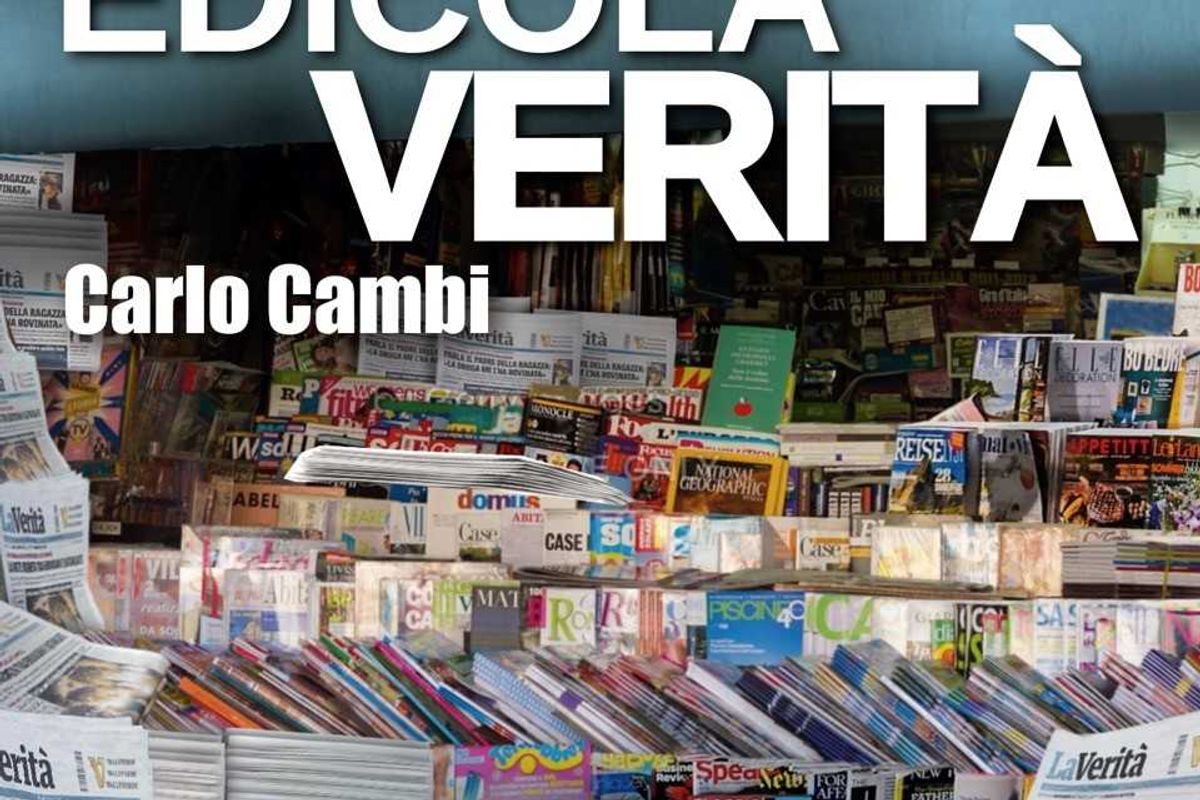2020-10-22
La fede senza limiti del gigante Bach in Dio e nella musica
Bach (Heritage Images/Getty Images)
Al primo posto metteva l'arte e lo spirito, senza concessioni alle mode. Per questo fino al XIX secolo venne dimenticato.Il capolavoro assoluto di Johann Sebastian Bach è la Passione Secondo San Matteo, opera che Felix Mendelssohn riscoprì nel 1829: da quella data in poi sarebbe divenuta la sua opera più popolare in tutto il mondo. Bach narra la Passione con le stesse parole del Vangelo. Ricordiamo uno dei recitativi più ispirati che viene dopo la domanda di Pilato: «Che cosa ha fatto di male? Ha fatto del bene a tutti noi, ha dato la vista ai ciechi, ha fatto camminare i paralitici, ha portato la parola del Padre, ha confortato gli afflitti!». Il tradimento e il pentimento di san Pietro hanno come epilogo un'aria per violino solo, uno dei momenti più ispirati della storia della musica. La Passione ha una tale ricchezza di invenzione che è superiore ad ogni analisi. L'architettura semplice e grandiosa, ricca di ispirazione profonda, impregnata di misticismo, è uno di quei capolavori che non appartengono più ad un'arte particolare.C'è una corrente filologica che, con la pretesa di interpretare il Bach storico e classico, lo appiattisce e lo rende noioso. Credo che Bach sarebbe il primo ad opporsi con tutte le sue forze al modo freddo, accademico e quanto mai estetizzante con cui vengono interpretate oggi le sue opere. Se c'è stato un uomo che ha attraversato il suo tempo provando tutte le gioie e le sofferenze della vita, questo è stato Bach: impossibile che abbia concepito la sua musica senza desiderare un crescendo, un forte, un piano, un accelerando o un diminuendo, accontentandosi di venire eseguito con meccanica perfezione senza profonda emozione. La Passione Secondo San Matteo è una delle opere più drammatiche e teatrali della musica di ogni tempo. Chi l'appiattisce in un grigio mezzoforte dall'inizio alla fine, offende Bach e la musica, come se egli non avesse saputo cosa fossero le emozioni. Bach possedeva una facilità naturale per tutti gli strumenti musicali e suonava il violino, la viola, il clavicembalo, il clavicordo e soprattutto l'organo. Non vi era nulla di troppo arduo sulla tastiera e insisteva nel dire che l'abilità era solo frutto di diligenza. Dopo aver eseguito un brano meravigliosamente, a un allievo che gli aveva manifestato ammirazione, disse, voltandosi con aria quasi di rimprovero: «Se lavorerai seriamente come lavoro io, riuscirai a suonare con altrettanta perizia. Non vi è nulla di meraviglioso in quello che faccio. Non avete che da battere la giusta nota al momento giusto e l'organo stesso fa il resto».Bach riuscì a formare una orchestra con la quale eseguiva le sue opere avendo a disposizione buona parte della famiglia. Lui si metteva al centro suonando la viola nell'orchestra e, da questa posizione orchestrale, poteva «bacchettare» i figli che sbagliavano e ascoltare tutti gli strumenti, dando indicazioni e suggerimenti ad ognuno dei componenti.Per far rivivere tutta intera la figura di Bach, bisogna considerare la sua profonda devozione che fu la qualità essenziale del suo carattere e che illuminò tutta la sua esistenza. Il suo sentimento religioso risulta evidente dalle partiture che hanno quasi tutte come intestazione le lettere S.D.G. (Soli De Gloria), ed è sincero e profondo. Nessuna testimonianza può rendere così viva l'immagine di Bach come quella di Anna Magdalena: «Rammento un giorno che lo sorpresi mentre scriveva l'a solo dalla Passione secondo Matteo “Ah, Golgota" e rimasi meravigliata nel vedere il suo volto in generale tanto colorito, divenuto d'un pallore mortale, mentre le lacrime gli sgorgavano dagli occhi. Egli non si avvide di me, così io uscii senza far motto e mi sedetti sulle scale piangendo. Avrei desiderato tornare da lui e buttargli le braccia al collo, ma non osai, tanto lontano mi parve lo sguardo dei suoi occhi. Così lontano che mi riempì di sgomento. Non mi aveva neppure sentito entrare e fui lieta che non se ne fosse accorto in verità. Era un momento in cui Dio solo doveva vederlo. La musica da lui composta su parole del Vangelo, esprime, a parer mio, nel modo più grandioso, il sentimento che deve suscitare in tutti i cristiani la contemplazione della croce e indubbiamente Sebastiano, prima di scrivere una sola nota di quella musica, ne sentì l'angoscia e la bellezza nell'intimo dell'anima sua».Per Bach la musica non era una pratica da piegare alle trasformazioni imposte dai gusti di ogni epoca, ma era una dottrina, un'Ars nel senso antico del termine, cioè un sapere immutabile del quale il musico ha il compito di impadronirsi. Su questo pilastro Bach costruì il fondamento della sua esistenza artistica. Fin dalla giovane età, egli nutriva un profondo interesse per i grandi musicisti della sua epoca. Suo fratello possedeva una collezione di composizioni di autori celebri. Era chiusa nella parte anteriore da una grata metallica, attraverso la quale tutte le notti, per mesi e mesi, il giovanissimo Johann Sebastian sottraeva i fogli per portarli nel suo abbaino e ricopiarli pazientemente al pallido chiarore della luna, perché non possedeva una candela. Naturalmente i suoi occhi ne soffrirono. Quando poi, compiuto il paziente lavoro, egli si accingeva a suonare la sua musica che gli era costata tanta fatica, suo fratello, scoprendo quello che egli considerava un delitto, gli strappava con violenza il manoscritto». Alla sua attività musicale Bach aveva dedicato l'intera vita, con la più grande energia e ferrea volontà. Si era dato alla musica senza esitazioni né pentimenti fin dai giorni dell'infanzia ad Eisenach. Soleva lavorare senza tregua fino a notte inoltrata alla debole luce della candela, lamentandosi sovente che gli occhi gli doloravano. Essi peggiorarono al punto che parecchie volte lo si vide cercare tastoni la maniglia della porta per entrare e uscire, gridando: «Debbo scrivere finché ci vedo, Magdalena!». Venne a Lipsia un famoso chirurgo inglese, un uomo che nella sua patria godeva di grandissima fama per le felici operazioni praticate in casi analoghi a quello di Johann Sebastian. Si chiamava Giovanni Taylor e alcuni amici insistettero perché Bach si valesse dei suoi servigi. Johann Sebastian non seppe resistere alle pressioni che gli si facevano e Taylor gli promise il più lusinghiero dei risultati. Così un giorno arrivò con i suoi strumenti e lavorò con essi intorno ai suoi poveri occhi che furono successivamente bendati. Quando finalmente le bende vennero tolte, Bach era diventato completamente cieco. Egli ebbe a soffrire più che per la perdita della vista, per la cura dopo l'operazione, in cui gli furono somministrati medicinali fortissimi che spezzarono la sua forte fibra e non gli permisero più di riprendersi nei pochi mesi che gli rimasero da vivere. Ma una grande e profonda serenità parve scendere su di lui in quelle ultime settimane di vita. La morte non solo non gli aveva mai incusso timore, ma gli era apparsa invece come una speranza alla quale si era sempre rivolto con piena e ferma fede. Essa rappresentava la vera sintesi di tutta la vita. Le Cantate che racchiudono le più belle melodie sono quelle in cui le parole esprimono l'idea della morte, della liberazione dell'anima dalle cose del mondo.Dimenticato ed estraneo quasi agli stessi suoi figli, le sue opere erano considerate sorpassate ai cultori della musica delle generazioni immediatamente seguenti. La musica di Bach ufficialmente non esisteva. Le corti e le Chiese per le quali quella musica era nata ne ignoravano l'esistenza e la validità artistica. La grandezza di Bach fu appunto riscoperta nei primi anni del diciannovesimo secolo, dando vita alla Bach Renaissance. Vi invito ad ascoltare Le Passioni Secondo San Matteo e San Giovanni, certamente non in chiave filologica, le Sonate e le Partite per violino solo, le Suite per violoncello suonate da Pablo Casals, le Variazioni Goldberg, I Concerti Brandeburghesi, Il Clavicembalo ben temperato, opere organistiche, i due concerti per violino, il doppio concerto per due violini di cui esiste una interpretazione storica di Yehudi Menuhin con George Enesco secondo violino.
Il neo sindaco di New York Zohran Mamdani (Ansa)
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 7 novembre con Carlo Cambi
Il luogo dell'accoltellamento a Milano. Nel riquadro, Vincenzo Lanni (Ansa)