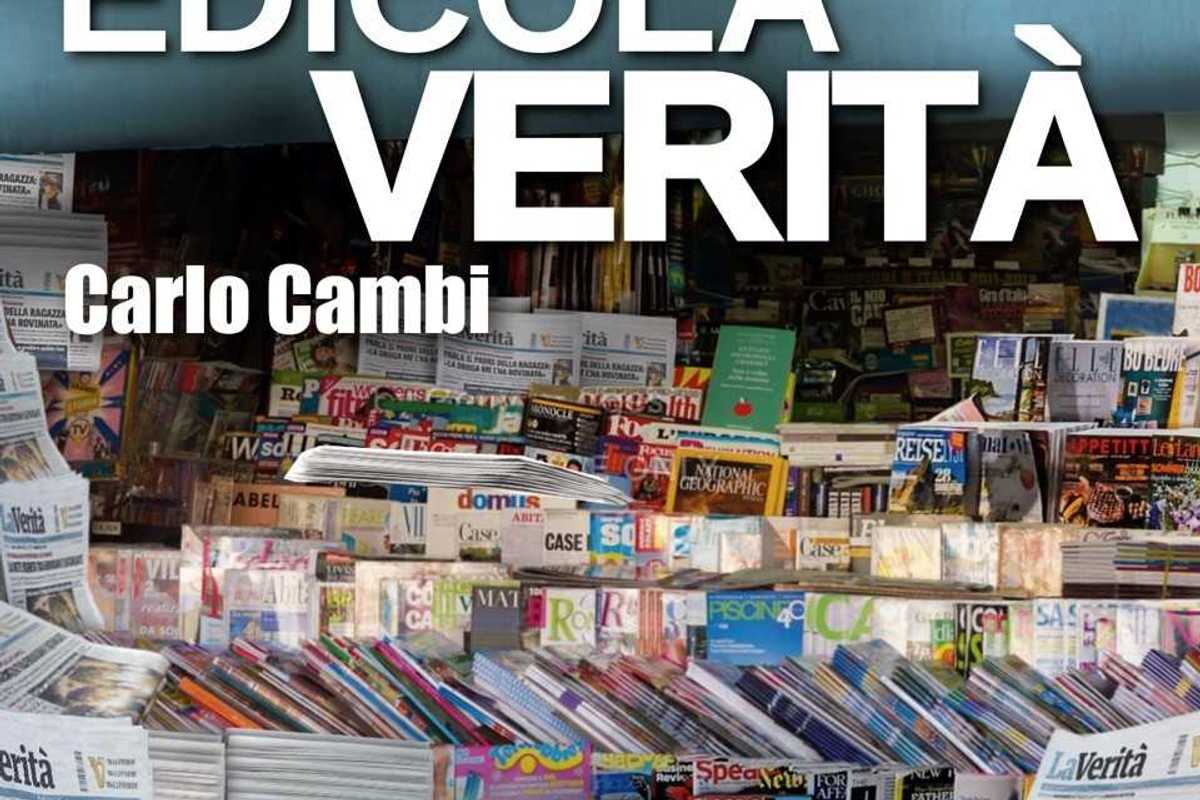Diversi autori e artisti sono attualmente impegnati nella ricerca di una selvatichezza perduta, di uno stato del sentire, del capire e del vivere regolati dall'istinto. Ecco perché i musei si sono riempiti di vegetazione, le librerie di volti di animali e foreste inchiostrate, le pagine dei giornali di coloro che invocano una deindustrializzazione pesante, quell'ecologismo integrale e talora gridato che vorrebbe placare tutti i mali del mondo. Una nuova illusione? Il tempo e le scelte delle nostre fragili democrazie quanto di ciascuno di noi singoli cittadini del mondo ce lo diranno. Ma restando al potere che la natura conserva nelle menti degli artisti, dei poeti, dei filosofi, che cosa possiamo andare a sbirciare dal nostro silente catalogo dei libri dormienti? Ad esempio William Blake (1757-1827), incisore e poeta quasi del tutto sconosciuto ai suoi contemporanei ma oggi idolatrato. Chi non ricorda il celebre «ritornello» tigre tigre di una delle sue più famose composizioni?
«Tigre! Tigre! Divampante fulgore/ Nelle foreste della notte, / Quale fu l'immortale mano o l'occhio/ Ch'ebbe la forza di formare la tua agghiacciante simmetria?/ In quali abissi o in quali cieli/ Accese il fuoco dei tuoi occhi?/ Sopra quali ali osa slanciarsi? / E quale mano afferra il fuoco?/ Quali spalle, quale arte/ Poté torcerti i tendini del cuore?/ E quando il tuo cuore ebbe il primo palpito, / Quale tremenda mano? Quale tremendo piede?/ Quale mazza e quale catena?/ Il tuo cervello fu in quale fornace?/ E quale incudine?/ Quale morsa robusta osò serrarne i terrori funesti? / Mentre gli astri perdevano le lance tirandole alla terra / e il paradiso riempivano di pianti?/ Fu nel sorriso che ebbe osservando compiuto il suo lavoro, / Chi l'Agnello creò, creò anche te?/ Tigre! Tigre! Divampante fulgore / Nelle foreste della notte, / Quale mano, quale immortale spia/ Osò formare la tua agghiacciante simmetria?».
La traduzione è stata compilata da Giuseppe Ungaretti, nonostante egli fosse poeta e mastro traduttore qui non riesce - ovviamente - a restituire nella nostra lingua, fluida, discorsiva, musicale, la sintesi e il gioco intraducibile che si conserva nell'originale. Ascoltiamolo:
Tyger! Tyger! Burning bright/ In the forests of the night: / What immortal hand or eye/ Could frame thy fearful symmetry?».
Una filastrocca. La letteratura, il cinema, la televisione e la musica hanno innalzato la voce oscura, tetra, simbolista, di questo poco letto poeta inglese, a vate luminoso a cui costantemente continuare a guardare, quasi fosse un neo-evangelista moderno. Basti pensare a quanta influenza la poetica di Blake abbia maturato in molti segmenti della più attuale produzione culturale, dalla televisione al cinema alla musica. Ad esempio la serie televisiva The Mentalist, nella quale gli appartenenti ad una setta segreta che proteggono l'anonimato dell'antagonista principale, il cattivo dei cattivi, si riconoscono grazie ad una parola d'ordine di matrice blakeiana. Oppure, facendo qualche capriola all'indietro, pensiamo agli amati The Doors, il celebre gruppo rock guidato da Jim Morrison, che prendevano il proprio nome proprio da un passo di una poesia di Blake: «Se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo com'è: infinita». Oppure ancora ai versi tatuati sulla schiena di uno dei malvagio dei romanzi di Thomas Harris, in un prequel de Il silenzio degli innocenti. E probabilmente non sono pochi i lettori che tornano alle sue incisioni, alle sue poesie cantabili, in attesa di folgorazioni spirituali, di verità teologiche e versi indimenticabili e indimenticati. Sono pochi i poeti dei nostri secoli che producono questo effetto, che richiamano i lettori, probabilmente fra i più attenti ed esigenti, totem viventi e veri e propri magneti della parola. Nel secolo che ci è radice, il «secolo breve» per citare la storiografia, l'unico comparabile è stato quel gallese spesso attaccato alla bottiglia che è stato Dylan Thomas; ma si potrebbe forse tirare in ballo anche l'Ezra Pound dei Cantos, se non fosse un'opera che eccede costantemente in citazioni e stratificazioni bibliografiche. Nemmeno i nostri poeti più religiosi, un Pasolini, un Luzi, un Turoldo, lo stesso Ungaretti, un Montale, o un mistico come Dino Campana probabilmente agitano il sangue di coloro che leggono quanto William Blake.
Ma torniamo agli animali. O meglio alla trasfigurazione della potenza di una tigre. A qualcuno sarà già tornata in mente Cristina Campo (1923-1977), altra figura in penombra, isolata per scelta, nella propria generazione. La tigre assenza è titolo di un suo celebre componimento che ora andremo a navigare, ma in seguito è stato adottato dalla casa editrice Adelphi per confezionare la selezione generale della sua poesia e delle sue traduzioni poetiche:
«Ahi che la Tigre,/ la tigre Assenza,/ o amati,/ ha tutto divorato/ di questo volto rivolto/ a voi! La bocca sola/ pura/ prega ancora/ voi: di pregare ancora/ perché la Tigre,/ la Tigre Assenza,/ o amati,/ non divori la bocca/ e la preghiera…».
Che cos'è questa assenza ruggente, digrignante? Pronta a divorare gli amati e gli amanti, la bocca quanto la parola pregata? Cos'è che si porta via tutta la nostra storia, la nostra identità e ci proietta dentro un vuoto, l'assenza, la mancanza? Siamo anche noi animali e dunque non così dissimili, oppure siamo addomesticazione, siamo calcolo, siamo ragione e ben poco sentimento? Esiste nell'umanità la selvatichezza, quella selvatichezza dei sentimenti prima che l'esperienza della vita corrompa la natura pura e veemente?
Un altro campo espressivo nel quale si evidenzia una vasta ricerca di primitività è senz'altro la fotografia. La fotografia naturalistica era annoverata, nei circoli fotografici, come una forma d'arte minore. Non più ora, visto che ogni anno anche in Italia si tengono decine di mostre dedicate agli animali, agli insetti, ai parchi, agli amati alberi. Ma per lungo tempo non è stato così. A parte singoli casi eccezionali, come l'americano Ansel Adams (1902-1984), uno dei padri di quel movimento eterogeneo composto di politici, scienziati, ricercatori, ambientalisti, viaggiatori, che ha portato prima alla nascita e poi alla diffusione sull'intero territorio nordamericano di parchi nazionali e statali. Proprio grazie a figure come quella di Adams ma anche di poeti della natura, quali John Muir o Henry David Thoreau, si è capito quanto fosse importante, fondamentale, preservare luoghi dove la natura opera così come aveva operato per millenni, anzi per milioni di anni prima dell'era del'Homo Sapiens. Gli alberi, le cascate, le cupole di marmo, i ghiacciai, le cime innevate, le foreste, le foglie, il riflesso delle lune negli specchi d'acqua, le nebbie, i cieli, le geometrie delle cortecce, i paesaggi, quanta meraviglia nelle spettacolari fotografie in bianco e nero di Ansel Adams, che non soltanto sono diventate dei classici, ma anche strumenti poiché servirono a irrobustire la crescente popolarità dei parchi naturali nei primi tempi del nascente turismo ambientalista; oggi questo turismo, lo sappiamo, è talmente diffuso da compararsi al turismo da museo, da grattacielo, da grande città. E che cosa vanno a cercare coloro che risalgono i tornanti delle montagne californiane se non quel sottile, quasi dimenticato, nervo animale, istintivo, primordiale che nella vita di ogni giorno viene sacrificato per rispettare le regole della convivenza sociale e per così dire civile?
Lo sentite dentro di voi animarsi quel «tigre tigre» blakeiano? O quella «tigre assenza» che ci porta a provare nostalgia della stessa nostalgia? Che cosa ci manca? Che cosa ci può completare? Un viaggio? Una camminata nel bosco? Un ritorno momentaneo alla vita elementare?