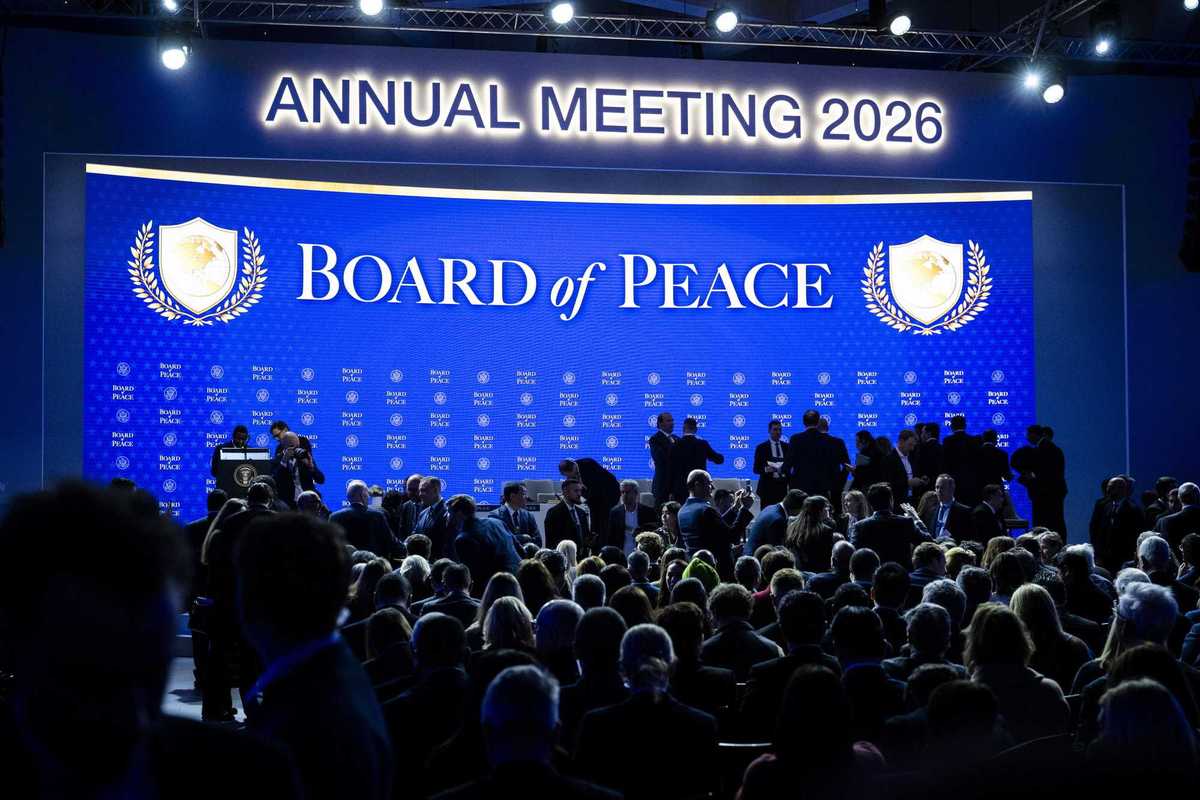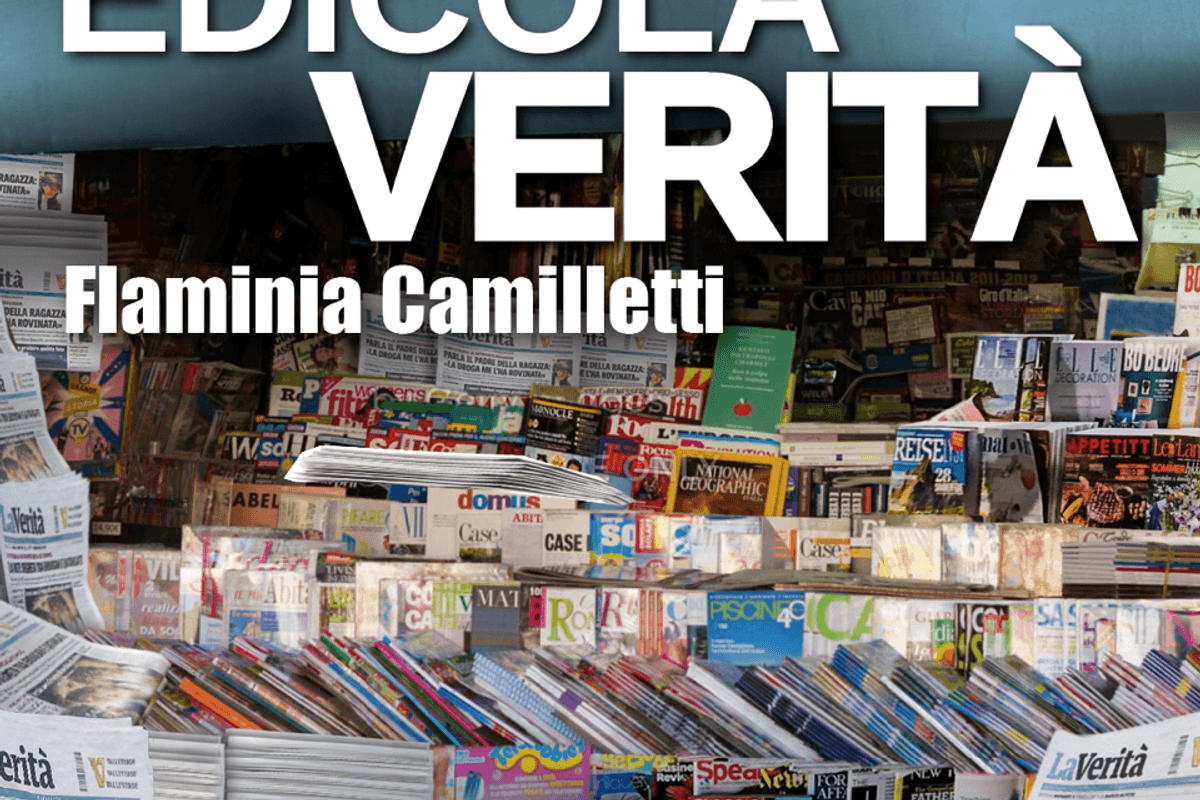Perché questa decisione e cosa comporterà in futuro?
«Sentivo il dovere e il desiderio di compiere questo passo in onore di mio padre e, ancor prima, di mio nonno, i quali hanno dedicato passione e impegno alla costruzione di questa azienda. Grazie a questa operazione, avvenuta proprio in un momento strategico, possiamo continuare a rispettare il nostro piano di espansione e crescita, con l’intento di soddisfare la richiesta del mercato con prodotti eccellenti, innovativi e su misura per i nostri clienti. Ringrazio le due storiche aziende che in questi anni hanno partecipato come soci del gruppo in maniera leale e corretta (la famiglia Brugola ha riacquistato l’80% delle quote della holding di partecipazione Abf srl, possedute dai due soci Agrati spa e Fontana Finanziaria spa: Abf deteneva il 30% del gruppo Brugola, ndr). Ho sempre visto l’azienda come un qualcosa di famiglia, è tutto per me. Non ho mire finanziarie o di quotazione in Borsa: sono un imprenditore vecchio stampo. So che è un passo, il mio, in controtendenza rispetto a quello che si vede oggi, con quote di società vendute a dei fondi, per esempio, ma seguo gli insegnamenti di mio padre, che a sua volta li ha ricevuti da mio nonno».
Le guerre in Ucraina e in Israele e le numerose tensioni internazionali come impattano sul mercato?
«Ovviamente la guerra in Ucraina è stato un’evento molto grave per noi, soprattutto per i risvolti sui costi. Gli scompensi maggiori, infatti, li abbiamo registrati sul fronte energetico, sulle bollette di luce e gas. Queste sono schizzate a livelli altissimi, rispetto al passato. Per fare un esempio, oggi l’energia e il gas ci costano il doppio rispetto al 2021. Ma nel 2022 questi costi si sono moltiplicati fino a sette volte. È chiaro che questo aumento dei costi energetici ci abbia creato delle difficoltà. Invece, almeno per il momento, la guerra e le tensioni in Medio Oriente non stanno avendo un impatto sul nostro lavoro».
Producete viti sia per motori endotermici sia per quelli elettrici. Cosa ne pensa di questa scelta dell’Europa di puntare tutto ed esclusivamente sull’elettrificazione della mobilità?
«Voglio essere subito chiaro: questa incertezza non fa assolutamente bene al settore. La Germania sta andando in recessione, le case automobilistiche non riescono a vendere i prodotti elettrici perché il mercato non li vuole ma nessuno si espone a tornare indietro, a tornare alle motorizzazioni termiche. C’è uno stallo del mercato che non va assolutamente bene. Noi, come Brugola, produciamo viti nelle parti critiche (quelle utilizzate nei motori ma anche negli pneumatici e in altre parti «sensibili», ndr) dei motori sia endotermici, sia elettrici. Però la situazione non può continuare così, bisogna che qualcuno prenda una decisione perché le persone, i clienti, stanno dimostrando che non hanno una gran passione per il solo elettrico. Come la mettiamo, allora? Lo stallo che si è creato porta alla crisi del settore automotive, che si traduce anche in tagli di posti di lavoro. Uno dei punti nodali su cui deve prendere posizione la prossima Commissione europea è proprio questo, bisogna dare alle aziende una direzione su cui investire. C’è bisogno di tornare a pensare che il motore endotermico è un qualcosa che, per così dire, ci appartiene e dobbiamo continuare a investire nella ricerca e lavorare per combustibili alternativi alla benzina. Io penso che l’idrogeno possa essere la soluzione migliore, in prospettiva. E nel mercato c’è spazio per tutti i tipi di motorizzazione, non dobbiamo essere talebani e decidere di percorrere una sola strada a discapito di altre che possono essere una valida, se non migliore, alternativa».
La strada da prendere, dunque, è quella di non imporre alcuna strada ma di lasciare aperte tutte le opzioni sulle motorizzazioni?
«Per prendere questa decisione, serve molta intelligenza. Ripeto, nel mercato c’è spazio per tutti: per il diesel che può tornare utile al rappresentante, all’elettrico per chi sta solo in città, al motore a benzina per chi ama auto più sportive. Nei giorni scorsi avevo qui in azienda i rappresentanti di Bmw e mi hanno raccontato di un’altra difficoltà che devono affrontare: quella relativa ai ritardi nella consegna delle auto. Le personalizzazioni anche motoristiche sono ormai troppe e questo causa inevitabilmente delle lungaggini. Ormai anche le grandi Case nutrono dubbi sulla bontà degli investimenti fatti per l’elettrico. E parlo di miliardi di euro, mi vengono i brividi e spero che non si rivelino soldi buttati. Dobbiamo fare le cose intelligenti e darci dei target realizzabili: il 100% elettrico non sarà mai possibile, il mercato non lo vuole, e poi dobbiamo pensare anche alle infrastrutture. Già in Italia, su questo aspetto, abbiamo delle evidenti differenze tra Nord e Sud. Se allarghiamo lo sguardo, posso affermare la stessa cosa per interi continenti, come l’Africa e l’Asia».
Il discorso della mobilità porta inevitabilmente a parlare del settore automotive in Italia: un settore che molti analisti vedono in smobilitazione visto i piani industriali di Stellantis. Davvero l’Italia sta perdendo anche questo settore?
«I problemi in questo settore ce li trasciniamo dietro da anni perché nessuno ha davvero idea di fare, o di voler fare, qualcosa di concreto. Abbiamo le competenze, sappiamo fare le cose bene ma quello che manca è l’intenzione di farle, queste cose. La fine del comparto, almeno in Italia, mi pare segnata. Basterebbe prendere a esempio due case come Hyundai e Kia: vendono sette milioni di pezzi, hanno un buon design, sono al passo con i tempi e hanno prezzi competitivi. Da noi, invece, che è successo nel frattempo? Solo tante chiacchiere e, alla fine, siamo arrivati al punto che non sappiamo neanche se sopravvive un marchio come Maserati. Di quello che sarà il destino di Fiat si sa poco, ormai è tutto a guida francese. Per certi aspetti, non è più neanche un problema italiano. O, meglio, il problema italiano è la chiusura delle fabbriche per decisioni che vengono prese altrove. È un peccato».
Molte aziende lamentano il fatto di non riuscire a sopperire con i giovani alle uscite dei propri dipendenti per la pensione. Riscontrate anche voi questo tipo di problemi?
«Si, lo abbiamo riscontrato anche noi. Accogliamo tutti quelli che vogliono fare colloqui. Portiamo a casa i giovani, ma ce ne sono pochi in giro che vogliono lavorare. Per un’industria come la nostra, per avere successo per i prossimi dieci anni, bisogna andare avanti spediti con l’automazione, e per questo abbiamo fatto importanti investimenti nei macchinari negli ultimi mesi, e alzare continuamente il livello del prodotto. Ma il vero problema è quello di mantenere le competenze: se non si avranno, tra alcuni anni, a disposizione dipendenti che sappiano stampare delle viti o fare altri lavori legati alla meccanica, sarà una situazione grave non solo per noi, ma per il mondo intero. In fabbrica una volta la gente ci veniva di corsa, oggi, invece, è vista come un posto di lavoro da sfigato. E questo è molto preoccupante. Noi offriamo retribuzioni che sono il 20% più alte di quanto offrono altre realtà dello stesso settore, non sottopaghiamo nessuno: un operaio di primo livello ha una busta paga di 1.800 euro netti al mese. Riteniamo giusto che chi lavora per noi prenda uno stipendio che gli consenta di vivere una vita decente. Recentemente abbiamo distribuito fino a 2.300 euro di bonus produzione a tutti i nostri operai. La sfida del futuro si vince con le competenze».