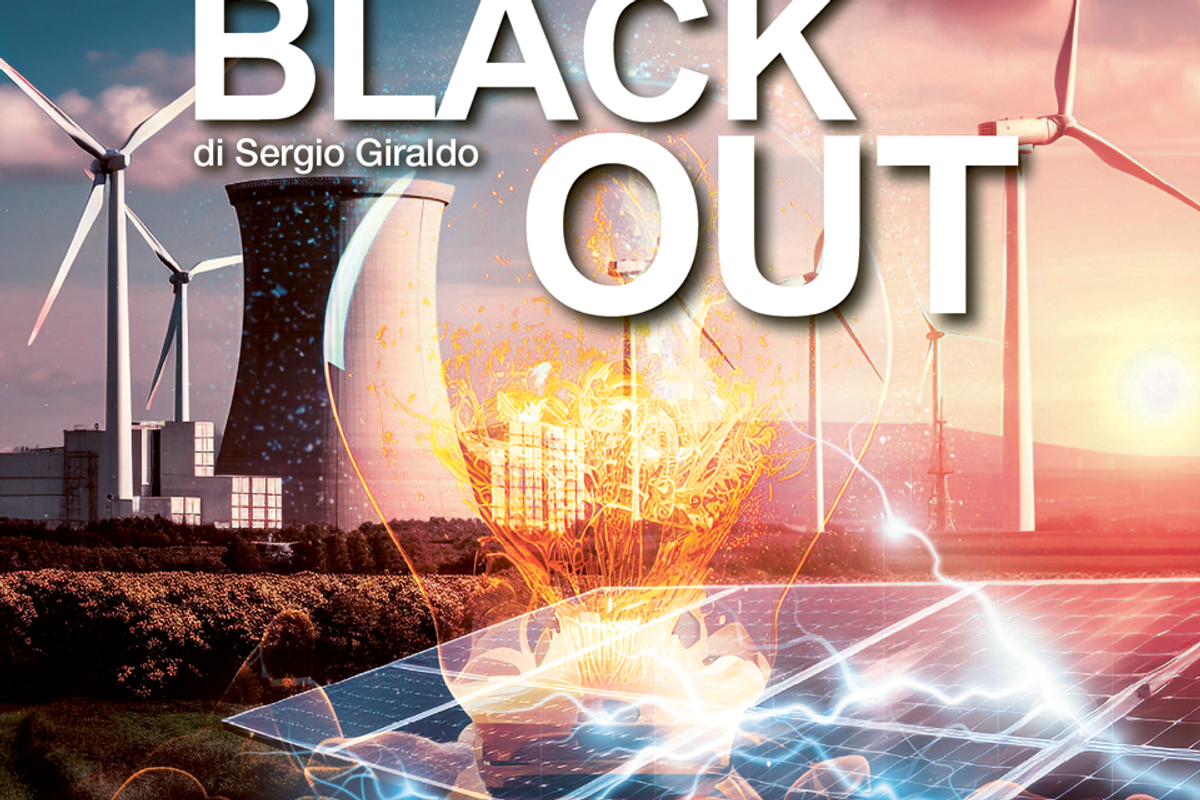Dal «Fate presto» a «può fare bene». L’inversione a U sul debito pubblico

Dicono i maligni che dietro la prosa di Francesco Giavazzi ci sia la mente di Mario Draghi. Se è così, la prima pagina del Corriere della Sera di ieri ospitava un editoriale due volte interessante, dal titolo «Il debito pubblico a volte fa bene».
Il primo motivo di curiosità è l’evoluzione, diciamo così, della sensibilità del quotidiano che si suppone informi i pensieri della cosiddetta classe dirigente. Sono lontani i tempi in cui, per esempio, l’ex direttore Ferruccio de Bortoli scriveva, sempre sulle pagine di via Solferino il 16 novembre 2016, un editoriale in cui spiegava così: «È irrilevante [...] se il debito è fatto per coprire spese correnti, come pensioni e stipendi, anziché investimenti. Il debito cattivo cattura consensi, quello buono no. Forse li fa perdere. I giovani che lo erediteranno tutto, buono e cattivo, esprimono il loro disagio andandosene». Oggi, Giavazzi, a 13 anni dal «Fate presto» del Sole 24 Ore che inaugurò festoso l’era Monti (il quale peggiorò il rapporto debito/Pil), presenta incredibilmente lo stesso senatore a vita come antesignano della lotta all’austerità: «oltre trent’anni fa» cominciò a sostenere che «dal freno al debito dovessero essere esclusi gli investimenti pubblici», ma poi da Palazzo Chigi non ha insistito più di tanto. Non solo: «L’affermazione “il debito è un modo per trasferire sui nostri nipoti il costo dei servizi di cui gode la nostra generazione” è sbagliata, o almeno incompleta». Affermazione ripetuta in modo ossessivo dal Corriere per decenni, in ottima compagnia di giornalisti e politici, dal Quirinale in giù: ma è sempre bene imparare dai propri errori ed essere disponibili a cambiare idea.
Curiosamente, quando c’era da difendere lo stesso Monti, che un’importante testata internazionale aveva definito inadatto alla guida dell’Italia, il 22 gennaio 2013 lo stesso Giavazzi era sceso in campo con Alberto Alesina (scomparso purtroppo nel 2020) dicendo che «senza austerità, in Italia come in altri Paesi europei, non vi sarebbe stata più crescita ma spread alle stelle, una probabile ristrutturazione del debito, scricchiolii nei bilanci delle banche: insomma, il rischio di un altro 2008». Anche perché, come spiegavano i due in un libro chiamato proprio Austerità (Rizzoli, 2009, prefazione di Ferruccio de Bortoli), «L’austerità può essere espansiva? Sì, quando la riduzione della spesa pubblica è più che compensata dalla crescita delle altre componenti della domanda aggregata».
Ovviamente si può obiettare che da allora a oggi è cambiato tutto, e quindi anche gli orientamenti di politica economica e monetaria si sono adeguati alla realtà. Resta il fatto che l’austerità espansiva era una contraddizione in termini ieri come allora, e il debito pubblico non ha mutato natura (problema da gestire era, problema da gestire rimane). Soprattutto, né Giavazzi né gli alfieri del «debito pubblico fardello per le nuove generazioni» hanno mai detto che stavano cambiando idea, né fornito motivi adeguati.
E qui veniamo al secondo motivo di interesse del pezzo di ieri, che aggiunge un tassello all’inversione a «U» rispetto alla rotta tracciata ai nostri danni nell’agosto 2011 con la celebre lettera della Bce (a doppia firma Draghi-Trichet). Allora, si chiedevano all’Italia «ulteriori misure di correzione del bilancio»; «un fabbisogno netto dell’1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013», da realizzare «principalmente attraverso tagli di spesa», a cominciare da pensioni e salari nel pubblico; di mettere «sotto stretto controllo l’assunzione di indebitamento [...] per decreto legge». È un fatto che si fece così, e che non andò benissimo. Nel 2020, la prima sterzata. In pieno lockdown, lo stesso Draghi affida al Financial Times uno storico editoriale in cui afferma: «È chiaro che la risposta che dovremo dare a questa crisi dovrà comportare un significativo aumento del debito pubblico. La perdita di reddito nel settore privato, e tutti i debiti che saranno contratti per compensarla, devono essere assorbiti, totalmente o in parte, dai bilanci pubblici». Pochi mesi dopo, al Meeting di Rimini 2021, in un colpo di genio situazionista assimilabile al «whatever it takes», lo stesso Draghi estrae dal cilindro la teoria del «debito buono»: «Questo debito, sottoscritto da Paesi, istituzioni, mercati e risparmiatori, sarà sostenibile, continuerà cioè a essere sottoscritto in futuro, se utilizzato a fini produttivi, ad esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca: se è cioè “debito buono”. La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà considerato “debito cattivo”».
Con tempismo degno della nottola di Minerva, Giavazzi accompagna con discrezione il riposizionamento sul debito (del resto, diversi discorsi di Draghi sono plasmati su articoli del professore, che seguirà Supermario a Palazzo Chigi come consigliere, come del resto aveva fatto con Monti). Il 21 aprile di quest’anno l’editorialista realizza che «se indebitarsi oggi per investire consentirà ai nostri nipoti di vivere in un continente libero e che cresce perché collocato sulla frontiera della tecnologia, ripagare il debito sarà un onere minore. Anche perché il debito pubblico non deve necessariamente essere ripagato: l’importante è ridurre il rapporto tra debito e Pil e questo dipende dalla crescita. Alla scadenza il debito pubblico può sempre essere rimborsato riemettendo altri titoli». Passa qualche mese e - 27 ottobre 2024 - sempre sul Corriere nota che «il punto di arrivo - o forse dovremmo dire di ripartenza - è tanta spesa pubblica, e senza alzare troppo la pressione fiscale, altrimenti persone e imprese si sposteranno altrove. È un’equazione che solo il debito può risolvere», fino alla consacrazione di ieri: il debito «fa bene».
Basta aspettare: una «svolta culturale» alla volta, e scopriranno che il Patto di stabilità non ha senso e pure l’euro qualche difetto ce l’ha.