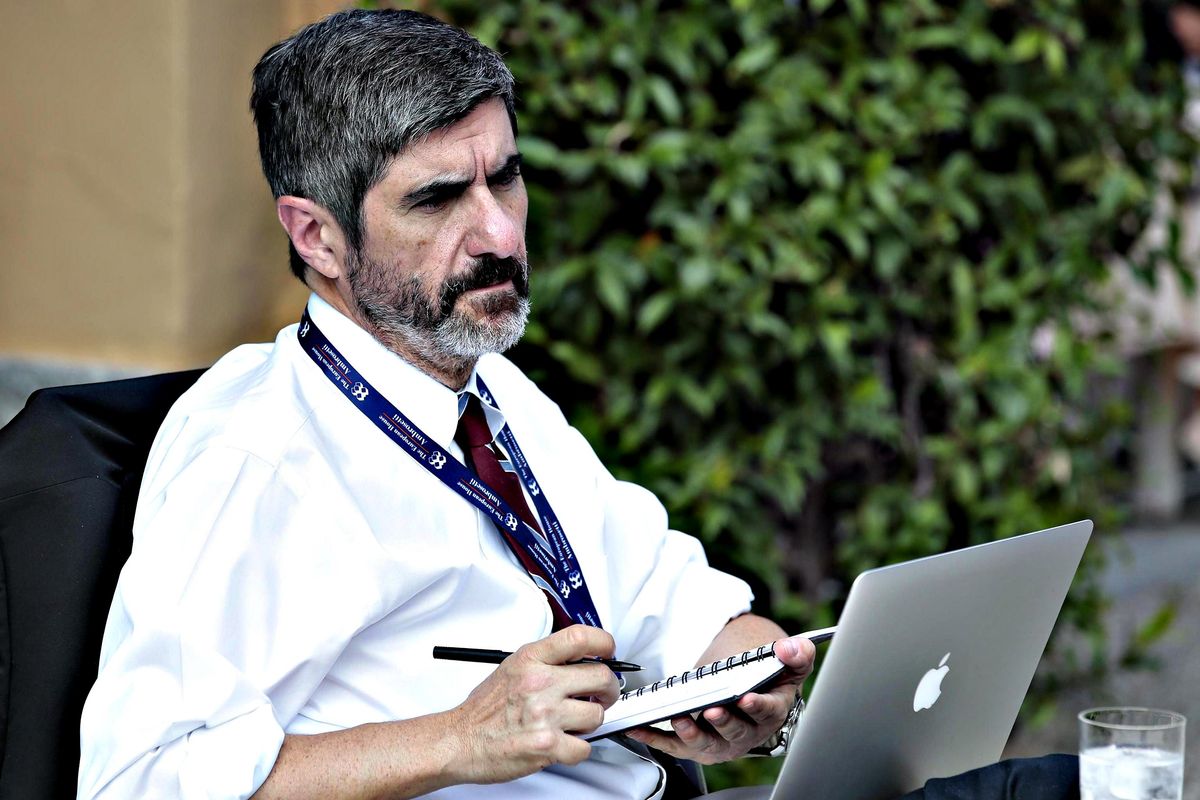
Sarà pure vero, come diceva Michele Serra qualche giorno fa su Repubblica, che ricondurre la destra a vino e buon cibo e la sinistra alla farina di insetti significa «non sapere nulla e non aver letto niente». Sorge però un dubbio: perché la sinistra stessa in questo schematismo un po’ naif tratteggiato dalla deputata di Fdi, Alessia Ambrosi, sembra trovarcisi a meraviglia? Perché fior di giornalisti e intellettuali liberal si sono gettati a corpo morto, come se non vedessero l’ora, sulle tesi decostruzioniste dello storico dell’alimentazione Alberto Grandi che sul Financial Times ha ricondotto la cucina italiana a fatto recente e iper ibridato? Ci deve essere un’implicita, ma potentissima, ragione antropologica, pre culturale, nell’eccitazione che porta Gianni Riotta a twittare che «la “tradizione” enogastronomica italiana, come tutte le tradizioni, è stata creata, in buona parte, sorry guys, in America» (si noti l’inciso: «come tutte le tradizioni»: gli States come l’Agarthi guénoniana da cui si dipana ogni sapienza…). Allo stesso modo, pare lecito interrogarsi su cosa spinga Francesco Merlo a rispondere con violenza al lettore di Repubblica che vantava un po’ ingenuamente la «purezza» dei nostri piatti con un lapidario: «Lei è in disaccordo con la storia e con la vita».
Perché va bene tutto: degli eccessivi entusiasmi per il tricolore, per l’aeronautica o per la riforma Gentile bisogna diffidare per l’odore di Regime che è restato loro addosso, ma per ringhiare così di fronte a un piatto di carbonara che scusa hanno?
Eppure, checché ne dica Grandi, pochi tratti identitari sono così perduranti nella storia di quello che vede nell’Italia la terra del mangiar bene. Ovviamente a perdurare non sono gli ingredienti o le ricette, che grazie a Dio si evolvono e si contaminano, ma due cose: la predisposizione del nostro territorio ad accogliere una incredibile biodiversità e l’oggettivo genio italiano per la lavorazione di suddette materie prime. La prima caratteristica era già nota a Strabone, nel I secolo a.C.: «L’Italia è soggetta a condizioni assai varie di clima e di temperatura, e questo fatto le comporta, in bene e in male, di avere anche una grande varietà di animali e di piante e in generale di tutto ciò che serve ai bisogni della vita». E quando, nel VI secolo, il generale bizantino Narsete invita i longobardi a lasciare la Pannonia per entrare in Italia, li alletta mandando loro, attraverso degli ambasciatori, «molti campioni di frutta e di altri prodotti di cui l’Italia è feconda». Con la centralità di Roma, il nostro Paese fu crocevia di scambi «globali» e importò prodotti da mezzo mondo. «Nelle nostre campagne», ha scritto Piero Bevilacqua in Felicità d’Italia (Laterza), «già in età antica le popolazioni contadine avevano consuetudine con una straordinaria biodiversità agricola insieme a un repertorio non comune di varietà delle stesse specie». Successivamente, oltre ai prodotti importati da colonizzatori arabi, per lo più dall’India, rilevante fu la cultura cittadina. Basti pensare che, al momento dell’Unità, si contavano in Italia 7.721 Comuni contro gli appena 1.307 della Francia, che ha un’estensione quasi doppia. Ed è nella città che si radica l’identità culinaria italiana, come testimoniato ancora oggi dai nostri menù: bistecca fiorentina, risotto alla milanese, saltimbocca alla romana, pizza napoletana etc. Ad ogni modo, come ricorda Massimo Montanari ne La cucina italiana: Storia di una cultura (Laterza), già nel Trecento, «all’interno della più grande koiné europea, una particolare attenzione si prestava alla dimensione “italiana” della cultura gastronomica, nelle sue molteplici varianti locali». Poco dopo, «nella seconda metà del Quattrocento, l’ambito “italiano” dei riferimenti culinari è ormai compiutamente delineato». Ancora in Les dons de Comus ou les délices de la table, del 1739, scritto forse da due gesuiti francesi, si poteva leggere: «Gli italiani hanno educato tutta l’Europa e son loro senza dubbio che ci hanno insegnato a far da mangiare». Certo, nessuno inventa nulla da zero o vive al riparo dalle ibridazioni. Pensiamo solo alla pizza, il cui nome, con una zeta sola, compare per la prima volta nel 997, nel Codex cajetanus di Gaeta. Non c’è nulla di originale, nulla che la distingua dalla pita greca, ebraica e araba o dal naan indiano. Eppure, a partire da una base così elementare e universalmente diffusa, la pizza è diventata icona di italianità e di buona tavola, le sue parenti orientali no. Lo stesso dicasi per la carbonara: sarà anche vero, come dice Grandi, che è solo «la tipica colazione americana (uova e bacon) con in più la pasta». Ma noi vi abbiamo estratto una leccornia, loro no. Come direbbe Riotta: sorry guys.





