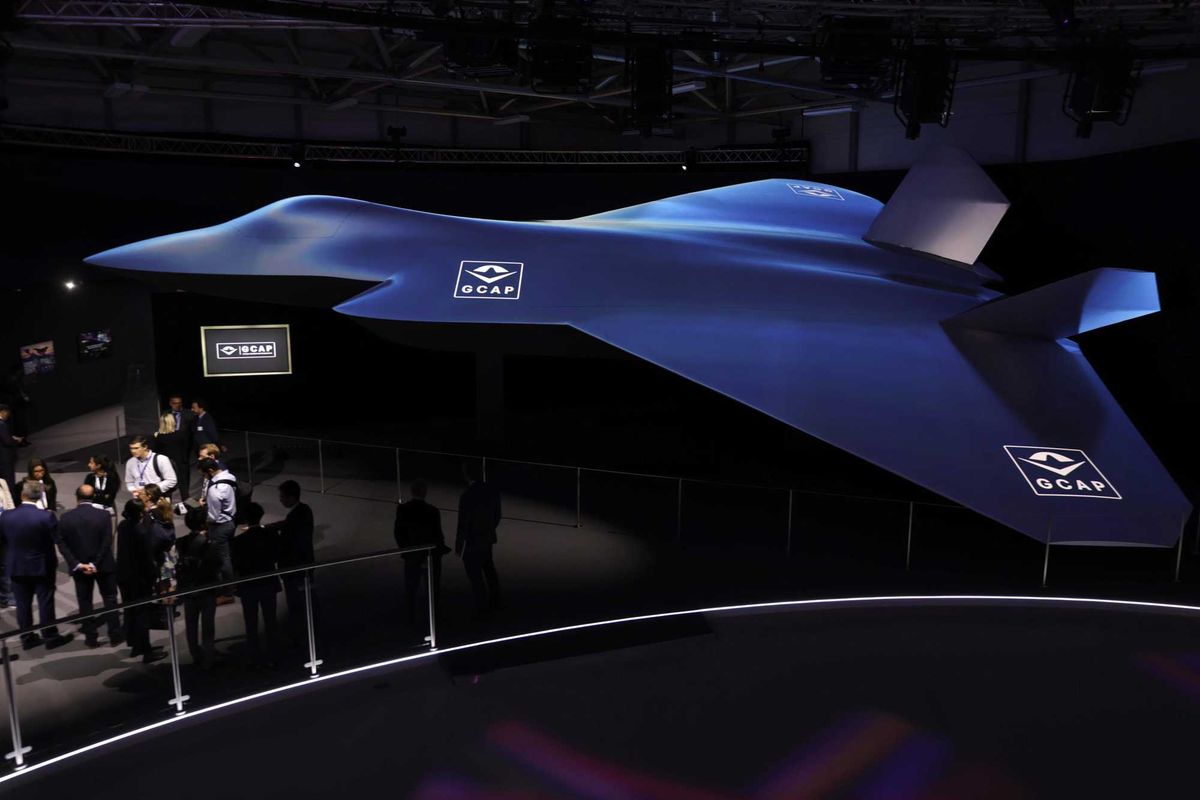«Non è colpa dell'Istat se nel paniere sono state inserite le auto elettriche, i monopattini, ecc. Non c'è alcuna richiesta europea. La verità è un'altra».
Quale presidente Blangiardo?
«Ogni anno l'Istat seleziona i prodotti da inserire nel paniere utilizzato per rilevare i prezzi al consumo e quindi stimare l'inflazione. I criteri sono rigorosi, oggettivi e quantitativi. Ricordo che il paniere è costituito da 1700 prodotti elementari ed ogni anno inseriamo delle novità in rapporto alla loro incidenza sul consumo».
È arrabbiato, ma non troppo il presidente Gian Carlo Blangiardo. È abituato alle critiche e alle polemiche dei media, anche quando il suo istituto non ha alcuna colpa. Quando sono stato invitato in via Balbo, nella storica sede dell'Istat, era il 4 febbraio. Esattamente un anno fa Gian Carlo Blangiardo (il 4 febbraio 2019) varcava il portone di questo austero palazzo per cominciare il suo lavoro di presidente. Aveva 70 anni e insegnava demografia all'Università Bicocca di Milano dal 1998. Ma si era anche occupato, come ricercatore, all'Università statale e alla Cattolica di Milano, di metodologia statistica, sempre di demografia e di statistiche sociali . È sempre stato considerato un accademico, mai militante in alcun partito o movimento politico. Come studioso di demografia veniva interpellato spesso dagli imprenditori, sindacati (soprattutto Cgil e Cisl), università e dai più diversi centri studi.
Eppure un anno fa il professor Blangiardo era stato oggetto di una campagna di stampa (soprattutto del gruppo Espresso-Repubblica) solo perché era stato proposto dal governo gialloblù alla presidenza dell'Istat e forse per il fatto di essere milanese veniva definito da quei giornali «l'ultrà leghista di Salvini». Ma all'istituto nessuno si è accorto che il presidente abbia mai manifestato simpatie leghiste. Comunque non esistono dichiarazioni, interviste o altri atti che possono testimoniare la sua presunta «fede leghista».
In ogni caso, anche se si fosse manifestato un intento politico di quel tipo non credo si possa classificare come un reato. In passato, più di un presidente di sinistra ha scavalcato senza alcuna critica pubblica il campo della neutralità. Qualcuno si è distinto come militante di sinistra e uno è diventato successivamente ministro (seppure tecnico) in un governo politico. Ma il professor Blangiardo è sereno e risponde a tutte le domande.
Presidente, l'Italia è ferma: l'inflazione allo 0,2% da novembre 2018 a novembre 2019; il pil è salito dello 0,1% nel terzo trimestre 2019 ; è calato il clima di fiducia delle imprese industriali (sotto i cento punti a fine 2019); la disoccupazione sempre vicina al 10%. Stiamo scivolando verso una stagnazione, che può diventare permanente, se non recessione?
«Certo, dalla stagnazione si può arrivare alla recessione. L'attuale andamento della nostra economia è altalenante. Il sistema economico e, in particolare, quello industriale, è sempre più debole. Prima della flessione del quarto trimestre dell'anno scorso il pil era cresciuto dello 0,5%. Più che di stagnazione parlerei quindi di crescita molto debole. Ma con la “caduta" del quarto trimestre, si è registrata una crescita zero, rispetto alla fine del 2018, e uno strascico negativo sul 2020. C'è comunque da ricordare che la flessione del pil nel nostro Paese è stata determinata anche da fattori negativi, ciclici e congiunturali, comuni a diversi Paesi dell'area dell'euro, come la Francia, che ha subito una flessione dello 0,1%. In sostanza, vorrei sottolineare che se il pil non cresce, la struttura economica diventa sempre più debole, più a rischio».
È facile chiederle: a questo punto quale può essere la terapia per risollevare le nostre sorti?
«Credo che ognuno deve fare la propria parte, senza ipocrisie e fughe in avanti, senza demagogie».
Un esempio?
«La povertà è diminuita o no? Le misurazioni statistiche di questo fenomeno sono molto complesse. Nel corso del 2019 sono state messe in campo misure che potrebbero diminuirla. Una risposta certa l'avremo a maggio a conclusione di una rilevazione attualmente in corso».
Poi c'è il grande problema della produttività che non cresce più.
«Certo, non solo la produttività, ma anche la capacità di investire. Abbiamo analizzato il fenomeno, che penalizza soprattutto le piccole imprese del nostro Paese: queste difficoltà si sono accentuate soprattutto a partire dal 2011. Aggiungiamo che da un nostro rapporto risulta che nel 2018 la produttività del lavoro è diminuita dello 0,3% e nel periodo 2014-18 è aumentato il divario della crescita della produttività del lavoro tra l'Italia (+0.3% annuo) e l'area euro (+1%). La produttività è quindi diminuita in quanto il pil è cresciuto (+0,1) meno delle ore lavorate (+0,4); il secondo dato conferma il primo anche nel lungo periodo e certifica il divario crescente tra l'Italia e l'area euro».
Ma perché non si discute mai di un problema centrale, come è appunto la produttività?
«È vero. La ragione credo vada ricercata nella crisi, ormai irreversibile, del nostro sistema industriale basato dal dopoguerra sulle piccole e medie imprese che possono essere in difficoltà di competitività nei nuovi scenari globali. In passato qualche presidente del Consiglio esaltava questo modello. Ma in seguito la forte crescita delle innovazioni tecnologiche e l'esigenza di spostare le produzioni verso unità produttive di maggiori dimensioni ha fatto entrare in crisi l'attuale sistema».
E i governi, che si sono alternati negli ultimi anni, non sono stati in grado di dare una concreta risposta ai problemi legati alla competitività internazionale. Ma del resto, non si tratta solo di questo. Ad esempio, oltre 100 miliardi di euro rimangono nelle casse della pubblica amministrazione perché non si riescono a investire in opere pubbliche, già progettate o iniziate, di cui abbiamo molto bisogno.
«Questo sarebbe il modo più efficace per incrementare il pil. Ma si tratta di scelte politiche su cui, per il mio ruolo, preferisco non esprimere pareri».
Ma un Paese che non crea più ricchezza e sceglie di incrementare il debito pubblico (aumenta ormai a un ritmo di 60-70 miliardi l'anno), si può permettere spese gigantesche come il reddito di cittadinanza e quota 100?
«Vorrei precisare che, dalle indagini Istat, il debito pubblico è aumentato di 36,5 miliardi di euro nel 2015, di 46 nel 2016, di 43,4 nel 2017 e di 51,6 nel 2018. Il livello del debito pubblico, a fine 2018, è pari a 2380 miliardi euro. Ovviamente sul deficit pubblico pesa molto la spesa per interessi che però, negli ultimi quattro anni, appare decrescente, passando dai 68,1 miliardi del 2015 ai 64,7 miliardi del 2018».
E i costi per il reddito di cittadinanza? È stato calcolato che questa spesa assorbirà nel triennio 2020-2022 ben 26 miliardi di euro, che aggiunti ad altri 9,7 miliardi che dovrebbero essere destinati alle politiche attive per il lavoro fanno più di 35 miliardi (fonte Uninpresa). Per quota 100 le cifre sono più ridotte: 23 miliardi investiti in quattro anni dal 2019 al 2022 (fonte Banca d'Italia).
«Purtroppo non abbiamo ancora dati precisi su queste due spese sociali. Ma anche in questi casi vorrei precisare che si tratta di scelte politiche del governo e del parlamento».
La spesa previdenziale certamente cresce.
«In totale quella pensionistica ha raggiunto i 293 miliardi di euro l'anno (+2,2% rispetto al 2017), con una incidenza sul pil del 16,6%. I beneficiati sono 16 milioni, con un importo medio lordo di 1469 euro mensili per quelle di vecchiaia (17.634 l'anno), mentre l'assegno non supera i 500 euro mensili per le pensioni assistenziali. In media si calcolano 259 pensionati ogni 1000 abitanti. Si è ridotta la percentuale (di sei punti) tra gli occupati e i pensionati: 606 in pensione ogni 1000 con un lavoro (erano 683 nel 2000). Questo significa che la situazione è peggiorata e che il rischio povertà è aumentato».
Nonostante il reddito di cittadinanza. E sono aumentati anche gli italiani che si sono trasferiti all'estero per lavoro. È stato calcolato che dal 2002 al 2017 sono emigrate dal Mezzogiorno oltre due milioni di persone (fonte Svimez). Una parte è rientrata, ma il saldo è comunque negativo.
«Anche l'Istat ha accertato che negli ultimi dieci anni 816 mila italiani sono emigrati. Solo nel 2018 sono stati 157.000 (+1,2% rispetto al 2017). E quel che è peggio - a differenza delle migrazioni del passato - è che il 73% hanno più di 25 anni e che, di questi, quasi tre su quattro hanno un livello di istruzione medio-alto. È curioso che dalla Regione più industrializzata del nostro Paese (la Lombardia) emigrano più italiani; seguono Veneto, Sicilia, Lazio e Piemonte».
E l'emigrazione sud-nord è sempre alta.
«Noi la chiamiamo “mobilità interna". Negli ultimi dieci anni sono stati un milione e 115.000 i lavoratori che si sono spostati dal Mezzogiorno nelle Regioni del centro-nord. Almeno 117.000 sono i trasferimenti di residenza sud-nord. Solo dalla Sicilia e dalla Campania si sono trasferiti al nord 8500 giovani laureati».
Soltanto di recente c'è una maggiore attenzione, almeno nel dibattito pubblico. E i politici hanno scoperto questo problema. Anzi qualcuno ha cercato di giustificare l'immigrazione con la riduzione costante della nostra popolazione.
«Allora precisiamo che dal 1861 il numero dei nati in Italia è stato sempre alto, ma negli anni più recenti si è interrotto. Solo in un anno dai primi nove mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, la natalità si è ridotta del 2%, che significa 10.000 nati in meno . Nell'intero anno 2019 si sono registrati 193.000 nati in meno e almeno altrettanti nel 2020».
L'immigrazione non compensa questi cali di natalità?
«No. Complessivamente abbiamo perso 400.000 persone rispetto alla popolazione passata. È un fenomeno che ci impoverisce».
Soprattutto se aggiungiamo l'invecchiamento della nostra popolazione.
«Certo, ogni giorno che passa… Le coppie fanno fatica a fare figli. Pensano prima al lavoro, a farsi una casa e dopo programmano un figlio. Ma spesso sono di età avanzata; al massimo riescono a fare solo un figlio… Si chiama tutto questo la crisi del primogenito».
Come intervenire?
«È un problema aperto in tutta Europa. Diversi Paesi (Gran Bretagna, Francia, Germania, ecc.) cercano di fronteggiare questo fenomeno incentivando al massimo le giovani coppie a procreare (contributi economici, detrazioni fiscali, servizi gratuiti ed efficienti, ecc.). Noi siamo fermi al bonus bebè e penalizziamo il ceto medio, oggi il più tartassato».