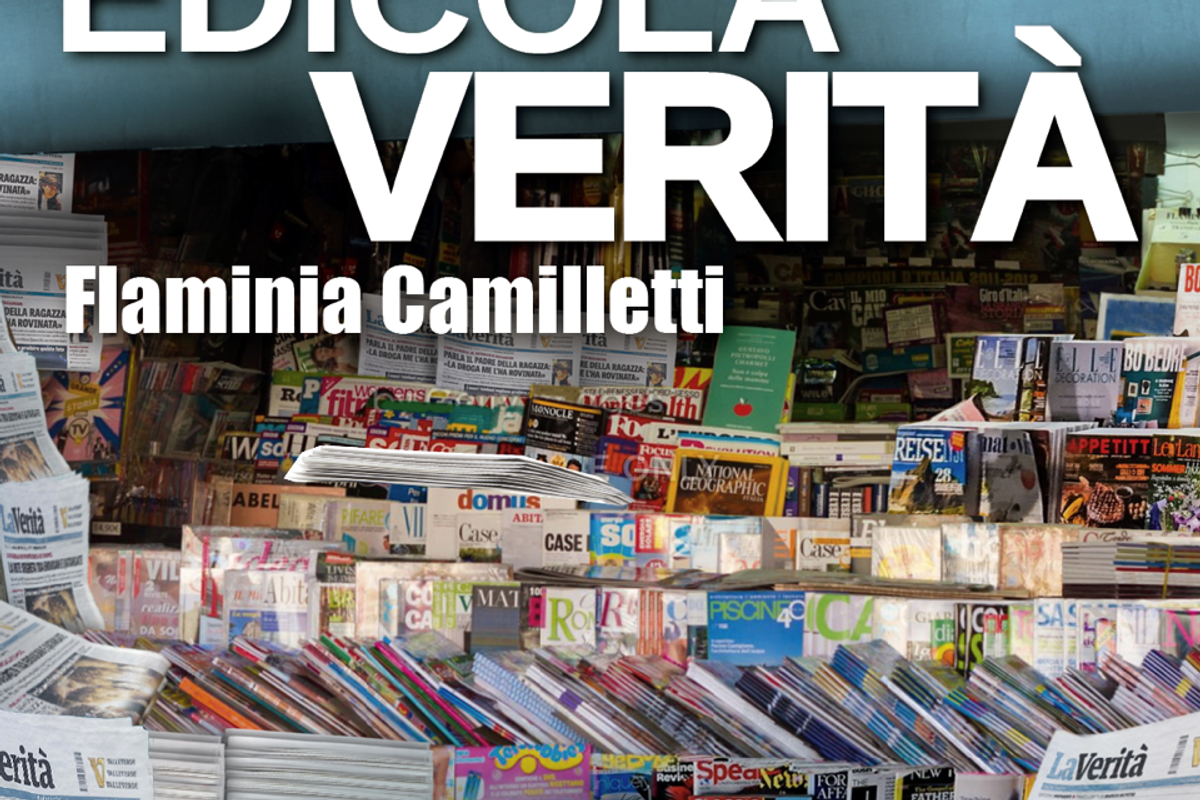2022-03-23
Il progresso ha un debito col cristianesimo
La statua di Copernico a Varsavia (IStock)
La fede è spesso ritenuta ostile alla scienza. Falso: molte scoperte tecnologiche sono avvenute nell’epoca più religiosa, il Medioevo. La Chiesa ha inoltre dato impulso all’istruzione e grandi scienziati come Niccolò Copernico, Galileo Galilei e Isaac Newton erano profondamente credenti.Se l’influenza della religione, specie del Cristianesimo, nella formazione dei valori occidentali può dopotutto incontrare una condivisione anche ampia, il discorso cambia decisamente quando si affronta il rapporto tra fede e scienza. Sono infatti ancora molti coloro che ritengono insanabile il conflitto tra il sacro e lo scientifico, guardati come due paradigmi in costitutivo contrasto tra loro e dinanzi ai quali ciascuno è tenuto a scegliere, dato che entrambi portatori di verità, si pensa, non possono essere. O si crede in Dio o si fa scienza. […] Ebbene, per farla breve, una simile visione, benché radicata in ambito accademico e accompagnata da studi secondo cui i credenti sarebbero meno intelligenti degli atei, non è solo parziale: è fuorviante. […]La scienza è davvero fiorita nell’Europa cristiana, che conobbe un impressionante sviluppo tecnologico già durante la fase medievale, durante la quale il continente dipendeva essenzialmente dall’organizzazione ecclesiastica. Per la verità, parecchi sono gli aspetti interessanti del Medioevo, epoca che, nonostante i conflitti da cui fu attraversata, fu di relativa stabilità soprattutto nel Vecchio Continente, come prova il fatto che i re cristiani furono politicamente assai più longevi dei sultani musulmani. L’arco temporale compreso tra i secoli V e XV, a livello europeo, fu però anzitutto una fase di crescita culturale e di progresso tecnologico.La crescita culturale fu garantita, da contributi in tanti campi ma, ancor prima, dalla custodia di opere classiche che rischiavano la distruzione e che, invece, furono conservate nei monasteri e in alcuni casi direttamente all’interno delle grandi cattedrali allora costruite. Se ancora oggi possiamo leggere e studiare autori come Platone, Aristotele, Cicerone o Virgilio, lo dobbiamo quindi anche all’encomiabile lavoro dei copisti medievali. Quanto al progresso tecnologico medievale, per capirne la portata basta uno sguardo al corposo elenco di invenzioni di quel periodo, parecchie delle quali sono state fondamentali per secoli e, in parte, tali ancora nella nostra quotidianità.[...]Continuando, vale poi la pena, specie in tempi di pandemia, parlare della nascita medievale degli ospedali. Rispetto a questo, c’è da sapere che, sebbene già nell’antica Grecia e a Roma esistessero istituzioni che fornivano una qualche forma di trattamento medico, in nessuna di esse si assicurava l’assistenza a malati, poveri e bisognosi, che erano lasciati a loro stessi. Un cambiamento radicale avvenne invece con l’ascesa del Cristianesimo e maturò nell’Europa cristianizzata dove, per la prima volta, la cura degli altri si organizza, si fa tecnica e rete per alleviare le sofferenze. Si fece così largo l’embrione dell’ospedale vero e proprio, non più riservato a pochi privilegiati né vissuto come fatto utilitario, bensì come luogo interamente ispirato da un impulso caritatevole e incondizionato verso i sofferenti. […] Niente male, ancora una volta, per un’epoca, il Medioevo, estremamente religiosa e che - in aggiunta alle meravigliose cattedrali che ancora oggi possiamo ammirare - ha lasciato in eredità una ricca serie di invenzioni e progressi di cui l’Europa intera ha beneficiato a lungo. […] Il debito del progresso scientifico verso il Cristianesimo, già chiaro nel Medioevo, è stato confermato tra il XVI e il XVII secolo, quando in Europa ebbe luogo quel rapido avanzamento dei saperi noto come «rivoluzione scientifica» e durante il quale furono poste le basi concettuali, metodologiche e istituzionali della scienza sperimentale moderna. Questo periodo viene convenzionalmente circoscritto tra la seconda metà del XVI secolo, con la pubblicazione nel 1543 di Le rivoluzioni dei corpi celesti di Niccolò Copernico, e la fine del XVII secolo, con l’affermazione delle leggi di Newton. Ora, già questo evidenzia un chiaro legame con il Cristianesimo se si pensa che, da una parte, Copernico altri non era che un consacrato formatosi nelle università di origine medie vale di Cracovia, Bologna, Ferrara e Padova, mentre, dall’altra, Isaac Newton - anche se i più lo ignorano - fu un signore che dedicò la maggior parte della sua esistenza non già allo studio della natura bensì a quello della Bibbia. [...] Se la fede cristiana di Copernico e Newton è dunque un dato sicuro, il discorso non cambia di una virgola neppure per Galileo Galilei, il quale non fu un generico credente ben sì un uomo profondamente devoto. Lo provano, al di là del processo che subì svariati elementi biografici, dalla sua personale amicizia con svariati tra cardinali e uomini di Chiesa, al fatto che quando spirò, a 78 anni e con tanto di benedizione papale, lo scienziato era circondato dai familiari e toccò a una delle due figlie suore raccogliere la sua ultima parola, che significativamente fu: «Gesù!». [...] Com’è possibile che lo stesso Cristianesimo che, da una parte, in epoca medievale, ha dato energico impulso all’istruzione universitaria, dall’altra potesse essere in qualche modo ostile alla ricerca scientifica? Si tratta di una tesi assurda, eppure continuamente rilanciata dagli assertori dell’ostilità ecclesiastica al progresso scientifico. Lo stesso processo di Galilei fu molto diverso da come viene immaginato. Infatti, non solo allo scienziato, il quale mai pronunciò «eppur si muove», non fu torto un solo capello ma, convocato a Roma, fu sistemato a spese e cura della Santa Sede in un ampio alloggio a cinque stanze, completo di finestra affacciata sui giardini vaticani e di cameriere personale. Il processo si celebrò quindi in un contesto lontano da quello, cupo e violento, spesso immaginato. E si svolse pure per un motivo diverso da quel che molti pensano, dato che non fu quello che lo scienziato pisano sosteneva, l’eliocentrismo, a procurargli processo e condanna all’abiura, bensì come lo sosteneva. Infatti egli da un lato, nella sua opera il Dialogo sopra i due massimi sistemi, derise il Papa, dall’altro, trattò il sistema copernicano come verità assoluta, vantando peraltro una sicurezza che non seppe supportare con gli argomenti; tanto da chiamare in causa, nel dibattimento, quell’esistenza delle maree che gli astronomi gesuiti giustamente osservarono essere collegata non già alla rotazione della Terra, bensì all’attrazione lunare. Comunque sia, nel giugno del 1633, nel convento romano di Santa Maria sopra Minerva tenuto dai domenicani, udita la sentenza di condanna all’abiura e la mitezza della stessa, Galilei pare abbia proferito un ringraziamento verso il collegio giudicante di dieci cardinali, tre dei quali avevano votato per il proscioglimento, che condannò sì la teoria copernicana, senza però giudicarla eretica né impegnando l’infallibilità della Chiesa. Il pontefice stesso, dal cui sdegno aveva avuto origine l’iniziativa inquisitoriale, non firmò mai quel verdetto.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 novembre con Flaminia Camilletti
Benjamin Netanyahu (Ansa)