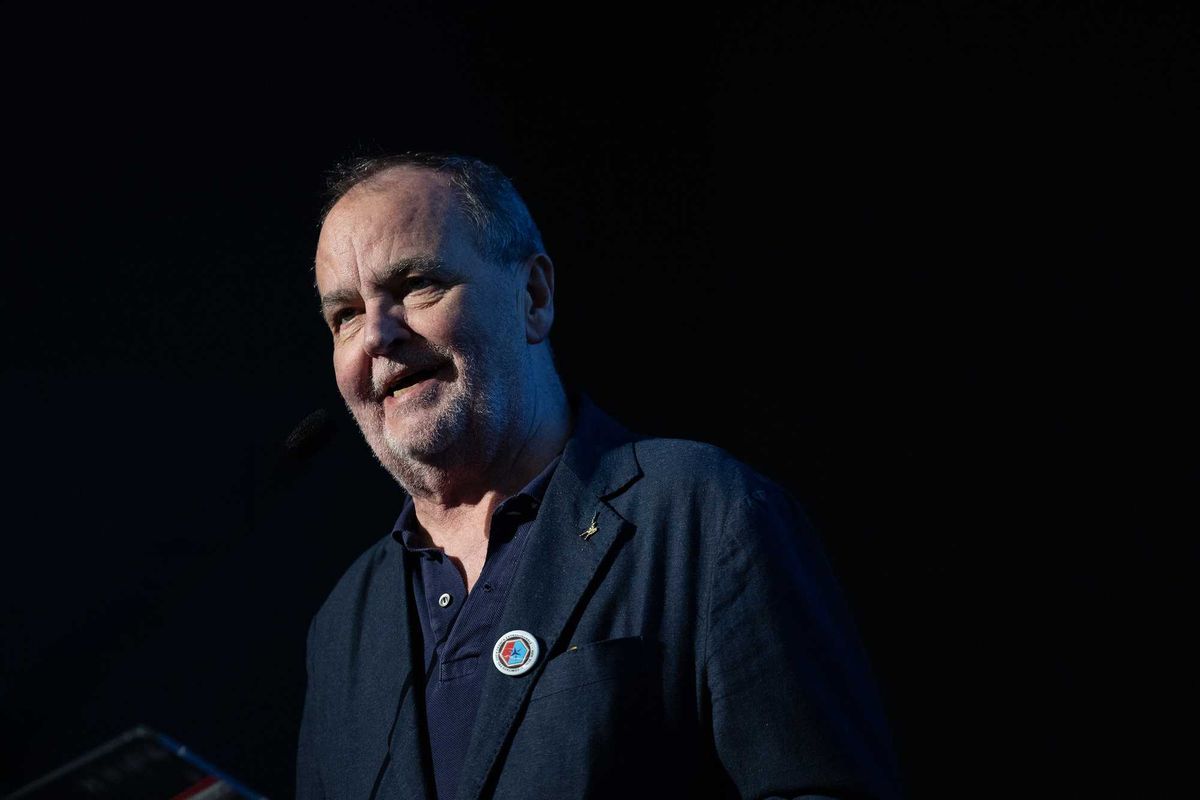La pandemia ha fatto scuola: libertà di espressione sempre più a rischio. Da febbraio l’Ue controllerà i contenuti on line. In molti Paesi, dall’Australia alla Gran Bretagna, presto in vigore leggi capestro. Al lavoro sporco ci pensano i fact checker. Negli Usa è nel mirino la legge che assicura il pluralismo sul web.
La pandemia ha fatto scuola: libertà di espressione sempre più a rischio. Da febbraio l’Ue controllerà i contenuti on line. In molti Paesi, dall’Australia alla Gran Bretagna, presto in vigore leggi capestro. Al lavoro sporco ci pensano i fact checker. Negli Usa è nel mirino la legge che assicura il pluralismo sul web. Lo speciale comprende tre articoli.«La lotta alla disinformazione e al discorso d’odio (hate speech) è soltanto un esercizio di controllo prettamente elitario», ha dichiarato giorni fa davanti al Congresso americano il giornalista indipendente Matt Taibbi, coordinatore dei Twitter Files. «Il ragionamento è semplice: se un piccolo gruppo demografico pretende di avere ampio controllo sulla libertà di espressione di un grande gruppo sottostante, ne consegue che uno dei due finirà per avere più potere politico dell’altro. Quale? Probabilmente non quello di cui fai parte tu, cittadino. I progressisti la chiamerebbero “guerra di classe”». Una guerra silenziosamente già vinta: ancora pochi giorni e l’anno nuovo ci porterà, insieme con le elezioni europee e le presidenziali americane, il complesso di leggi appena approvate in tutto il mondo occidentale per monitorare i cittadini e privarli della loro libertà di espressione.Si tratta, di fatto, di leggi-bavaglio: il modello di riferimento è il Digital Services Act (Dsa) europeo, che dal 17 febbraio 2024 entrerà in vigore per tutte le piattaforme Ue. Concepito, sulla carta, per tutelare gli utenti dai contenuti illegali, il Dsa è in realtà un efficace strumento per scaricare sui distributori di contenuti online la (auto)censura del free speech. Il funzionamento della tagliola Ue è molto semplice: smantellando il principio su cui è stata regolata l’informazione online dagli anni Novanta ad oggi (nessuna piattaforma è responsabile dei contenuti informativi diffusi dagli utenti), «ciò che è illegale offline, lo sarà anche online». Peccato, però, che i criteri di pubblicabilità, o di legalità, non saranno stabiliti dagli organi di giustizia preposti ma dal neonato «Comitato europeo per i servizi digitali», costituito da funzionari di alto livello e presieduto dalla Commissione europea, organo politico non eletto. Non meglio definite figure sovranazionali decideranno quindi, per conto delle istituzioni, ma per mano delle piattaforme, quali contenuti potranno circolare in rete e quali no. «L’Ue si è dotata di una mole eccessiva di regolamentazioni», ha dichiarato proprio a Roma, sabato scorso, Elon Musk, intervenuto alla festa di Atreju. Il rischio - ha spiegato Mr. Twitter - è che col tempo tutto diventi illegale. «Quando si comincia a censurare, prima o poi la censura si ritorce contro».La tempistica del Dsa è indicativa: le misure restrittive saranno intensificate «in caso di crisi» («conflitti armati o atti di terrorismo, catastrofi naturali nonché pandemie e altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero»), ipotesi non proprio remota, considerata l’emergenza permanente in cui è precipitato il mondo di oggi tra guerre per procura, cambiamenti climatici e «future pandemie» ormai date per certe. Le piattaforme online che non rispetteranno le regole del Dsa incorreranno in multe fino al 6% del fatturato globale.La lista dei Paesi che negli ultimi mesi hanno approvato o stanno approvando leggi restrittive della libertà di espressione online si sovrappone, di fatto, a quella degli Stati membri della Nato: oltre agli Stati Uniti, l’Ue, il Canada, l’Australia, il Regno Unito e la Turchia (ma anche il Brasile di Lula). Il Parlamento irlandese, ad esempio, dopo la rivolta anti-immigrati scoppiata dopo che un uomo di origine algerina aveva accoltellato tre bambini e una maestra davanti a una scuola di Dublino, ha accelerato l’iter dell’Hate Crime Bill. Anche in Scozia, l’Hate Crime Act renderà alcuni argomenti politici punibili fino a sette anni di carcere e colpirà anche le conversazioni private all’interno delle abitazioni. Nel Regno Unito di Rishi Sunak, l’Online Safety Bill appena approvato riprende i postulati del Dsa, delegando alle piattaforme la responsabilità dei contenuti. La clausola 110 chiede infatti ai siti web e alle app di impedire «in modo proattivo» la visualizzazione di contenuti dannosi, anche sui servizi di messaggistica. L’accusa all’Ofcom, il regolatore delle comunicazioni nel Regno Unito, è quella di violazione del diritto alla privacy dei cittadini. L’Australia, da parte sua, ha approvato l'Online Safety Act nel 2021 per regolamentare la rimozione di contenuti ed è oggi al rush finale anche il Misinformation Bill, strutturato in maniera simile al Dsa europeo: l’Australian Communications and Media Authority (Acma) sarà dotato di nuovi poteri per combattere la disinformazione online e scaricherà l’onere di rimozione alle piattaforme digitali. Incentrate sul principio della responsabilità dei fornitori online e sulle multe ai provider anche le leggi sulla disinformazione approvate in Turchia e in Brasile. La legge 7418 turca è stata firmata dal presidente Recep Tayyip Erdogan a fine 2022 tra le preoccupazioni per le sue potenziali implicazioni per la libertà di espressione nel Paese. All’articolo 5, ad esempio, è previsto che se un provider non rimuove contenuti falsi, fuorvianti o illeciti entro due settimane, può perdere la pubblicità e i giornalisti possono essere privati del tesserino stampa. Il Pl 2630 brasiliano all’esame del Congresso, che trasferirebbe l’onere di segnalazione di contenuti illegali e fake news sulle piattaforme Internet, è stato stigmatizzato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che si è dichiarato «seriamente preoccupato» per le potenziali violazioni della libertà di espressione. Eppure, sia la legge turca che quella brasiliana sono simili a quella europea, che però è passata senza particolari proteste. In Canada il primo ministro Justin Trudeau ha promesso l’approvazione in tempi rapidi dell’Online Harms Law, annunciando che «il governo dovrà trovare il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e le esigenze delle comunità». Infine, gli Usa: la maggior parte delle legislature statali ha introdotto disegni di legge per la regolamentazione dei social media, che vanno a rafforzare i criteri della Section 230. Ma il grande dibattito sulla libertà di espressione avrà luogo in primavera, a ridosso delle elezioni presidenziali, quando la Corte Suprema dovrà discutere il caso Missouri vs Biden scoppiato a seguito della censura perpetrata dalle massime istituzioni del Paese, a cominciare dal presidente Joe Biden, durante la pandemia.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/il-2024-sara-lanno-della-censura-2666616470.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="negli-usa-e-nel-mirino-la-legge-che-assicura-il-pluralismo-sul-web" data-post-id="2666616470" data-published-at="1702844392" data-use-pagination="False"> Negli Usa è nel mirino la legge che assicura il pluralismo sul web Avviluppata come sempre nelle sue contraddizioni, è l’America del Primo Emendamento e della Westminster Declaration, ma anche dell’ideologia woke, l’unico Paese in cui si sta seriamente discutendo di libertà di espressione online, laddove si dipana la conversazione politica degli americani. Conversazione che è stata regolamentata per decenni dalla famosa «Section 230» del Communications Decency Act approvato quasi 30 anni fa, nel 1996. «Nessun fornitore e nessun utilizzatore di servizi Internet può essere considerato responsabile, come editore o autore, di una qualsiasi informazione fornita da terzi», recita la legge Usa che ha fatto scuola in tutto il mondo, fino all’introduzione del Dsa europeo e di tutte le altre leggi che, oggi, ne hanno ribaltato le fondamenta. Anche gli ultimi due presidenti Usa, pur animati da intenti opposti, hanno cercato di smantellarla. Ci ha provato Donald Trump durante la campagna elettorale del 2020, ordinando alla Federal Communications Commission (Fcc) di intervenire sulle piattaforme social, colpevoli di essere tutte schierate contro di lui. Twitter, allora non ancora acquistato da Elon Musk, è stato, ad esempio, il primo social media a sospendere dalla piattaforma, a tempo indeterminato, un presidente degli Stati Uniti, sia pure uscente. Ci ha riprovato anche Joe Biden, che a gennaio di quest’anno ha scelto le colonne del Wall Street Journal per inveire contro «gli abusi di Big Tech» e suggerire una revisione della 230 per combattere l’incitamento all’odio e la presunta disinformazione: sui vaccini, sui miliardi spesi per la guerra nella lontana Ucraina e soprattutto sui sospetti affari di suo figlio Hunter, nei confronti del quale i media americani hanno praticato una potente autocensura. L’alibi dietro il quale la sinistra dem si sta nascondendo per invocare la soppressione del free speech è la sicurezza online: è in nome di questa che la libertà di espressione è diventata, per una parte dei cittadini degli Stati Uniti, sacrificabile. Al Congresso sono state presentate moltissime proposte per rivedere la Sezione 230, ma nessuna è arrivata al voto né alla Camera né al Senato. Per un motivo: in America il Primo emendamento della Costituzione (che recita che «il Congresso non potrà emanare leggi per limitare la libertà di parola o di stampa») è ancora sacro. Tant’è che perfino il presidente in carica non si è potuto sottrarre al processo Missouri vs Biden che, a pochi mesi dal voto per le presidenziali, sarà valutato dalla Corte Suprema. L’accusa rivolta al presidente degli Stati Uniti dai procuratori del Missouri e della Louisiana, insieme con gli scienziati Jay Bhattacharya e Martin Kulldorf, è pesantissima: aver violato il Primo emendamento, censurando - con la complicità delle piattaforme social, anch’esse citate in giudizio - cittadini, giornalisti e scienziati che durante la pandemia hanno osato diffondere sui social evidenze scientifiche diverse da quelle del governo, etichettandole come false o fuorvianti. Un tribunale federale si è pronunciato a favore dei querelanti a luglio, una corte d’appello ha in gran parte confermato la sentenza a settembre. Biden tuttavia le ha provate tutte pur di limitare il free speech: appena cinque giorni dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ha assunto la giornalista Nina Jankowicz nominandola a capo del neonato Disinformation Governance Board, minacciosamente posto alle dipendenze della Homeland Security, il Dipartimento che difende il Paese dagli attacchi terroristici. L’ufficio, ribattezzato «Ministero della Verità», è stato smantellato appena tre mesi dopo la sua istituzione, dopo l’intervento dei repubblicani. Alla «debunker istituzionale» voluta da Biden è stata rinfacciata la penosa esibizione canora, sulle note di «Supercalifragilistichespiralidoso», nel 2020 su TikTok, contro Trump e le fake news. Il presidente ha scatenato anche l’ex portavoce Jen Psaki, soprannominata «Psycho Jen», contro la presunta disinformazione: «Il presidente è molto preoccupato e vuole riformare al più presto la 230», annunciò. Ma la 230 non è stata riformata e anche Psaki alla fine ha lasciato l’incarico, così come lo hanno lasciato tutti i protagonisti della pandemia - da Anthony Fauci a Rochelle Walenski - che si sono più volte appellati alla censura contro le presunte fake news. La verità è che la Section 230, tutto sommato, ha fatto per decenni il suo sporco lavoro, cercando di conciliare il Primo emendamento con la necessità di tutelare gli utenti dai contenuti dannosi come la pedopornografia, il cyberbullismo, la violazione del copyright. La decisione della Corte Suprema sul caso Missouri vs Biden, attesa ad aprile, sarà dunque dirimente. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/il-2024-sara-lanno-della-censura-2666616470.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="e-al-lavoro-sporco-ci-pensano-i-fact-checker" data-post-id="2666616470" data-published-at="1702844392" data-use-pagination="False"> E al lavoro sporco ci pensano i «fact checker» In principio fu la «Commissione Amore»: così il senatore leghista Alberto Bagnai aveva ironicamente ribattezzato l’organo bicamerale istituito a fine 2019, incaricato di elaborare strategie «per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza». La prima seduta della commissione straordinaria, presieduta dalla senatrice Liliana Segre, si era tenuta dopo l’emergenza Covid, a metà aprile 2021; i lavori si erano conclusi a luglio del 2022 con la pubblicazione della pretenziosa «Analisi comparativa sul fenomeno dell’istigazione all’odio online». Nel documento di 40 pagine, la commissione stigmatizzava la discriminazione di gruppi target, negli stessi mesi in cui, sotto i suoi occhi, i cosiddetti novax erano paragonati da un indisturbato Roberto Burioni a «sorci», nonché sottoposti a pubblico ludibrio perpetrato non soltanto dai media ma anche dai rappresentanti istituzionali e politici, online e offline. «Il percorso iniziato con la Commissione Joe Cox, proseguito con la Commissione Amore, punteggiato da infiniti tribunalucci e tribunaletti della verità, proseguirà sempre più rapido e scomposto», aveva pronosticato Bagnai. Così è stato: le conclusioni dei lavori della Commissione Segre sono state di una tale modestia che, visto il successo, si è ben pensato di riattivarla con la nuova legislatura. Nel frattempo, media e piattaforme social hanno fatto la parte del leone e sopperito alla fuffa istituzionale censurando e autocensurandosi anche prima dell’entrata in vigore del Dsa europeo. Dsa votato, occorre precisarlo, dagli eurodeputati di Pd e M5s appassionatamente assieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia (ma senza il sostegno della Lega, che ha votato contro). Al resto hanno provveduto i cosiddetti «fact-checkers»: quelli, nominati da non si sa chi, che quando ancora la legge europea era in itinere, facevano già carne da macello della libertà di espressione in Italia, segnalando qualsiasi post, articolo o tweet che esulasse dalla vulgata istituzionale, prima sui vaccini, poi sulla guerra in Ucraina, infine sul clima. Le vittime sul campo sono state molte: La Verità e i suoi giornalisti, ma anche migliaia di cittadini comuni, colpevoli di aver postato sul web documenti ufficiali che non avevano nulla di falso ma, semplicemente, non erano graditi. A farsi ufficialmente carico del lavoro sporco è stata la testata Open, che ancora un mese fa è indirettamente incappata in uno sguaiato incidente di online shaming nei confronti di un ignaro utente Twitter. Il sottobosco mediatico che gravita intorno ad Open sta cedendo in maniera sempre più grottesca al tifo sgangherato: quello che doveva essere, alla fin fine, un banale lavoro di censura si è presto trasformato in una faida tra bande, in quel «tutti contro tutti» che lo stesso Elon Musk, atterrato sabato alla festa Atreju di Fdi, ha stigmatizzato: «Non importate l’ideologia woke», ha detto Mr. Twitter, «perché amplifica razzismo, sessismo e odio facendo finta di fare il contrario». Troppo tardi: abbiamo fatto, se possibile, anche peggio.
Roberto Calderoli (Getty Images)
Il ministro leghista Roberto Calderoli: «L’opposizione strepita ma si è trattato per un anno. Ai governatori dico: la pre intesa è un’opportunità. Più libertà a chi lavora bene, più Stato per gli altri».
Il tavolo del vertice di Ginevra (Ansa)
Elaborati 24 nuovi punti per far finire la guerra. Tra questi pure, secondo il «Telegraph», il reintegro della Russia nel G8. Rubio: «È stata una delle giornate più produttive da quando siamo stati coinvolti». E Zelensky adesso ringrazia The Donald.
Stefano Esposito (Ansa)
L’ex dem, assolto dopo 7 anni di calvario: «Quel magistrato fece intercettazioni illegittime. Il Csm non lo ha nemmeno trasferito».