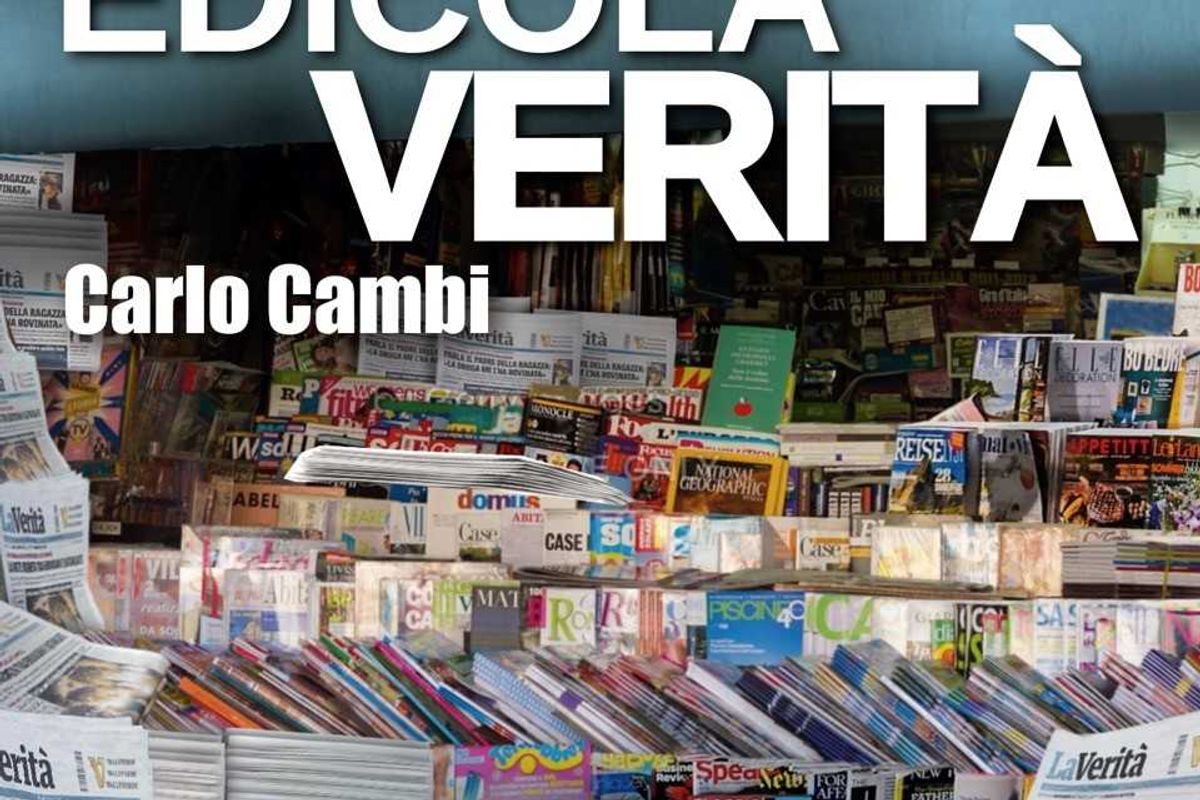2021-02-21
Identità e tradizioni si possono difendere tenendo in mano coltello e forchetta
Raccolti in volume gli scritti del filosofo Tullio Gregory dedicati alla cucina: un manuale di resistenza alla globalizzazione. Per tutelare l'identità e il patrimonio culturale, talvolta, non resta altro che sedersi a tavola, brandire coltello e forchetta e prepararsi a combattere per «la cucina in rapporto al territorio e alle stagioni, da difendere in quanto fatto culturale». Certo, oggi dominano gli chef e la loro concezione competitiva. La cucina creativa va per la maggiore; quella tradizionale è per lo più ridotta a curiosità da programma del pomeriggio. Eppure, «la prima è una cucina dell'improvvisazione. L'altra è la sola che valga». Così scriveva Tullio Gregory, uno dei più noti filosofi italiani del Novecento, professore di Storia della filosofia medievale alla Sapienza, autore di volumi ponderosi e influenti. E, soprattutto, grande amante della buona tavola. I suoi scritti sul cibo e sul vino sono ora raccolti in un volume intitolato L'eros gastronomico. Elogio dell'identitaria cucina tradizionale, contro l'anonima cucina creativa (Laterza). Un libro per gourmet, come no. Ma anche uno straordinario manuale di resistenza alle forze livellatrici della modernità, della globalizzazione e del cattivo gusto. Gregory - che certo non può essere ricondotto all'universo cosiddetto «sovranista», anzi - ha condotto una strenua lotta a favore «della grande tradizione gastronomica italiana», onde invitarci a «ritrovare il senso di una civiltà della cucina, che è un momento non marginale della nostra storia culturale e civile». Lo sappiamo: mangiare è un atto (anche) politico, e la tavola è più che mai rivelatrice di alcuni dei più pericolosi meccanismi imposti dal mainstream. Reagire a certe mode e a certi automatismi, dunque, significa reagire al pensiero dominante, combatterlo. Non solo durante i pasti, ma pure nel resto del tempo. La critica di Gregory alla cucina creativa contemporanea diventa, in qualche modo, critica radicale del presente, opposizione al magma globalizzato. La cucina, per lui, era prima di tutto pratica, intelligenza delle mani. «La tradizione», scriveva, «esiste solo se trasmessa e ripetuta dal modo di fare». Già, la tradizione è esattamente l'attimo indescrivibile in cui si osserva la nonna preparare un piatto antico. E quando alla nonna si chiede: «Perché lo prepari proprio in questo modo?», lei risponde: «Perché si fa così». Che significa: «Perché così facevano i miei avi prima di me, perché così facciamo in questa terra, perché così facciamo noi». Ecco perché, spiegava Gregory, quando si maneggia il passato bisogna prestare enorme attenzione. Spesso, scriveva il filosofo, rivisitare un piatto tradizionale «vuol dire alleggerirlo, renderlo più bello, semplificarlo. Io credo invece che “il" gnocco fritto vada fritto nello strutto. E che se voglio cercare “il bello" vado al museo, non al ristorante. A tavola deve valere un rispetto per la tradizione culinaria trasmessa. Se chiedo il bollito, non voglio il piatto che richiama concetti o frasi di carni bollite, ma un carrello dei bolliti con testina, coda, muscoli, lingua, cappone, gallina». Certo, è facile far passare Gregory per un passatista brontolone. Lui stesso si definiva un «rompiscatole» e godeva a provocare i ristoratori «con la spocchia». La sua, però, non è la solita (e fin troppo facile) polemica contro i ristoranti stellati che mettono «tutto sul conto, nulla nel piatto». No, qui parliamo di una vibrante difesa della civiltà europea. La globalizzazione in tavola, i fast food, il cibo pronto e la fusion, cioè la mescolanza per la mescolanza, sono segni «di decadenza della civiltà occidentale. La cucina nasce al mercato, non al supermercato». La cucina deve essere «eros gastronomico». Ma, di nuovo, non si tratta della banale associazione commerciale fra sesso e cibo, ennesima maniera di invitare alla sfrenatezza del desiderio. No, la cucina deve essere «passione vitale», cioè tradizione viva, rispetto per «la realtà del cibo, nella sua fisicità e nei suoi valori». Quindi anche rispetto della natura, dei suoi ritmi, delle sue gerarchie. La grande arte culinaria richiede tempo. È fatta di terra, appunto, e di gesti antichi, di popolo. Per Gregory «non esiste una cucina internazionale», al massimo «un'arte culinaria internazionale». Egli depreca la gastronomia asettica «che - sulla strada della dietetica praticata da una borghesia anoressica e malinconica - ha perduto il gusto per le grandi salse e le lunghe cotture». Se la prende con «la petulanza di dietologi inappetenti» e con chi frequenta ristoranti costosi per vedere o essere visto.Non è il goloso, il mangione, che strepita per ottenere porzioni più grandi e conti più stretti. È il fine pensatore che vuole rivivificare la cultura partendo dalla base «tradizionale» e «regionale», in opposizione alle teorie dominanti secondo cui le cucine nazionali non esistono, tutto è mescolanza, «contaminazione». A tavola, insomma, si combatte contro il «business planetario» che «disintegra e integra insieme, produce una sorta di mosaico sincretico universale». Si combatte per i popoli e per le nazioni: per l'identità.
Cartelli antisionisti affissi fuori dallo stadio dell'Aston Villa prima del match contro il Maccabi Tel Aviv (Ansa)
Il neo sindaco di New York Zohran Mamdani (Ansa)
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 7 novembre con Carlo Cambi
Il luogo dell'accoltellamento a Milano. Nel riquadro, Vincenzo Lanni (Ansa)