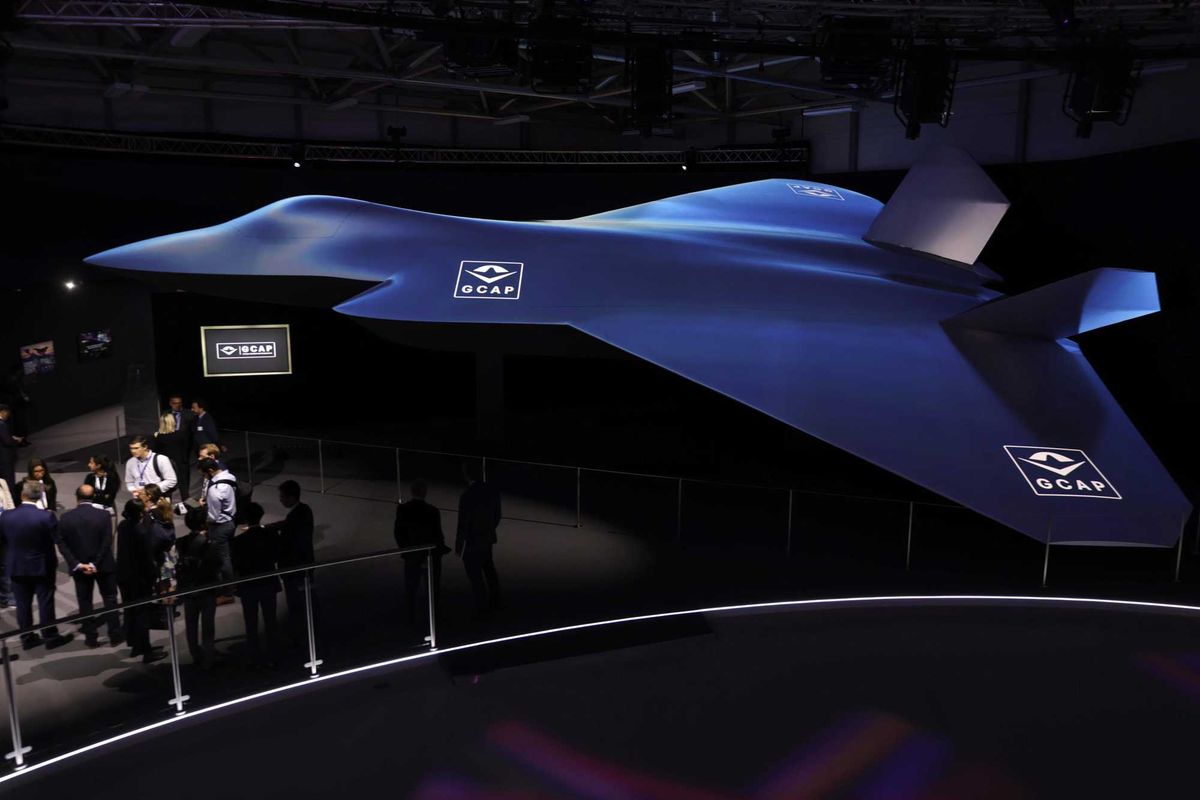L'altro giorno sono andato a Carpi e, nel cortile di Palazzo Pio, con Pierluigi Senatore abbiamo presentato un libro che è appena uscito. Era una bella serata, c'era tanta gente, in una pazza incantevole, mi presentava un mio amico e eran dei mesi che io non facevo una cosa che mi piace moltissimo, parlare in pubblico, e quella sera ricominciavo, e poco prima di salire sul palco ho pensato a un libro, e lo sono andato a cercare sul mio sito e ho trovato il pezzo che mi interessava, che è questo qua: «Quando sono tornato a casa dalla seconda guerra mondiale, mio zio Dan mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: “Adesso sei un uomo". E io l'ho ammazzato. No, non l'ho ammazzato per davvero, ma mi è venuta una gran voglia di farlo. Dan era il mio zio stronzo, quello che diceva che un uomo non è mai un vero uomo finché non è stato in guerra. Ma avevo anche uno zio buono, Alex, che adesso non c'è più. Era il fratello minore di mio padre: laureato ad Harvard, senza figli, abitava a Indianapolis ed era un onesto impiegato di una compagnia di assicurazioni. Era un uomo colto e saggio. E la cosa che più rimproverava agli altri esseri umani era che si rendevano troppo raramente conto della loro stessa felicità. Perciò, quando d'estate stavamo seduti sotto un melo a bere limonata, parlando del più e del meno, quasi ronzando come api, zio Alex all'improvviso interrompeva quelle piacevoli quattro chiacchiere per esclamare: “Ah, questa sì che è vita!". E così io oggi faccio lo stesso, e lo stesso fanno i miei figli e i miei nipoti. E invito anche voi a rendervi conto dei momenti di felicità e a esclamare, mormorare o pensare fra voi, a un certo punto: “Ah, questa sì che è vita!"».
«Ecco», ho detto, l'altro giorno a Carpi,« io adesso, poi magari la presentazione verrà malissimo, ma io, adesso, sono proprio contento», ho detto.
Una mia amica il giorno dopo mi ha scritto, mi ha chiesto chi era l'autore russo che avevo citato all'inizio, io le ho risposto che non era russo, era americano, si chiama Kurt Vonnegut (e il libro Un uomo senza patria, nella traduzione di Martina Testa).
Di solito, quando mi succede qualcosa che mi sembra significativo, lo collego a un libro che ho letto, perché, per me, la letteratura, che, come si sa, in generale, non serve a niente, per me è uno strumento per pensare, o per capire quello che penso, direbbe forse un altro scrittore non russo, emiliano, che si chiama Luigi Malerba.
Quando vado in Russia, per esempio, cosa che, per fortuna, mi succede un paio di volte l'anno, una delle prime cose che faccio è guardare per aria e ripetermi nella testa una poesia, molto breve, di Velimir Chlebnikov: «Poco, mi serve,/una crosta di pane,/un ditale di latte,/e questo cielo,/e queste nuvole».
O quando, nella mia testa, penso a Francesca, la mamma di mia figlia, la collego all'inizio di un'altra poesia di Chlebnikov: «Le ragazze/quelle che camminano/con stivali di occhi neri/sui fiori del mio cuore».
O, quando mi capita di avere a che fare con qualcuno che mi sembra non sappia fare il suo mestiere, è facile che pensi all'opera numero 138 delle Opere complete di Learco Pignagnoli, di Daniele Benati, che fa così: «Opera n. 138. I figli dei notai che diventano notai, degli attori che diventano attori, dei musicisti che diventano musicisti, dei giornalisti che diventano giornalisti, degli industriali che diventano industriali, dei dottori che diventano dottori, degli architetti che diventano architetti, degli avvocati che diventano avvocati, degli ingegneri che diventano ingegneri. Ma andatevela a prendere nel culo».
Delle volte, succede il contrario, un'esperienza mi aiuta a capire una cosa che ho letto tempo prima.
Mi è successo così con Il Dottor Zivago, di Boris Pasternàk. Ecco, io, Il Dottor Zivago, l'ho letto, ma devo dire che non è stato, per me, un romanzo memorabile. Mi sembra che Pasternàk sia un grande poeta, ma con il suo romanzo, io, devo dire, faccio fatica.
L'unica cosa che mi suona, del Dottor Zivago, sono le prime pagine e le ultime, dove ci son le poesie, le ultime, e in particolare la prima poesia, che nella finzione è una poesia di Zivago, nella realtà è una poesia di Pasternàk che si intitola Amleto e il cui ultimo verso dice: «Vivere una vita non è attraversare un campo» (la traduzione è di Pietro Zveteremich).
Che a me è sempre sembrato un finale grandioso, che però ha incrociato la mia biografia solo nel 1999, quando avevo già 36 anni. Allora io, nel 1999, ero in ospedale, mi ero ustionato, mi mancava un terzo della pelle, al posto della pelle avevo la carne viva, e ci sarei rimasto 77 giorni di seguito, e avrei fatto sette operazioni, e è stato il periodo più doloroso della mia vita, soprattutto i primi 30 giorni, che tutti i giorni mi dovevano sbendare e ribendare, per lavarmi, e le bende, che nella notte, con il sangue e col pus, si erano attaccate, a staccarle facevano un male che io non ho mai provato un male del genere nella mia vita, e solo a pensarci, a quel male lì, io mi commuovo. Sono stati, quei giorni lì in ospedale, il periodo più difficile della mia vita, fino a adesso. È stato il periodo che ho conosciuto la morfina, e devo dire mi piace moltissimo, la morfina, ho scoperto, sono così simpatico, subito dopo che mi hanno iniettato una dose di morfina, sono così curioso del mondo, ma, a parte la parte della morfina, quel periodo lì, quel male lì, che c'era tutti i giorni, che mi veniva da strapparmi i capelli, anche con la morfina, e che quando passava io sapevo benissimo che il giorno dopo sarebbe ritornato, io tutti i giorni mi ripetevo: «Vivere una vita non è attraversare un campo, vivere una vita non è attraversare un campo, vivere una vita non è attraversare un campo», e quel verso lì di Pasternàk mi è sembrato di capirlo solo allora.
E allora? direte forse voi.
Allora io quest'estate vorrei provare, una volta a settimana, a fare una cosa del genere, a decifrare una cosa che succede attraverso la letteratura (russa, prevalentemente, ma non necessariamente).
Cominciamo la prossima settimana e parliamo delle statue che cadono, probabilmente.
(1. Continua)