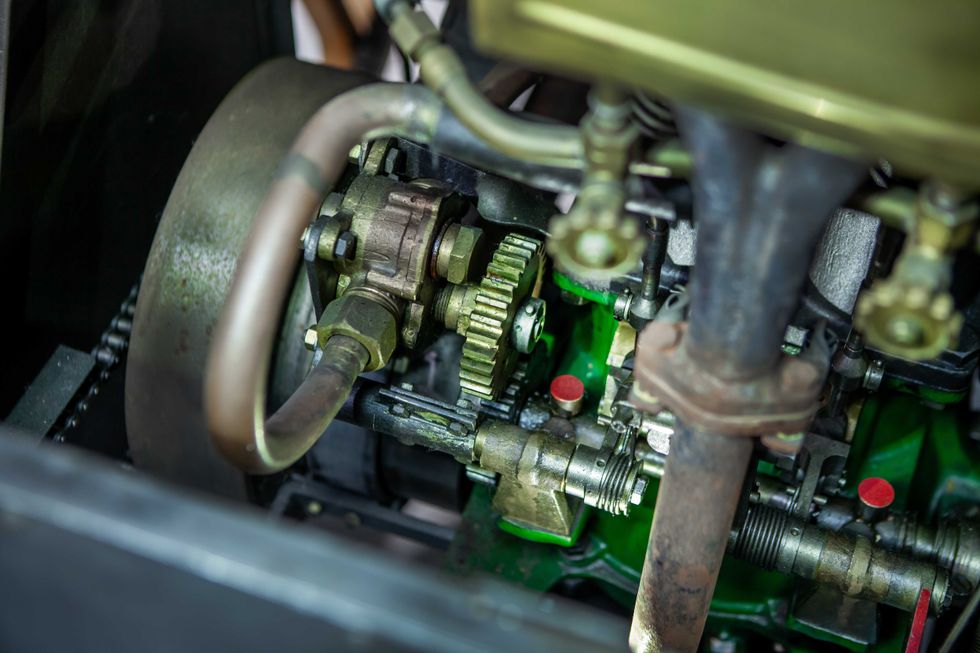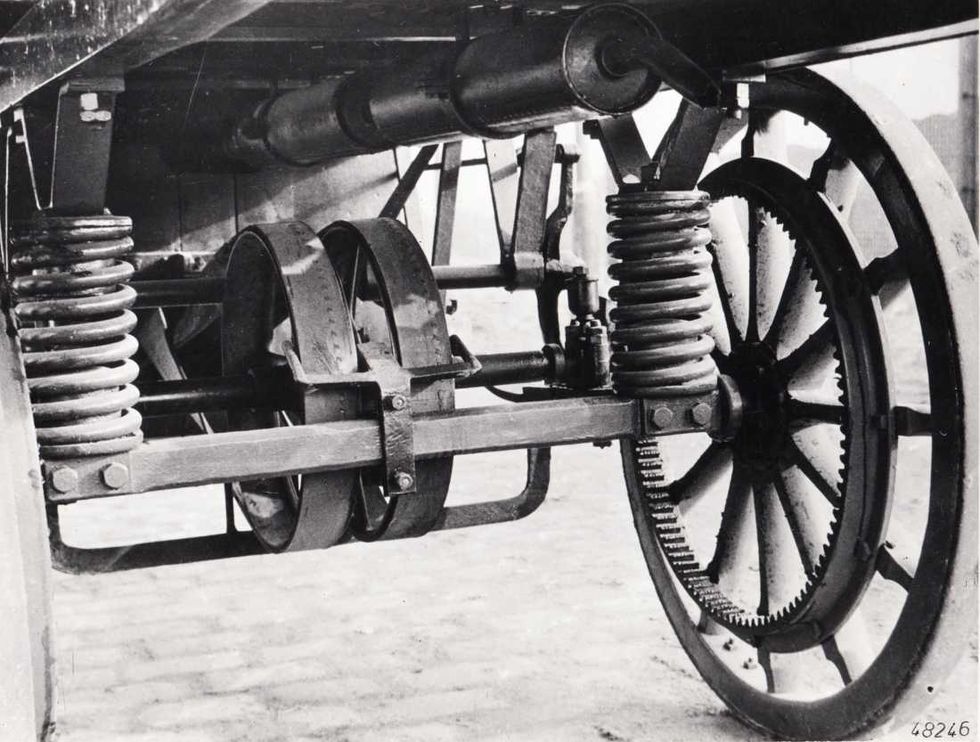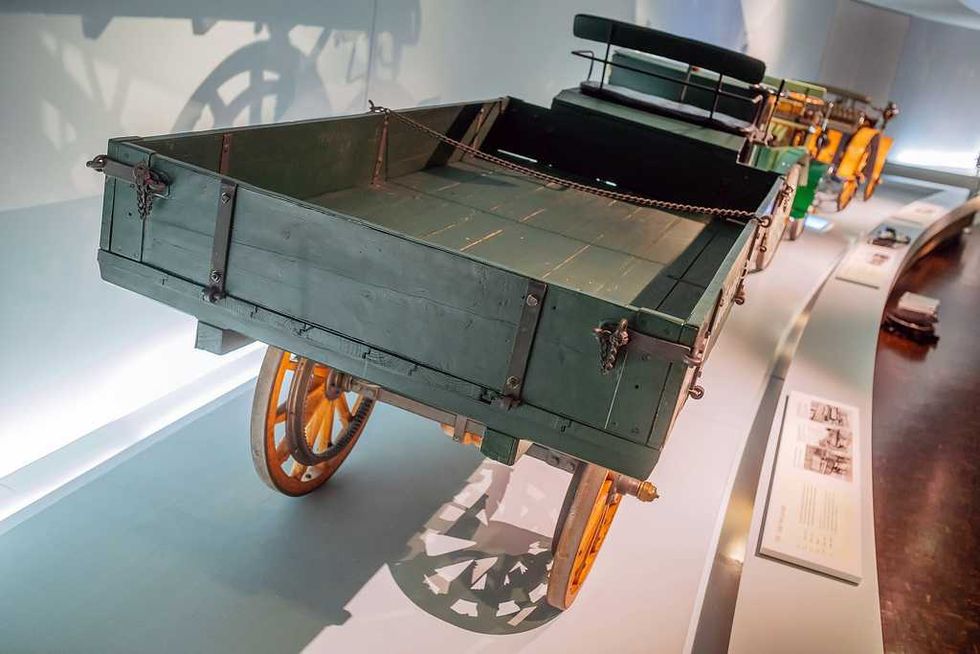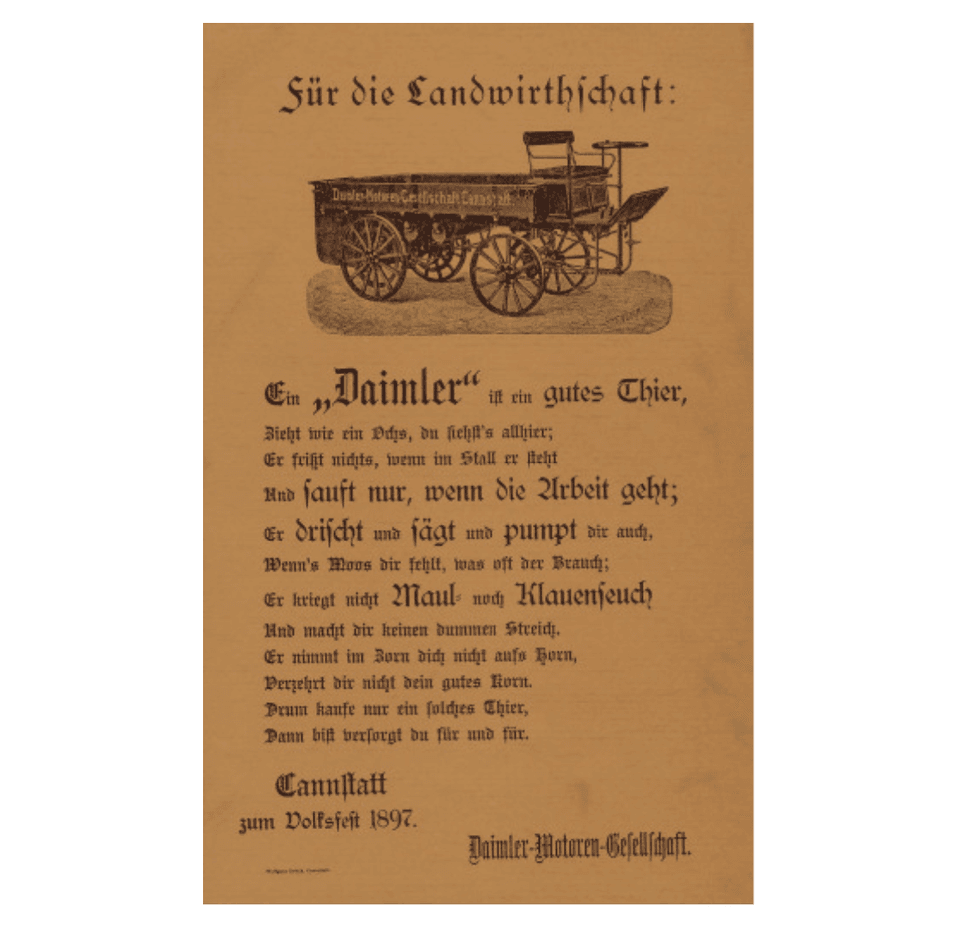La Casa Bianca tallona la Ivy League sui soldi spesi per il green e la Cina

Durante la sua campagna elettorale, Donald Trump era stato cristallino: in caso di ritorno alla Casa Bianca, il tycoon sarebbe passato alla resa dei conti con i campus americani, che ormai si sono trasformati in «centrali di indottrinamento» e in santuari dell’ideologia woke. Nelle idee dello staff trumpiano, la battaglia contro gli atenei politicizzati avrebbe dovuto svilupparsi lungo due direttrici strategiche. In primo luogo, occorreva una rimodulazione dei programmi accademici, che da anni sono sempre più incentrati sulle materie Dei (diversità, equità e inclusione) e su discipline politicamente corrette ma scientificamente dubbie: pensiamo solo ai controversi gender studies o anche solo a indirizzi come gli whiteness studies, che si propongono di studiare il «privilegio bianco» nelle nostre società. In secondo luogo, per il presidente degli Stati Uniti era di vitale importanza colpire i college lì dove fa più male, ossia nel portafoglio.
Ebbene, Trump è stato di parola. Circa due settimane fa, i funzionari del tycoon hanno congelato i fondi destinati alle università dell’Ivy League, ossia gli atenei più prestigiosi del Paese. E non si parla certo di noccioline, bensì di miliardi di dollari: tra tagli e sospensioni, ci hanno rimesso la Columbia (400 milioni), la Brown (510 milioni), la Cornell (circa 1 miliardo), la Northwestern (790 milioni), l’Università della Pennsylvania (175 milioni), Princeton (210 milioni) e, dulcis in fundo, Harvard, a cui sono stati congelati 2,2, miliardi di dollari, che potrebbe arrivare anche a 9. Le sblocco dei fondi, com’è noto, è vincolato all’adesione dei college alle nuove linee guida volute dall’amministrazione repubblicana per riportare il mondo accademico sulla retta via della ricerca.
A quel punto, alcuni rettori, tra cui quelli di Harvard e della Columbia, si sono giocati la carta del vittimismo, accusando Trump di repressione e autoritarismo. Tesi subito sposata da Barack Obama, ex studente di Harvard, che ha parlato di «tentativo illegittimo di soffocare la libertà accademica». Gli echi di queste geremiadi, ovviamente, sono giunti fino al Belpaese, con la sinistra nostrana che non vedeva l’ora di rispolverare la più vieta retorica antifascista. Leggere, per credere, il commento di Michele Serra, uscito ieri su Repubblica, che in tutta serietà ha accostato Trump al fascismo. Ma non solo: Serra, da buon radical chic, se la prende addirittura con il «rancore sociale dell’ignorante che detesta la cultura», che sarebbe una delle caratteristiche del trumpismo. Stando alla penna di Repubblica, «ogni atto politico» del leader repubblicano sarebbe «uno sputo alla democrazia, al diritto di opposizione, alle regole scritte e non scritte che consentono la convivenza tra opinioni e interessi differenti». Più che un identikit del trumpismo, a ben vedere, questa sembra un’accurata descrizione del modus operandi della sinistra italiana.
Pianti e lamenti a parte, Trump non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo aver risposto a tono al rettore di Harvard, il presidente ha chiesto ieri al Tesoro di revocare le esenzioni fiscali di cui godono l’ateneo di Cambridge e altri college prestigiosi ma marcatamente ideologizzati. Anche perché, ha ricordato il tycoon in un suo post su Truth, lo status di ente no profit concesso alle università private è vincolato per legge alla loro utilità pubblica e all’astensione dalle attività politiche. La decisione spetterà ora all’Irs, l’agenzia del Tesoro che si occupa della riscossione dei tributi: il suo nuovo direttore ad interim, Andrew De Mello, si è già messo al lavoro.
Un altro punto sensibile all’esame degli organi di governo, inoltre, è l’ammissione degli studenti stranieri negli atenei sotto osservazione. Già mercoledì il segretario del Dipartimento per la sicurezza interna, Kristi Noem, ha annunciato la revoca di due sovvenzioni del suo ministero ad Harvard per un totale di oltre 2,7 milioni di dollari. In sostanza, l’ateneo è chiamato a fornire entro il 30 aprile tutti i documenti su quelle che la Noem ha definito le «attività illegali e violente» degli studenti titolari di visto, i quali hanno partecipato alle manifestazioni pro Palestina e che potrebbero essersi resi protagonisti di episodi antisemiti. «Se Harvard non riuscirà a dimostrare il pieno rispetto dei suoi obblighi di segnalazione», ha scritto il dipartimento in un comunicato, «l’università perderà il privilegio di iscrivere studenti internazionali».
Ma non è finita qui. Come ha rivelato ieri la testata online Semafor, l’amministrazione Trump si concentrerà presto pure sugli investimenti finanziari delle università d’élite, «in particolare in settori sgraditi alla Casa Bianca, come l’energia pulita e la Cina». Anche questo punto, del resto, rientrava tra i propositi espressi dalla nuova amministrazione, che in un promemoria dello scorso febbraio aveva scritto: «È ora che i college americani smettano di foraggiare i nostri avversari stranieri con le loro decisioni di investimento, così come dovrebbero smettere di concedere l’accesso all’università ai sostenitori del terrorismo».