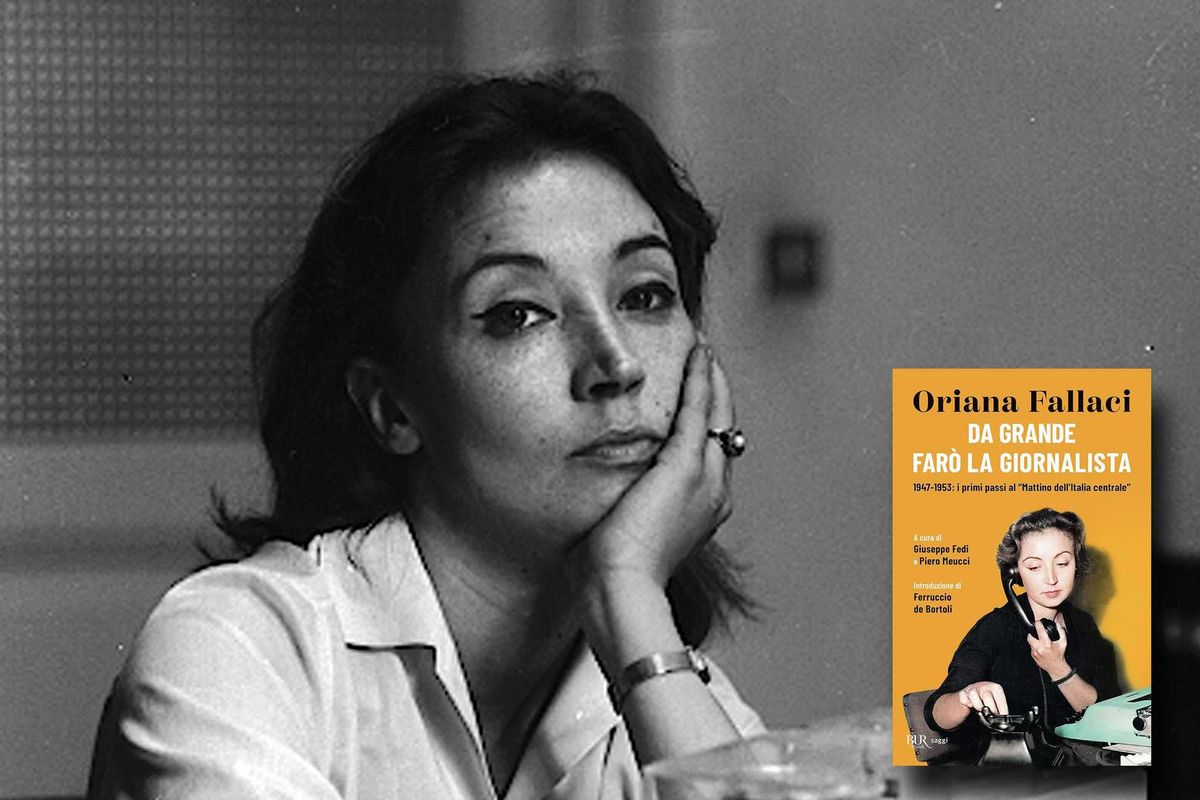Gli Usa tornano nel Caribe e puntano sulla Giamaica
- Kingston potrebbe diventare indipendente da Londra nel 2025, dopo le forti tensioni tra i due Paesi su immigrazione e riparazioni per il regime di schiavitù del passato coloniale. Il calo del debito pubblico è reale, ma dipende da forti tagli alle risorse dello Stato. Che fatica sempre più a contrastare la dilagante criminalità.
- La cultura giamaicana del rastafarianesimo si intreccia con la storia coloniale italiana nella figura controversa di Marcus Garvey, tra i massimi ispiratori del culto di Hailé Selassié e dell'etiopismo. Ma prima del 1935 si dichiarò ammiratore di Mussolini e del fascismo.
Lo speciale contiene due articoli.
La Giamaica, stato insulare caraibico famoso per la musica e le spiagge, sembra deciso a tagliare definitivamente il labile cordone ombelicale che ancora lo tiene legato alla Gran Bretagna. Re Carlo III infatti è ancora formalmente capo dello stato e nomina un Governatore Generale che amministra l’isola. Entro il 2025 la Giamaica potrebbe diventare definitivamente una repubblica, passando sia dal parlamento che da un referendum popolare, il consenso politico a questa svolta epocale è pressoché unanime fra maggioranza ed opposizione, ma dietro questa mossa ci sono precise ragioni politiche. I rapporti fra la Giamaica ed il Regno Unito sono ai minimi storici per due ragioni: la prima è la ferrea restrizione dei visti d’ingresso, sia per turismo, sia per lavoro, dei giamaicani in Gran Bretagna, la seconda, molto più pregnante, riguarda le cosiddette riparazioni per il periodo della schiavitù, questione che peraltro è stata al centro di un recente incontro dei capi di stato dei Caraibi, nel quale è stata ribadita la necessità di affrontare una volta per tutte il tema, chiedendo un vertice con le nazioni europee. Questa richiesta, oltre alle scuse ufficiali che la Gran Bretagna ha sempre rifiutato di fare, prevede anche la cancellazione del debito e una riduzione importante dei rapporti commerciali privilegiati. La situazione economica dell’isola caraibica resta comunque molto complessa segnata da una scarsa crescita economica e un alto tasso di criminalità. L’economia giamaicana dipende soprattutto dalle esportazioni di bauxite e dal turismo, ed è minacciata dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, il paese è riuscito a dimezzare il rapporto tra il Pil e il debito pubblico, passando dal 147 per cento del 2012 al 73 per cento di oggi. L’abbattimento del debito non è dovuto alla crescita economica, stabile intorno all’1%, ma a forti tagli delle spese ed un sostanzioso aumento della tassazione. Questa politica di austerità ha avuto un ampio consenso politico, ma le conseguenze di questo piano si sono fatte sentire. Tutto il settore pubblico dalla magistratura alla polizia hanno scarsi finanziamenti per combattere la criminalità dilagante, così come la scuola e la sanità che hanno chiuso diversi centri. Anche i fondi di emergenza per i disastri naturali che spesso colpiscono l’isola sono stati sensibilmente ridotti e la Banca Mondiale ha sottolineato che queste politiche d’austerità e la mancanza d’investimenti pubblici hanno frenato la crescita del paese. Nonostante una situazione piuttosto complicata qualche risultato nella lotta al crimine si vede e la polizia ha diramato dei dati incoraggianti. Gli omicidi sono calati del 16%, numeri sempre alti con 784 vittime ogni anno, più di due omicidi al giorno. Le rapine sono scese del 15%, mentre gli stupri del 32%, ma la corruzione resta un fattore determinante. Una situazione comunque lontana dagli anni ’70 quando Bob Marley riuscì a riunire sul palco di un suo concerto a Kingston i due leader politici dell’epoca Michael Manley, del People’s National Party, e il suo avversario, Edward Seaga, del Jamaican Labour Party che avevano scatenato un conflitto paramilitare urbano. Nonostante i problemi la Giamaica resta fortemente attenzionata da Washington che in primavera ha inviato il Segretario di Stato Marco Rubio in visita ufficiale che ha incontrato il Primo ministro Andrew Holness. Il responsabile della politica estera di Trump ha sottolineato l’importanza degli storici rapporti fra Stati Uniti e Giamaica e di quanto la comunità giamaicana sia parte integrante della società americana ormai da decenni. Nel bilaterale Marco Rubio ha poi affrontato la questione dei dazi, sottolineando come potrebbero essere una grande occasione per l’economia caraibica che ha nell’export verso gli Usa una parte preponderante della sua bilancia commerciale. In questo tour ai Caraibi che oltre alla Giamaica, prevedeva le Barbados, Trinidad e Tobago, St. Vincent e Grenadine e Haiti, Rubio non è però riuscito ad annullare l’accordo fra le isola e Cuba per una partnership sanitaria. Questi paesi hanno difeso il programma concordato con l’Avana, che dal Covid in poi, si è rivelato insostituibile nel sostenere servizi sanitari scadenti, o addirittura inesistenti come ad Haiti. Anche la questione del petrolio del Venezuela non è stata affrontata e per la Giamaica è stato un sollievo visto che il 70% della sua fornitura arriva proprio da Caracas. Gli Stati Uniti vogliono rafforzare la loro presa sul Caribe blandendo e minacciando i governi locali che negli ultimi anni hanno rafforzato la cooperazione, ma che restano molto legati agli Usa.
Marcus Garvey, il Ras Tafari e l'Italia. Il profeta del panafricanismo che ammirò Mussolini
La sera del 27 giugno 1980 lo spirito della Giamaica, grazie a Bob Marley, mise piede in Italia riempiendo lo stadio milanese di San Siro di una marea di giovani ansiosi di sentire dal vivo per la prima volta i suoi più grandi successi. La «leggenda del reggae», nativo di Kingston, apparve sul palco proprio nel momento in cui il Dc-9 dell’Itavia si inabissava nelle acque di Ustica, cambiando per sempre la storia italiana. Marley iniziò l’esibizione con una preghiera, sulle note di un vecchio motivo chiamato «Stalag Riddim’», che i suoi fans conoscevano come «Marley chant». Le parole richiamavano direttamente un passato in cui l’Italia coloniale fu protagonista: «Greetings..and good evening..In the name of His Majesty Emperor Hailé Selassié…Jah! Ras Tafari!» urlò nel microfono Marley salutando la folla («Saluti e buona serata...Nel nome di Sua Maestà l’Imperatore Hailé Selassié! Dio! Il Ras Tafari!»).
Per cercare il legame tra la religione rasta, nata e cresciuta in Giamaica, e l’Italia dell’impresa coloniale in Etiopia, che dal 1930 era governata dal Negus neghesti (il Re dei re) Hailé Selassiè I, bisogna ritornare in Giamaica all’inizio del XX secolo e analizzare la controversa figura di Marcus Garvey, uno dei massimi ispiratori del rastafarianesimo, un leader ben lontano dai ritmi, dai riti e dal fascino del reggae che avrebbe riempito gli stadi mezzo secolo dopo. Sindacalista, politico, mistico, Marcus Garvey era nato a Kingston nel 1887 da una famiglia di umili origini. Cresciuto nel mondo del sindacalismo nero, ebbe occasione di viaggiare in Sudamerica ed Europa. Nel 1914 diede vita all’Unia (Associazione per il progresso universale della popolazione nera), realizzazione politica delle sue teorie sulla riunificazione della diaspora africana. Alla base dell’Unia vi era un’idea fortemente nazionalista, che costituiva la spina dorsale del panafricanismo. Il sindacalista e giornalista giamaicano infatti, lungi dal rifutare l’espressione dispregiativa «negro», la utilizzò piuttosto come l’elemento fondante di una razza universale, che avrebbe dovuto con orgoglio portare il nome e raggiungere l’indipendenza politica ed economica dal mondo coloniale costruito nei secoli dai bianchi. Per raggiungere lo scopo, Garvey sviluppò una serie di attività imprenditoriali dal 1916, quando si trasferì negli Stati Uniti. Qui diede vita ad una compagnia di navigazione, la «Black Star Line» (chiara risposta alla White Star, già proprietaria del Titanic) per incrementare e facilitare gli spostamenti tra Africa e America della popolazione nera. Nello stesso periodo promuoveva, con il consistente capitale di un milione di dollari, la Negro Factories Corporation, una holding di aziende dirette unicamente da personale di colore, che negli stessi anni costituirono i primi nuclei del nazionalismo delle popolazioni afroamericane inizialmente concentrate nel quartiere newyorchese di Harlem. Nel 1930 Garvey lesse l’incoronazione del principe Tafari Maconnèn come un segno divino, e con le proprie capacità oratorie contribuì di fatto alla diffusione del rastafarianesimo. Il leader giamaicano dell’Unia si ispirò alle Sacre Scritture, in particolare nei passaggi che indicano la linea diretta di Re Salomone e della Regina di Saba nella dinastia dei discendenti di Menelik. Dall’Etiopismo e dal Kebra Nagast, libro sacro al cristianesimo ortodosso degli Abissini, Garvey attinse la profezia del ritorno del Messia sulla Terra, identificato con il Re dei Re Hailé Selassié. L’Africa sarebbe stato il luogo della rinascita dal peccato di «Babilonia» (il mondo occidentale) e avrebbe fatto da culla ad un nuovo popolo costituito da tutti gli africani uniti in una sola Nazione, sotto un’unica religione. Quando il Negus fu incoronato, l’invasione dell’Etiopia da parte delle truppe italiane era ancora relativamente lontana. Ancora pochi anni prima dello scoppio della guerra contro il Negus, Marcus Garvey non nascose la propria ammirazione per la figura del Duce. Affascinato dalla storia del primo periodo del ventennio fascista, raccontò le sue impressioni sull’Italia di Mussolini all’amico giornalista (e come lui sostenitore del panafricanismo) Joel Rogers, che lo intervistò nella sua residenza londinese di Beaumont Crescent, al quale dichiarò testualmente che «Noi Garveyani siamo stati i primi fascisti. Quando Benito Mussolini era ancora semi sconosciuto, avevamo inquadrato (con l’Unia ndr) oltre centomila uomini e fondato le organizzazioni giovanili. Mussolini ha copiato il nostro fascismo!». Il carattere nazionale e popolare dell’Italia mussoliniana fu l’aspetto che maggiormente colpì Garvey, che vide una sorta di parallelismo con le sue teorie in una nazione giovane, che aveva saputo unirsi dopo secoli di dominazioni straniere, sotto una guida che era riuscita a mantenere un carattere «proletario» pur potendo ormai competere con le maggiori potenze occidentali. Poi, nel 1935, l’attacco italiano cambiò naturalmente la sua prospettiva sull’Italia fascista. Tuttavia, nonostante la mitizzazione dell’Etiopia come centro spirituale della nuova Africa, colui che è ancora considerato tra i massimi ispiratori del rastafarianesimo e del «Black Power» che emerse in America alla fine degli anni ‘60, fu tutt’altro che tenero con la figura di Hailé Selassié. L’andamento della guerra, che portò le truppe italiane a Addis Abeba e all’esilio londinese del «Negus Neghesti», portò il leader dell’Unia a criticare pesantemente l’operato dell’imperatore-messia. Selassiè si era mostrato debole e soprattutto «corrotto» dai consiglieri britannici, bianchi e fautori del colonialismo, che lo avevano portato alla fuga e al rifugio sotto la propria protezione. Neppure i neri furono risparmiati nella rabbia per la sconfitta, accusati di essere stati dei guerrieri indisciplinati ed inadeguati, i quali non avrebbero fatto tesoro delle teorie del nazionalismo panafricano contenute nelle sue teorie, a lungo esposte per mezzo della voce dell’Unia. Un finale amaro per Garvey che, a causa di queste ultime dichiarazioni contro il «Re dei Re», si alienò buona parte dei suoi seguaci nel mondo del panafricanismo, terminando la propria carriera di predicatore e leader dell’emancipazione dei neri del mondo praticamente isolato. La sua eredità, privata degli aspetti più esasperatamente separatisti e nazionalisti, fu raccolta in Giamaica anni dopo la fine della seconda guerra mondiale dal movimento religioso dei Rastafariani, dai quali nacque anche la cultura reggae. Per una coincidenza quasi cabalistica, Marcus Garvey morì il 10 giugno 1940, il giorno dell’ingresso dell’Italia in guerra.