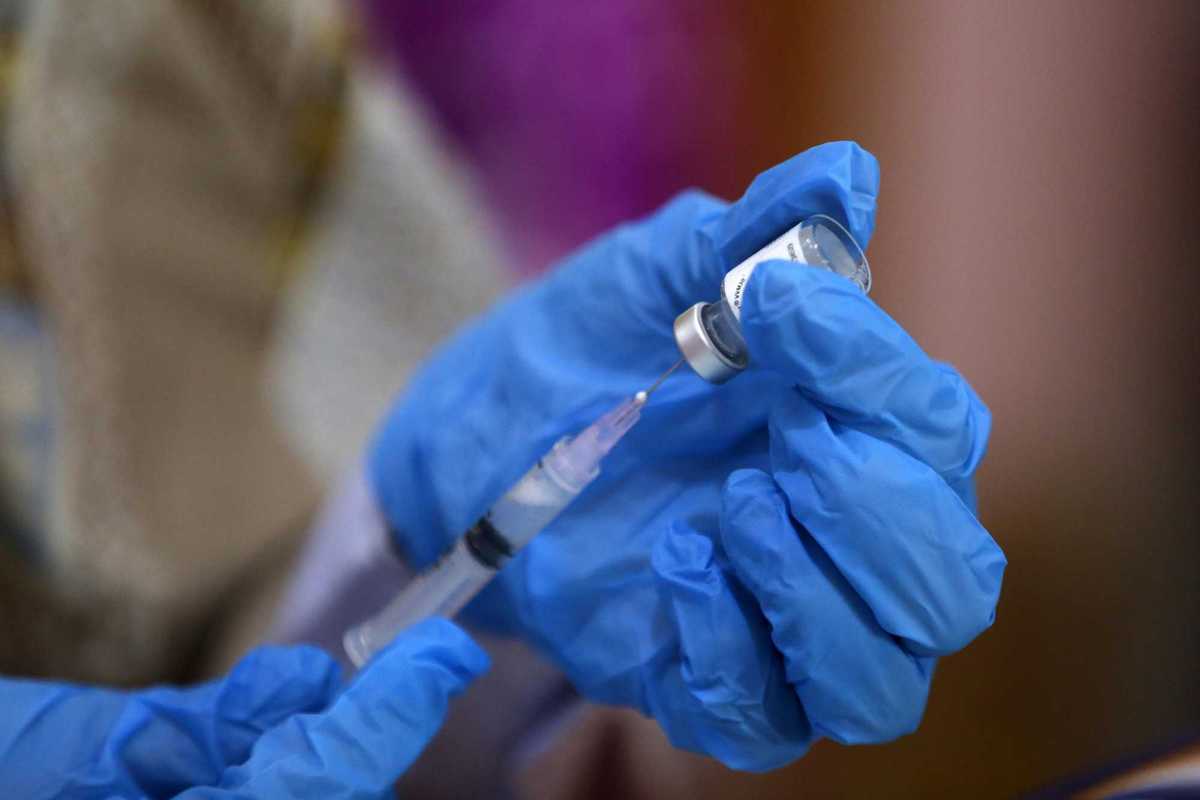Gli iraniani non fanno sgarbi a Biden per incassare l’accordo sul nucleare

Dopo l'uccisione dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi le autorità del regime di Teheran brancolano nel buio. Le indagini finora non sono approdate a nulla di concreto: solo ipotesi sugli attentatori. È più facile, quindi, per mantenere viva l'attenzione sui responsabili (e i loro mandanti), incolpare non gli americani, come si è sempre fatto in passato, ma Israele, il nemico storico di Teheran. Gerusalemme non ha smentito ufficialmente, ma ha fatto capire apertamente che gli israeliani non c'entrano nulla, anche perché dicono di non avere alcun interesse a provocare reazioni dei pasdaran con azioni terroristiche che potrebbero scatenare una nuova guerra, mettendo in imbarazzo gli Stati Uniti, in una delicata fase di transizione (Donald Trump - Joe Biden) .E forse anche la Russia di Vladimir Putin, che si è impegnata a sostenere il regime iraniano in caso di attacco militare esterno. Intanto chiariamo subito che lo scienziato ucciso non era un civile (come lo ha definito l'altra mattina «Radio anch'io» di Rai Radio 1 in un'ambigua trasmissione), ma un alto dirigente del regime: è stato responsabile del programma nucleare iraniano per molti anni, era un autorevole ufficiale dei Guardiani della rivoluzione (i pasdaran), oltre che docente di fisica all'Imam Hussein University di Teheran ed ex responsabile dell'Iran's physics research center. Ed era anche responsabile del programma nucleare segreto (nome in codice «Amad») per produrre armi nucleari, a partire dalla bomba atomica e dai missili a lunga gittata armati con testate nucleari. Un piano, questo, che è stato rilanciato e portato avanti, sempre segretamente, nei siti militari, come è stato documentato (sulla base di prove, anche fotografiche, della resistenza iraniana) su Panorama la scorsa settimana.
A questo punto si fanno tre ipotesi sui responsabili dell'attentato. La prima riguarda gli Stati Uniti (che il regime finora ha accuratamente ignorato per non creare ombre sul nuovo presidente Biden, che potrebbe essere disponibile a rientrare nell'accordo sul nucleare. Ad esempio, l'ex direttore della Cia, John Brenner (obamiano) ha fatto capire, in una dichiarazione, che è in corso una lotta fra trumpiani e democratici anche sul caso Iran. Qualche gruppo, legato alla Cia, può avere quindi realizzato o favorito l'attentato per mettere in difficoltà Biden. Non è la prima volta che si verificano attentati contro scienziati iraniani. Già ai tempi di Barack Obama (con Brenner alla Cia) ricordiamo, il 29 settembre 2010, l'uccisione del noto scienziato Majid Shahriari e, successivamente, altri quattro ricercatori nucleari sono stati uccisi fra il 2010 e il 2012. Ma il presidente Hassan Rouhani ha deciso di non parlare dei «vecchi» attentati e di scaricare ogni responsabilità su Israele, anche in mancanza di prove.
La seconda ipotesi riguarda le diverse componenti del regime, fra falchi e colombe. I primi sono collegati direttamente a Khamenei, la massima autorità dello Stato, e si appoggiano all'organizzazione dei pasdaran e dell'esercito; le seconde su una parte degli ayatollah che fanno riferimento al capo del governo, Rouhani. Entrambe le fazioni sperano nel rientro degli Usa nell'accordo nucleare e nella cessazione delle sanzioni americane che potrebbe rilanciare l'economia iraniana, in grave dissesto soprattutto dopo la pandemia del coronavirus che ha provocato, finora, quasi 50.000 morti (cifre truccate secondo la Resistenza iraniana che parla di oltre 200.000 decessi). Non è escluso che anche qualche gruppo estremista, legato ai Guardiani della rivoluzione, abbia organizzato un attentato allo scienziato nucleare per impedire un avvicinamento di Teheran agli Usa, in vista del cambio di presidente e tenere viva così la tensione nel Medio Oriente.
La terza ipotesi (ma è la meno condivisibile) è legata alla resistenza iraniana, che contava da qualche anno anche sull'appoggio di Trump e di molti dirigenti della Casa Bianca, a partire da Rudolph Giuliani. Non pensiamo comunque che il Consiglio della resistenza (presieduto da Maryam Rajavi) abbia favorito un attentato di questa natura. Ma sappiamo bene che l'area del terrorismo islamico è variegata, politicamente e ideologicamente, non è quindi da escludere in assoluto qualche «scheggia impazzita» autonoma, che possa avere favorito, all'interno dell'Iran, un attentato contro chi veniva definito il «padre» dell'atomica iraniana. Il Consiglio della resistenza (che ha sede a Parigi e in un villaggio costruito a Tirana, in Albania) ormai da molti anni ha abbandonato la lotta armata, scegliendo metodi pacifici di azione politica, coinvolgendo tutte le istituzioni democratiche (a cominciare dalla Ue). Non a caso - proprio in questi giorni - 240 parlamentari europei che rappresentano i gruppi politici di 19 Paesi e del Parlamento europeo hanno inviato una dichiarazione a tutti i governi per invitarli a modificare le loro relazioni con la Repubblica islamica per garantire la cessazione di ogni azione terroristica in Europa (com'è noto, è in corso un processo in Belgio contro un diplomatico iraniano, Assadollah Assadi, incriminato insieme ad altri iraniani, per un attentato terroristico al raduno della Resistenza iraniana a Parigi nel 2018 ). A questa iniziativa hanno aderito 42 senatori e deputati italiani. «Teheran», ci ha dichiarato Giulio Terzi di Sant'Agata, ex ministro degli Esteri, «continua a disattendere gli impegni assunti, compresi i trattati in vigore in materia di lotta al terrorismo, di tutela delle minoranze, di rispetto dei diritti umani, di non proliferazione, di abolizione della tortura, di trattamento dei prigionieri politici e di molto altro». Ecco, se non fosse già noto ,che cosa è l'Iran oggi.