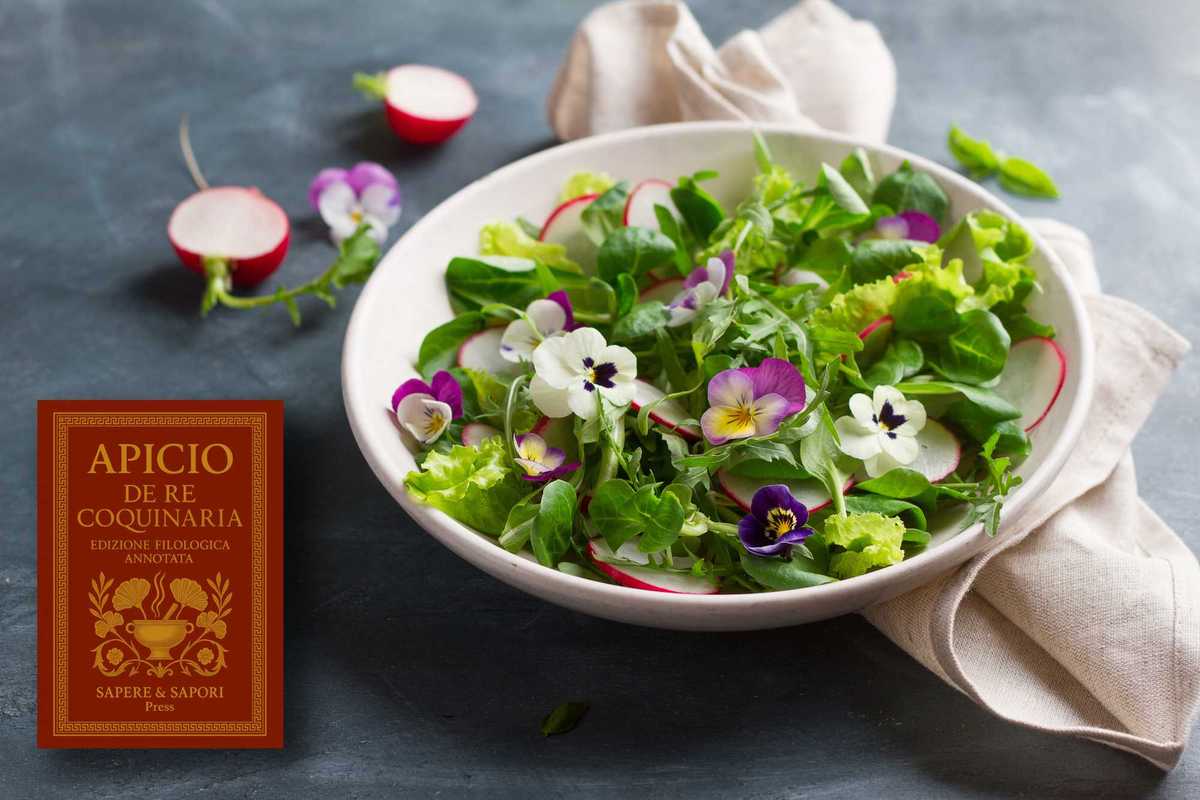I giudici tedeschi s’inchinano alla Ue. No al ricorso sul fondo per la ripresa

È accaduto quanto era largamente previsto che accadesse. La Corte costituzionale tedesca ha ritenuto di respingere la richiesta di un'ordinanza preliminare per bloccare la ratifica della Decisione sulle risorse proprie da parte del Bundestag. Il 26 marzo, dopo che le Camere si erano espresse favorevolmente, la firma del presidente della Repubblica, Frank Steinmeier, era stata bloccata dalle toghe rosse di Karlsruhe.
Dopo circa 4 settimane, c'è il via libera della Corte e la Decisione di dicembre che stabilisce le modalità di finanziamento dei 750 miliardi del Next generation Ue (Ngeu), oltre che del bilancio pluriennale 2021-2027, si avvicina alla meta dell'approvazione da parte di tutti i 27 Stati membri.
Allora il Ngeu, dopo una gestazione di quasi un anno (è del 28 maggio 2020 la pubblicazione delle prime bozze da parte della Commissione) è pronto per decollare? Forse, ma ne esce parecchio malconcio. Anche se già subito dopo il 27 marzo, vi avevamo riferito della improbabilità che questa disputa avrebbe potuto bloccare il fondo per la ripresa, le tre pagine con cui i giudici tedeschi danno semaforo verde alla ratifica prima di tutto non chiudono la vicenda e poi pongono dei pesanti macigni sulla strada di qualsiasi tipo di sogno europeo, dagli eurobond, al bilancio comune.
I giudici hanno fatto un ragionamento molto chiaro: essendo chiamati ad un giudizio sommario e preliminare - il giudizio di merito richiederà probabilmente qualche anno - hanno soppesato le conseguenze di bloccare tutto subito e poi ritrovarsi tra qualche anno a promuovere la Decisione o, in alternativa, le conseguenze di dare oggi il via libera e poi bocciare tutto in futuro. Nel primo caso ci sarebbero «svantaggi irreversibili», proprio per la natura del Ngeu. Un fondo per la ripresa serve ora, non in futuro, quando sbloccarlo non servirebbe a nulla.
E hanno così deciso per la seconda opzione, meno gravida di conseguenze irreparabili. Ma la gravità di tali conseguenze non è stata direttamente accertata da loro. Da Berlino hanno fatto capire a Karlsruhe che non era il caso di mettersi di traverso, e loro hanno obbedito, scrivendo pure a chiare lettere che hanno tenuto conto della valutazione del governo federale tedesco - che la Corte «è tenuta a rispettare» - secondo cui la mancata ratifica della Decisione sulle risorse proprie avrebbe messo in notevole difficoltà le relazioni europee ed internazionali. Un'ammissione di Realpolitik che ha poco a che vedere con il diritto.
Pur non essendo escluso che le ragioni dei ricorrenti siano fondate - riconoscendo che non sono né inammissibili e né chiaramente infondate - l'esame preliminare dei giudici conclude che non ci siano gli estremi per bloccare tutto sin d'ora, in quanto non appare esserci «un'elevata probabilità» di violazione della Costituzione tedesca e dei Trattati.
i giudici scandiscono in modo chiaro almeno due principi che mortificano qualsiasi sogno europeo.
Il primo consiste nella supremazia del Bundestag in tutte le decisioni di spesa riguardanti denaro dei cittadini tedeschi. Anche quando vengono destinati fondi a strumenti sovranazionali come il Ngeu - purché non sia permanente, con buona pace di Enrico Letta - il Parlamento deve poter esercitare una «sufficiente influenza sulle modalità di utilizzo di quei fondi».
Il secondo consiste nel ribadire che l'impegno finanziario della Germania (e di tutti gli Stati membri) è limitato e non può condurre a esborsi imprevedibili. Quindi ognuno ha il suo debito, fino all'ammontare massimo del 0,6% del reddito nazionale lordo annuo, che per la Germania equivale a 21 miliardi, in teoria sufficiente a coprire gli oneri di rimborso del debito emesso per il Ngeu, in caso di default di tutti gli Stati membri. Proprio per l'esistenza di un limite che è peraltro estremamente improbabile che venga toccato, il Bundestag non rinuncia affatto al potere di essere «padrone delle proprie decisioni», concludono i giudici, però mettendosi così di traverso a ipotesi di debito comune europeo.
Infine, non è escluso che la Decisione sulle risorse proprie violi il divieto di «bail out», cioè di aiuto finanziario reciproco tra Stati e il principio di saldo di bilancio in pareggio, con il divieto quindi di contrarre debiti per finanziare spese eccedenti le entrate. Altri due siluri lanciati verso il Titanic Europa, prima dell'affondo finale secondo cui, qualora dal giudizio di merito emergesse che c'è invece violazione della Costituzione, sarebbe compito di governo e Parlamento tedesco «ripristinare l'ordine costituzionale con ogni strumento disponibile».
Ed il governo tedesco, stando a quanto pubblicato martedì in prima pagina dal quotidiano spagnolo El Pais, si sta già portando avanti col lavoro e ha cominciato con la Spagna. Alla quale il 1° marzo, durante la discussione all'Ocse dei rapporti Paese, ha avuto l'ardire di chiedere «un piano pluriennale di aggiustamento di bilancio», presentando un apposito rapporto che gli Usa e altri economisti hanno definito come privo di senso economico e del tutto intempestivo.
Nulla di cui meravigliarsi, è la Costituzione tedesca che reca scolpita la regola di non ammettere spese e debiti non decisi dal Parlamento, ed è normale che i tedeschi chiedano - come fecero nel 2010, condannando la Ue a una seconda recessione - un consolidamento di bilancio per timore di ritrovarsi a pagare conti indesiderati. Soffre di questa influenza tedesca pure il Def presentato da Mario Draghi e Daniele Franco: credevamo che frasi come «risparmi di spesa e aumenti di entrate per conseguire il 3,4% di deficit/Pil nel 2024» fossero state definitivamente archiviate ma, a quanto pare, il capo condomino tedesco non demorde.