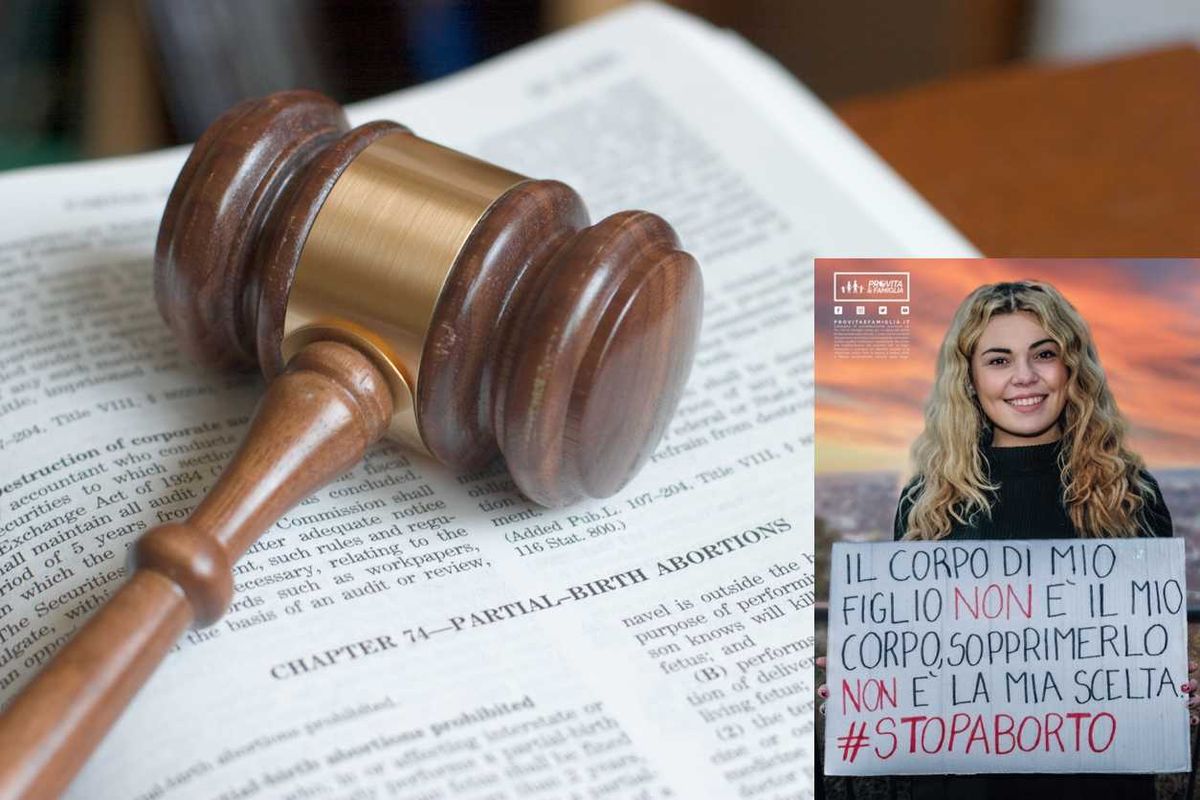Sempre meno nipponici sono interessati a questa disciplina, per anni considerata sport nazionale e ora scavalcata dal baseball, più in vetrina e popolare grazie al merchandising. E negli ultimi anni il primato è passato nelle mani dei lottatori mongoli, più predisposti ad accettare le rigide regole imposte dalle scuole.
Tradizione, arte, cultura, spiritualità, sacrificio. C'era un tempo, non poi così lontano, in cui tutti questi concetti erano racchiusi in un'unica disciplina, nata in Giappone all'inizio del Sesto secolo: il sumo. Oggi, e in particolare negli ultimi anni, il sumo, inteso sia come sport sia come elemento contraddistintivo della più profonda e radicata cultura nipponica appare sempre più in crisi. Sempre meno giapponesi sono interessati a questo sport e sempre meno ragazzi si iscrivono alle scuole di sumo. Dietro questo fenomeno ci sono diversi fattori, in parte legati ai recenti scandali che hanno travolto il sumo, dai numerosi casi di doping alle scommesse che ne hanno fatto calare l'interesse a vantaggio del baseball che ha potuto sfruttare la vetrina del merchandising, e in parte a un cambiamento sociale che ha coinvolto le nuove generazioni, le quali rispetto a 20-30 anni fa, quando i giovani provenienti da zone rurali e da famiglie poco agiate intravedevano nel sumo l'occasione del riscatto, si trasferiscono appena possibile nelle grandi città del Paese per intraprendere le carriere universitarie o lavorative, con stili di vita sempre più distanti da quello richiesto dalla pratica del sumo, fatto di rigide regole, totale disciplina e obbedienza.
Essere iscritti in una scuola di sumo, «heya», significa far parte di una grande famiglia dove si vive, si studia e si impara l'arte della lotta corpo a corpo. Il rispetto delle regole, come per esempio andare a letto tutti alla stessa ora e non consumare alcolici, vale per tutti e i maestri sono intransigenti.
C'è poi anche una questione morale. Nella società odierna, sempre più governata da ciò che è politicamente corretto e ciò che invece non lo è, uno sport praticato esclusivamente da uomini non è ben visto e perde di considerazione. Il sumo professionistico, infatti, non è ancora aperto alle donne, che possono praticarlo soltanto a livello amatoriale. Il motivo è da ricondurre a un'antichissima tradizione che ritiene le donne impure a causa del sangue mestruale che contamina un luogo sacro quale il «dohyo», ossia il ring in argilla sul quale si svolgono gli incontri. Prima di ogni incontro, infatti, il «dohyo» viene purificato dai sacerdoti shintoisti attraverso una cerimonia durante la quale, per imprigionare gli spiriti maligni, viene praticato al centro del ring un buco e riempito con noci, alghe, calamari essiccati e sakè. Quando uno dei lottatori perde sangue l'incontro viene sospeso e il «dohyo» viene cosparso di sale per purificarlo. Pochi anni fa, nel 2018, durante un incontro a Maizuru, una città della prefettura di Kyoto, il sindaco ebbe un malore mentre pronunciava il suo discorso sul «dohyo» e una dottoressa presente tra il pubblico che era salita sul ring per prestare soccorso venne invitata dagli organizzatori ad allontanarsi subito perché stava contaminando un luogo sacro. In origine, il sumo era percepito dalla popolazione giapponese come un rituale per intrattenere gli dei dello shintoismo, religione politeista che prevede l'adorazione dei «kami», ossia le divinità e gli spiriti naturali.
In questo vuoto si sono infilati con abilità, costanza e tenacia i vicini di casa della Mongolia, che ormai da 20 anni a questa parte dominano la scena mondiale del sumo. È abbastanza eclatante il dato che racconta come dal 2002 al 2016 i lottatori mongoli hanno trionfato in 81 campionati su 88 per quanto riguarda la massima divisione giapponese, nonostante la limitazione che permette la presenza di un solo atleta straniero per ogni scuola di sumo. Di fatto una violazione di un monopolio durato e difeso per secoli e messo in discussione dalla maggiore fame di riscatto sociale degli atleti mongoli, sempre più determinati a raggiungere i livelli più alti di questa disciplina e spinti dall'obiettivo di poter un giorno aiutare e risolvere i problemi delle loro famiglie, considerando che un lottatore - in gergo «yokozuna» - che si spinge fino alla massima divisione arriva a un ingaggio di due milioni di dollari a stagione.
Tale popolarità diffusa aggiunta alla natura gladiatoria della graticola rende il calcio un terreno fertile per il nazionalismo. Il sumo potrebbe non avvolgersi nella bandiera allo stesso modo della NFL, ma quando uno sport può far risalire la sua storia a due millenni ed è menzionato nel più antico testo storico giapponese conosciuto, non sorprende che ci siano elementi della società che preferirebbe tenerlo libero da ogni influenza straniera. Questo è un obiettivo che è diventato urgente solo nelle menti di coloro che vedono il recente dominio mongolo del sumo come una sorta di evirazione dell'orgoglio giapponese. Per essere onesti, la maggior parte di quel sentimento proviene da fonti esterne. Vivere e allenarsi insieme a rikishi e stablemasters nati all'estero è qualcosa che la maggior parte dei lottatori giapponesi sperimenta su base continuativa. Quelli all'interno dello sport hanno meno probabilità di avere opinioni controverse sulla "purezza" del sumo rispetto agli accademici o ai commentatori che vengono regolarmente portati fuori nei talk show o nominati in comitati o panel incaricati di migliorare il sumo. Quando tutti i tuoi consiglieri sono martelli con un'inclinazione nazionalistica, ogni straniero comincia a sembrare un chiodo che deve essere abbattuto.
Il protezionismo e la discriminazione non sono esclusivi del sumo e nemmeno del Giappone. il sumo deve affrontare problemi molto più urgenti e seri come la salute e la sicurezza dei suoi lottatori.