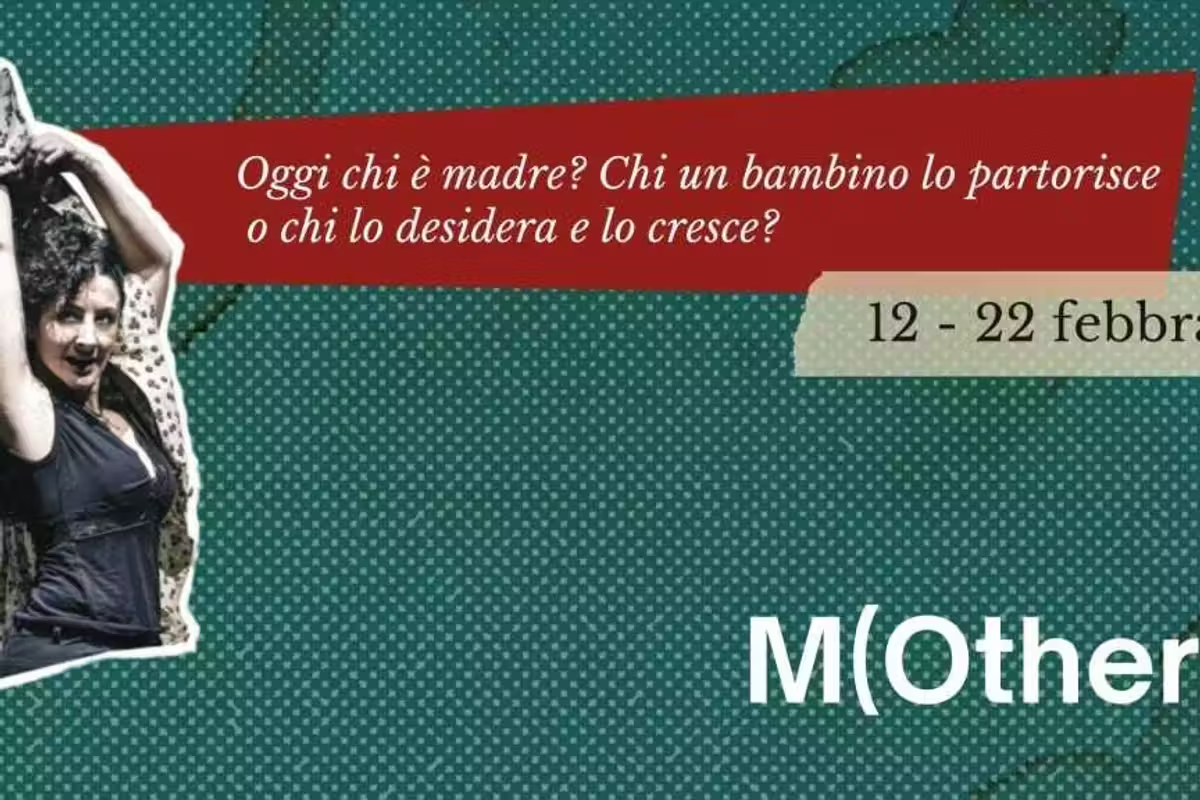Ennesima fiducia sul lasciapassare. Il Parlamento ormai è l’ufficio timbri

E con questo, il quinto in 48 ore, sono 18. Un voto di fiducia ogni 12 giorni, da quando a Palazzo Chigi si è insediato Super Mario Draghi. Che forse non è «l'uomo della provvidenza», come crede il cardinale Gualtiero Bassetti. Ma sicuramente, come dice Carlo Bonomi di Confindustria, è «l'uomo della necessità». Che è il contrario della possibilità, quindi della politica.
Ieri, il governo, che vanta la più ampia maggioranza della storia, ha chiesto la fiducia al Senato sul decreto green pass bis, quello che estende il lasciapassare a scuola e trasporti. Perché? Sicuramente non per il rischio di andare sotto. Non sarebbe affondato nemmeno se - scenario impossibile - tutta la Lega avesse votato contro. Alla fine, l'esecutivo ha incassato 189 sì, 31 no e nessuna astensione. C'era di mezzo l'urgenza? C'era bisogno di tagliare corto ed evitare emendamenti e discussioni in Aula? Sarà. Ma qualcuno sta scordando che è questa l'essenza della democrazia parlamentare. Un orpello del passato? Può darsi. Eppure, Draghi aveva promesso di rispettare le Camere. Le quali - siccome c'è l'emergenza, siccome bisognava vaccinare, siccome andavano messi in cassaforte i soldi dell'Europa, siccome, al solito, si deve «fare presto» e la necessità, appunto, ha preso il posto della deliberazione - gli hanno accordato il timbro su tutto. Una scelta obbligata, sì, ancorché foriera di effetti collaterali: se non ti assumi la responsabilità di occupare uno spazio politico che ti spetta, lo occuperà un altro al posto tuo.
Dove sono, adesso, i difensori delle prerogative dell'Aula? A giugno 2019, quando ancora stava con il Carroccio, il presidente della Camera, Roberto Fico, ammonì il premier, Giuseppe Conte: «Troppi decreti, garantire condizioni più equilibrate nell'esercizio della potestà legislativa tra governo e Parlamento». A ottobre e dicembre 2020, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rimproverava l'avvocato del popolo, nel frattempo diventato giallorosso: «Troppi dpcm, il governo scavalca le Camere con le fiducie e crea confusione sul Covid». E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto il coraggio di muovere rimostranze persino all'intoccabile Draghi, lamentando l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e minacciando, addirittura, di non firmare più le leggi, invocando l'articolo 74 della Costituzione. Dove sono, oggi, quelli che hanno tentato una sacrosanta difesa delle Camere? A quanto pare, l'inquilino del Colle, stavolta, preferisce inseguire le prescrizioni dell'esecutivo: il Quirinale ha fatto sapere che stabilirà le modalità con cui disciplinare l'utilizzo del green pass, a partire dal 15 ottobre, dando seguito all'ultimo dl.
La mannaia verde s'è abbattuta anche sul legislatore, alla faccia dell'autodichia, che evidentemente è meno forte della strizza di finire bersagliati dai mal di pancia antipolitici. A Montecitorio è stato deciso che ai deputati non in regola sarà interdetto l'accesso e sarà sospesa la diaria per 15 giorni. Mentre è una mezza bufala quella dei tamponi gratis per i «privilegiati», i quali, comunque, si sottopongono già a una ritenuta di oltre 700 euro al mese per finanziare il fondo comune, al quale s'attingerà per pagare i test anti Covid. Capolavori della retorica sulla «casta»: ovviamente, nessuno si strapperà i capelli per il definitivo svuotamento di un Parlamento già ridotto a una farsa, già screditato, delegittimato (anche per colpa dei partiti, che l'hanno riempito di personaggi grotteschi), ormai persino «tagliato». Il circolo vizioso, poi, non potrà che tradursi in ulteriori umiliazioni, ulteriori infornate di politici di bassissima caratura e, a ruota, in dileggio e nuove usurpazioni.
D'altronde, l'Aula non viene semplicemente dissanguata dall'assalto interno, da parte di un governo sempre più prevaricatore, accentratore, insofferente ai tempi della democrazia e, forse, alla democrazia stessa. Non è costretta a subire solo gli ultimatum della Corte costituzionale, che anziché controllare la compatibilità delle norme con la Carta fondamentale, s'è messa in testa di dover «dinamizzare» l'ordinamento giuridico (citiamo Marta Cartabia). E, di conseguenza, prescrive modi e tempi per colmare supposti «vuoti legislativi». Il Parlamento, a questo punto, è assediato anche dall'esterno. Dalle piazze, reali o virtuali, che lamentano, magari a ragione, l'immobilità della politica. La sua incapacità di decidere. La sua sordità alle istanze della società civile, altro attore politico di un'era convulsa, tanto fumoso quanto celebrato fino alla nausea. Di qui, la recente proliferazione delle iniziative referendarie. Che - chiariamolo - non sono un male in sé. Anzi, rappresentano un'occasione di partecipazione, la chance per scuotere una classe dirigente bradicardica.
Pure in questo caso, tuttavia, si va perdendo il senso del limite. Quesiti sulla giustizia, iniziative sull'eutanasia, sulla cannabis, peraltro impacchettate con l'insidiosissimo nastrino pop della raccolta firme online. Una novità da era degli influencer, che ha facilitato il successo dei referendum (ieri, ad esempio, l'associazione Luca Coscioni festeggiava il milione di sottoscrizioni), suscitando, al contempo, le perplessità dei giuristi, peraltro di sinistra: da Giovanni Maria Flick a Vladimiro Zagrebelsky, all'onorevole dem Stefano Ceccanti.
Il problema è che il referendum, da pungolo, si sta trasformando in arma contundente. Da strumento di pressione, in mezzo di sfondamento. Da veicolo di istanze popolari, in grimaldello per eterodirigere l'attività legislativa. Un aspetto deteriore del grillismo (ve li ricordate la democrazia diretta e il Parlamento da abolire?), sul quale, i molti che hanno bisogno dei 5 stelle per stare a galla, ora tacciono. Perché la Carta dice, sì, che la sovranità appartiene al popolo. Però precisa che esso «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». È ancora lei, la «più bella del mondo»?