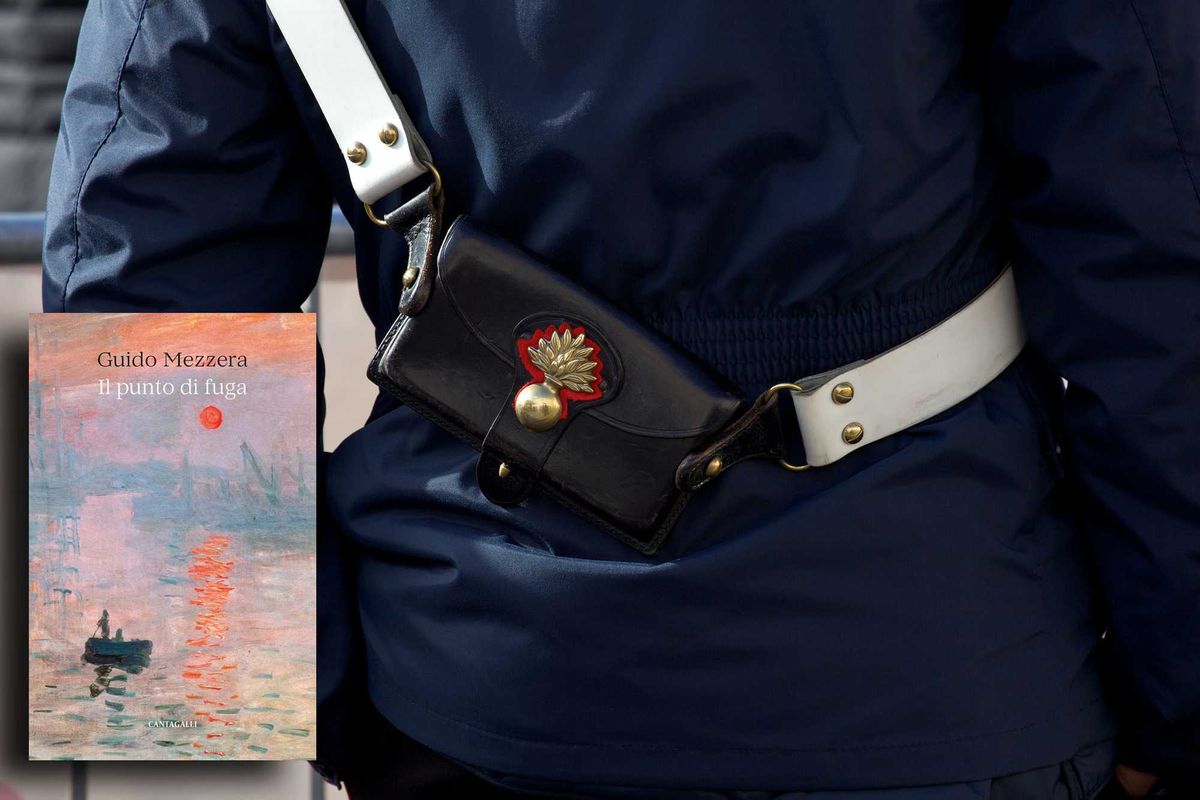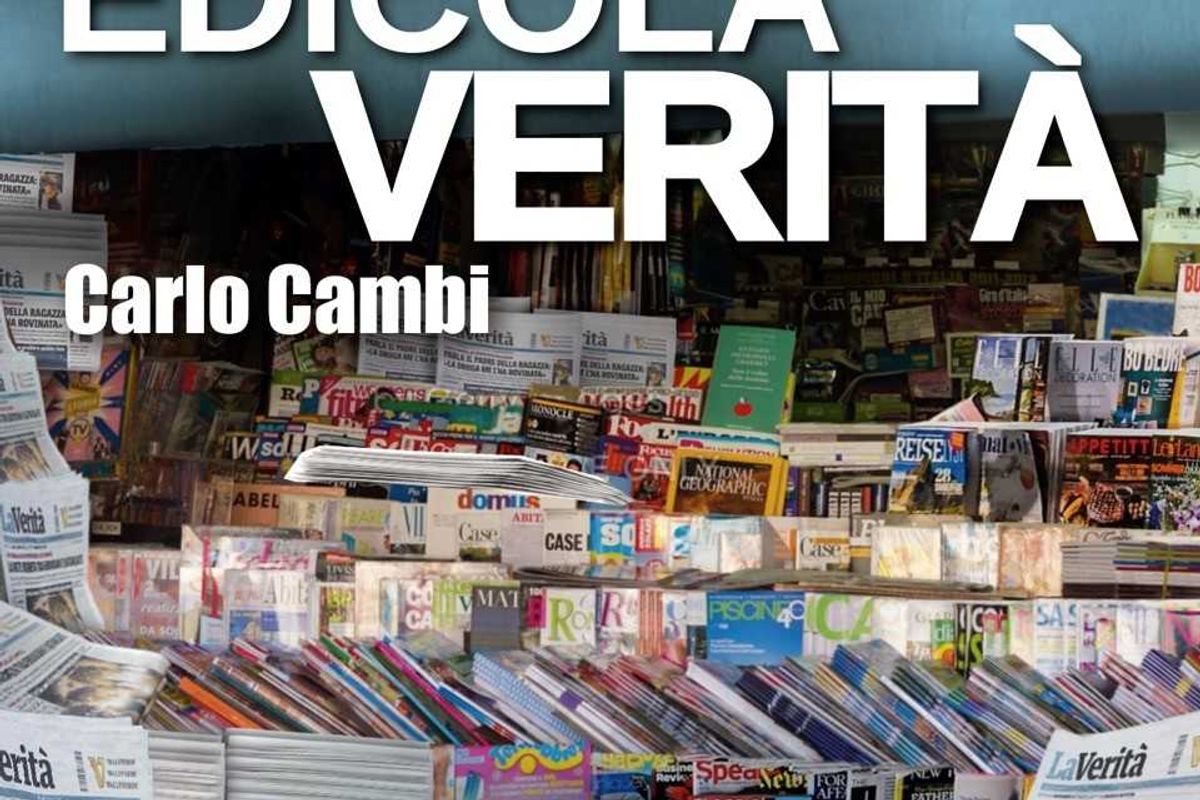Due «cartabiate» hanno trasformato la funzione originaria della Consulta

Come ogni giudice, anche quello costituzionale ha la tendenza a considerare di bassa lega l'interpretazione letterale della legge, preferendo distillarne lo spirito. Il rischio è poi, effettivamente, quello di alzare troppo il gomito e uscire barcollando dal seminato. La Consulta ha davvero il vizietto di mettere i piedi in testa al Parlamento. Il sistema consente infatti al Sinedrio di sostituirsi al legislatore, introducendo tra noi norme e valori dettati da proprie visioni del mondo.
In genere, i Quindici giocano di sponda col magistrato ordinario che, durante un processo, ritenendo di dubbia costituzionalità una norma da applicare, la trasmette alla Corte chiedendole di pronunciarsi. Spesso c'è della pantomima. Si sa già che il domandante finge di domandare e che, in realtà, rifiuta la norma perché cozza contro i suoi principi, lo Spirito del Tempo e quant'altro gli frulli in capo. Se la Corte è dello stesso umore, dichiara l'incostituzionalità e toglie la legge di mezzo, mettendo così i piedi nel piatto dell'attività legislativa.
La Corte, ebbra di questa sua discrezionalità, poiché controlla ma non è controllata, si è lanciata sotto la presidenza di Marta Cartabia (poi guardasigilli del gabinetto Draghi) in due iniziative datate 2020 che la dicono lunga. La prima è che la Consulta si è «aperta alla gente», alle «voci di fuori», come è stata presentata l'innovazione. Ora sono infatti ammessi nei giudizi costituzionali gruppi di pressione esterni, interessati alla vicenda che si dibatte. Hanno il diritto di illustrare le proprie posizioni e produrre memorie. Pensiamo alle questioni delicate su cui c'è pubblico dibattito - aborto, utero in affitto, suicidio assistito ecc. -, la Consulta, prima di decidere, ascolterà le tesi delle associazioni gay o dei movimenti pro vita, e ne terrà conto nella decisione. La cosa potrà piacere o no, ma il punto è un altro.
La Corte, che doveva solo stabilire se la legge ordinaria rispettava la norma costituzionale, un confronto quasi visivo tra i due testi, trasforma la sua analisi in attività legislativa vera e propria. Infatti, la presenza delle «voci di fuori» si giustifica solo con la volontà di dare all'articolo della Costituzione sotto esame un'interpretazione innovativa - «dinamizzante» nel gergo dei Quindici - che travalichi il testo e tenga conto di tutto ciò che brulica nella contemporaneità, drammi e ghiribizzi, sentimenti e vizi. Questo però significa rubare il mestiere al Parlamento, il solo preposto ad ascoltare la società prima di legiferare. Se anche le magistrature soggette a null'altro che alla legge, o alla Costituzione nel nostro caso, fanno come i parlamentari che captano nelle piazze e nelle cene le opinioni circolanti per poi sostenere nella stesura di una norma questo o quel gruppo, beh, scusate, non c'è più religione. C'è, piuttosto, in questo attivismo della Corte costituzionale, il rischio che sdruccioli nella più totale incostituzionalità. E a me, come popolo sovrano che aveva affidato la confezione delle leggi ai propri eletti, potendoli, in base al risultato, punire o confermare, mi vengono le furie che ora a legiferare siano 15 convitati di pietra su cui non ho presa.
La seconda cartabiata, se posso così esprimermi, è la decisione di non decidere, delegando ad altri il lavoro della Corte. A chi? Alla Corte di giustizia europea in base al criterio della «leale collaborazione tra Corti». Oggetto del contendere sono i sussidi di maternità agli stranieri, che in Italia spettano unicamente a chi già vi risiede da almeno cinque anni. Imbattendosi in uno di questi casi e parendole ingiusta la faccenda, la Cassazione ha trasmesso alla Consulta la norma discriminatoria chiedendo lumi sulla sua costituzionalità. A fine luglio 2020 però la presidente Cartabia, anziché stabilire con i sagaci colleghi se il limite dei cinque anni stonasse con la nostra Costituzione, se n'è lavata le mani e ha spedito la pratica in Lussemburgo. Escludendo che la signora volesse sfuggire al solleone e correre ai bagni, per quale ragione rinunciava alla propria giurisdizione, consegnando oltreconfine le sorti di una legge italiana?
Toccherebbe al Parlamento, che ha varato la normativa sugli assegni familiari, battere i pugni. Una cosa è che sia la Corte costituzionale italiana ad abrogare la legge, magari invocando una norma europea. È previsto dal nostro ordinamento e rientra nella routine. Tutt'altro è che sia una Corte estera a condannare una legge italiana. Questo scardina nel profondo il sistema, confligge con la sovranità dello Stato e umilia il Parlamento nazionale, costretto a subire, via Lussemburgo, una (eventuale) bacchettata Ue sul proprio operato. La Consulta, mi pare, rinunciando alla competenza, ha non solo mancato al suo dovere ma indebolito l'Italia. L'opposto della Corte costituzionale tedesca che, sempre nel 2020, ha riaffermato il principio nazionale. Infatti, giudicando contrari agli interessi germanici i finanziamenti della Bce ai Paesi in difficoltà, ha messo alle strette la Banca centrale europea, chiamandola a giustificarsi. Due mondi opposti: la Germania agguanta un organo Ue e lo striglia, l'Italia cede a un organo Ue e si fa strigliare.