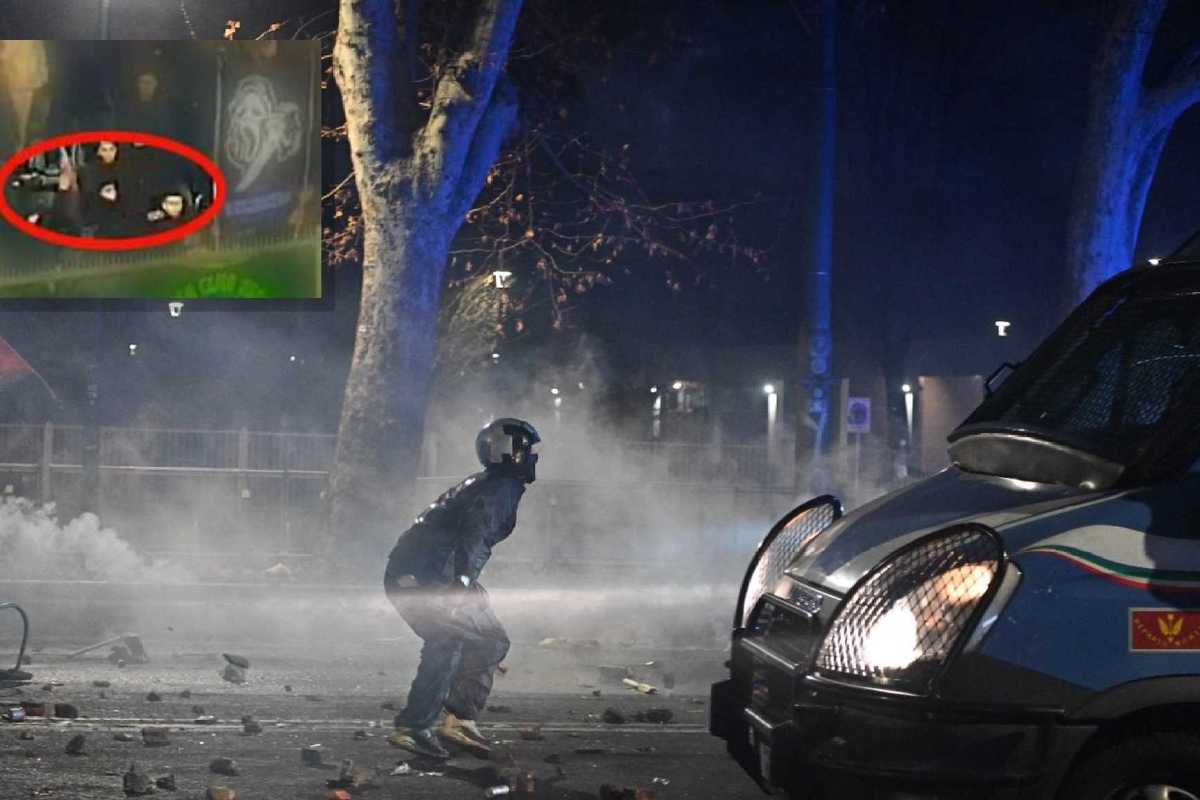Le donne e la patria: quando il femminismo italiano era nazionalista

Dal Risorgimento al fascismo, le attiviste per l’emancipazione della donna hanno sposato la causa patriottica. È solo dopo il 1945 che il movimento assume una dimensione anti identitaria.
L'onda lunga dell'8 marzo e dello «sciopero transfemminista», complice anche l'ascesa delle due leader politiche donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, ripropone, come ciclicamente avviene, il tema del femminismo e delle sue connotazioni politiche. Oggi pare scontato: il femminismo è di sinistra e la destra è antifemminista. Tant'è che fior di intellettuali ci hanno spiegato che il fatto di avere per la prima volta un premier donna non costituisce comunque un passo avanti per la condizione femminile in Italia, dato che le idee della Meloni avrebbero la meglio sulla sua appartenenza a quel genere.
Il punto, però, è che non è sempre stato così. La costruzione di un'identità politica progressista e femminista, naturaliter anti nazionalista, anti identitaria, cosmopolita, è un parto ideologico artificioso del dopoguerra. Eppure, nella storia d'Italia, le rivendicazioni femminili si sono accompagnate per molto tempo con quelle nazionali. Il «femminismo» è stato per molto tempo un fenomeno (anche) nazionalista, e questo dal Risorgimento al fascismo (incluso).
Il protagonismo femminile nel Risorgimento è noto. Pensiamo ai casi di Anita Garibaldi, Eleonora Fonseca Pimentel, Rose Montmasson (l'unica partecipante donna alla spedizione dei Mille), Luisa Battistotti Sassi, Colomba Antonietti, Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Se spesso abbiamo a che fare con intellettuali, propagandiste, o magari «mogli di...» che sposano convintamente la causa del marito, la verità che non mancano anche donne combattenti: pensiamo alle già citate Colomba Antonietti, uccisa mentre difendeva la Repubblica romana, o Luisa Battistotti Sassi, protagonista armi in pugno della cacciata degli austriaci durante le Cinque giornate di Milano.
Meno nota è la partecipazione femminile all'interventismo alle soglie della Grande guerra. Facendo, dal loro punto di vista, gli stessi ragionamenti che ad esempio portarono un Benito Mussolini a passare dal neutralismo alla scelta pro guerra per volontà di partecipare al movimento della storia anziché stare a guardare, le femministe scelsero convintamente l'interventismo ritenendo che anche le loro istanze sarebbero state accolte nel «mondo nuovo» uscito dalle trincee. Questo insieme di convinzioni fece sì che «nel periodo della grande guerra siano potute convergere appartenenze ed ideologie che oggi appaiono incompatibili quali pacifismo, femminismo, interventismo e nazionalismo» (Emma Schiavon, Interventiste nella Grande guerra).
Parte di queste lotte confluirono poi nel fascismo nascente. Già prima della marcia su Roma, pur nella difficoltà del periodo rivoluzionario, erano comunque un centinaio le militanti donne del fascismo, mentre a Monza, il 12 maggio 1920, fu fondato il primo fascio femminile. E qui, di fatto, si apre tutto un mondo che, ha scritto Luca Leonello Rimbotti, va «da Leda Rafanelli, anarchica e futurista, a Margherita Sarfatti, leader culturale e vicedirettrice di Gerarchia; dalla poetessa Ada Negri (la prima donna a entrare nell’Accademia d’Italia) alla giornalista Elisa Majer Rizzioli (“marcia su Roma” e artefice dei Fasci femminili), alla pittrice triestina Amalia Besso, alla chirurga Carmelita Casagrandi, fondatrice del Fascio femminile di Padova, alle squadriste Ines Donati, Emilia Carreras o la fiorentina Fanny Dini, che negli anni Venti parteciparono agli scontri di piazza in camicia nera insieme agli uomini, e la prima ne morì… e fino alla nutrita schiera delle donne di Salò, in divisa militare e maneggiatrici di contraeree».
Se il primo punto del Manifesto di Sansepolcro chiedeva «voto ed eleggibilità per le donne», la legge del 22 novembre 1925 stabilì addirittura il voto femminile nelle elezioni amministrative, anche se è vero che la misura restò di fatto senza conseguenze pratiche dopo che venne instaurata la nomina dall’alto dei podestà. Nel 1938, del resto, Mussolini cercò addirittura di far sì che le donne fossero rappresentate alla Camera dei fasci e delle corporazioni, ma Vittorio Emanuele si oppose all’idea.
Per riassumere questo filone sconosciuto del femminismo pre '45, citiamo solo due parabole biografiche. La prima è quella di Regina Terruzzi (1862 – 1951): di umili origini, mazziniana, nazionalista, socialista, interventista, la Terruzzi era stata sul finire dell’Ottocento una infaticabile attivista femminista, avendo fondato nel 1893 a Milano la Lega per la tutela degli interessi femminili e nel 1898 la prima società di ginnastica femminile, chiamata Insubria. Conosciuto Mussolini ai tempi delle battaglie socialiste, il 23 marzo 1919 si ritroverà in piazza Sansepolcro, una delle nove donne che parteciparono alla fondazione dei Fasci di Combattimento. Durante gli anni del regime, questa infaticabile attivista femminista veniva regolarmente ricevuta da Mussolini, collaborava al Popolo d’Italia, era in amicizia con Arnaldo Mussolini, pubblicava libri femministi. Nel ’23 il Duce la nominò delegata ufficiale del governo al Congresso dell’Alleanza internazionale per il suffragio femminile, che raccolse a Roma decine di delegate da tutto il mondo. Per tutti gli anni del regime, Regina Terruzzi girò il mondo in nome dell’Italia fascista, anche se per le sue prese di posizioni talora critiche fu definita «la suocera del regime». Sostenne infine la guerra d’Etiopia, quella di Spagna e si schierò per l’intervento nella Seconda guerra mondiale.
L'altra personalità di spicco fu Teresa Labriola (1874 – 1941). Figlia ribelle del più noto esponente marxista Antonio, Teresa dimostra molto precocemente la sua voglia di protagonismo sociale laureandosi in giurisprudenza nel 1894 e tentando, con successo, di iscriversi all’albo degli avvocati. Avvicinatasi al movimento emancipazionista, diviene responsabile della Sezione giuridica del Consiglio nazionale delle donne italiane e partecipa alla campagna per il voto alle donne del 1906-13. Interviene in vari convegni femminili, raccogliendo alcuni dei suoi saggi e interventi nella raccolta La quistione femminile del 1910. Accesa femminista, la Labriola sposa con passione la causa del patriottismo e, in seguito, aderisce con convinzione al fascismo. Dopo il delitto Matteotti espresse fiducia incondizionata in Mussolini. Scrisse: «L’età muta della donna è finita. Facciamo che la donna cominci a essere eloquente parlando della patria».