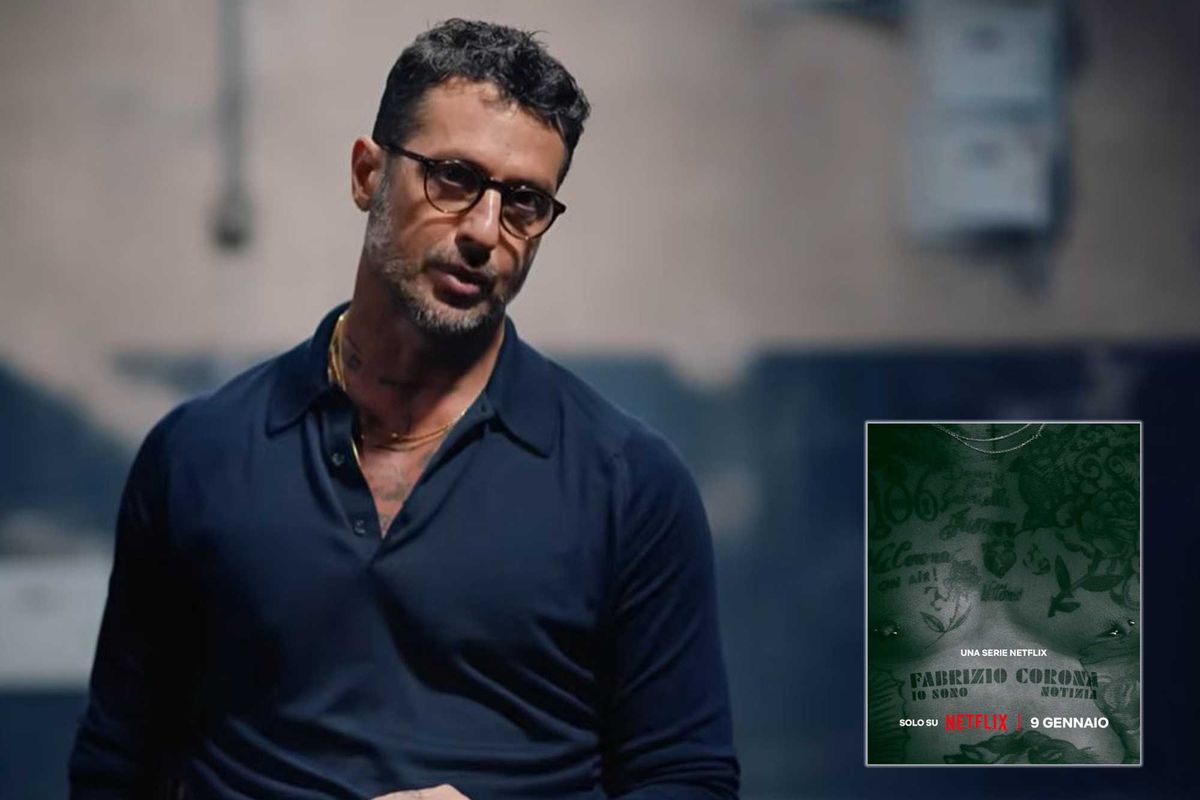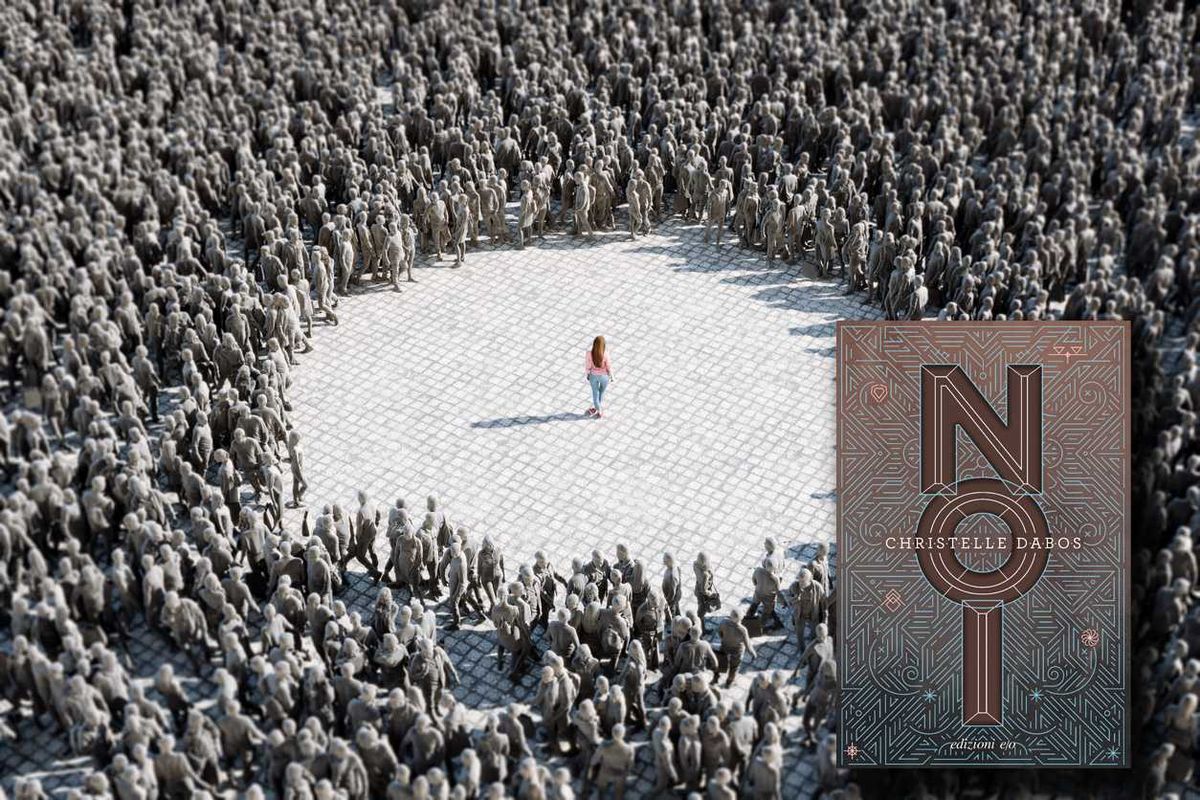Dalle assenze di peso ai piani sconfessati. La Cop26 è già fallita

Inutile nasconderlo: la Cop26, la conferenza sul clima inaugurata ieri a Glasgow, molto probabilmente si rivelerà un fallimento. Non serve essere delle menti particolarmente illuminate per prevederlo: le assenze eccellenti del presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin, leader di due tra i quattro Paesi maggiori produttori di emissioni di carbonio, trasformano quello che sarebbe dovuto essere nelle intenzioni iniziali il vertice sul clima più importante dopo quello di Parigi del 2015 in un semplice incontro tra capi di Stato e di governo. Il cui unico intento sembra oramai essere quello di salvare le apparenze.
D'altronde, bastava seguire i lavori di scrittura del comunicato finale del G20, tenuto a Roma questo week end per rendersi conto dell'inesorabile debacle della narrativa ambientalista: se infatti nella bozza iniziale di venerdì si menzionava l'obiettivo di interrompere immediatamente la costruzione di nuovi impianti alimentati a carbone, nella versione finale di domenica si ripiegava su un più generico impegno volontario, senza neppure indicare una data di riferimento. La realpolitik, insomma, ha già ceduto il passo all'ideologia che di danni già ne ha fatti parecchi: proprio i piani zelanti di riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo ai disinvestimenti in nuova capacità estrattiva da parte delle major petrolifere e minerarie, sono alla base della crisi energetica che a inizio ottobre ha investito Cina, Regno Unito e Unione Europea e che rischia di riproporsi il prossimo inverno.
A parlare sono i fatti. In Cina la dismissione delle miniere di carbone in atto dal 2016 accompagnata all'eccessivo affidamento alle fonti rinnovabili, in particolare idroelettrica, in un anno caratterizzato dalla siccità, ha innescato un vero e proprio power crunch che da agosto sta mettendo in ginocchio il comparto manifatturiero, tanto da spingerlo alle soglie della recessione nel terzo trimestre con un effetto a valanga sul settore industriale mondiale, se pensiamo all'impennata del 200% del prezzo di materiali come il magnesio e il silicio. La reazione del governo di Pechino non si è fatta attendere, tanto che nel giro di poche settimane ha sconfessato gli ambiziosi piani climatici, annunciando la riapertura delle miniere di carbone per un totale di 160 milioni di tonnellate. Il risultato si tradurrà in un impegno a ridurre le CO2 molto più blando di quello promesso: arrivare alla neutralità climatica nel 2060. Che è un po' come dire: «poi vedremo». Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Russia che però, essendo Paese produttore di gas e petrolio, non ha ovviamente fretta nel ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre a Mosca il riscaldamento climatico rappresenta una grande opportunità sul piano geostrategico perché contribuisce a sciogliere i ghiacci nella regione artica, rendendo così molto più semplici sia la navigazione che l'estrazione di metalli. Va anche detto però, a onor del vero, che chiedere a un Paese caratterizzato da inverno particolarmente freddi di riscaldare 140 milioni di persone con fonti rinnovabili non può rappresentare un'opzione valida. A cadere nella crisi energetica a inizio ottobre è anche l'India, Paese che dipende per il 66% dal carbone per la fornitura di elettricità e che ha assistito allo spegnimento di 70 delle 135 centrali elettriche del Paese. Ieri Narendra Modi ha annunciato che l'obbiettivo sono le zero emissioni entro il... 2070!
Ma anche nel Vecchio Continente in realtà i danni commessi dall'adozione sfrenata di politiche green non sono da meno, se pensiamo al raggiungimento del prezzo del gas che ha toccato il mese scorso picchi di 150 euro/megawattora anche a causa della bassa generazione di energia dalle fonti eoliche e nucleare in Germania e nel Regno Unito (la Francia ringrazia). Ma l'Ue, come sappiamo, ha fatto del verde una ragione esistenziale del proprio modello economico. Più interessante è invece la posizione degli Usa, che da un lato sostengono le politiche climatiche ma dall'altro implorano l'Opec di alzare la produzione di petrolio per abbassare i prezzi della benzina che, veleggiando sui livelli record, rischiano di riservare qualche sorpresa sgradita a Biden alle prossime elezioni di mid-term.
La domanda che viene spontanea dunque è: se i 4 maggiori produttori di CO2 del pianeta abiurano o sostengono solo a parole i piani di contenimento delle emissioni di carbonio come si può considerare seria l'impalcatura complessiva dei piani climatici? In primo luogo va evidenziato come il fallimento del multilateralismo sul fronte della riduzione delle CO2 non mette una pietra tombale sulle politiche climatiche tout court ma sul principio di privare una fascia cospicua della popolazione mondiale di fonti stabili e affidabili di approvvigionamento energetico. Pensare di perseguire politiche anti inquinamento agendo sulla restrizione dell'offerta è infatti rivelata una strategia fallimentare in quanto oltre ad alimentare la corsa al rialzo dei beni energetici favorendo la speculazione finanziaria, trasferisce la produzione di energie fossili nei Paesi non allineati, aumentandone il potere contrattuale (come sta dimostrando il braccio di ferro tra Russia ed Europa su gas).
In secondo luogo va detto come la questione climatica offra un pretesto per intraprendere nuove forme di guerre commerciali. La riprova è giunta con l'accordo tra Washington e Bruxelles annunciato al termine del G20 al fine di eliminare i dazi su acciaio e alluminio. L'accordo serviva come il pane agli Usa che proprio per ragioni elettorali necessitano di raffreddare il prezzo degli acciai giunto a 2.000 dollari la tonnellata per i laminati a caldo. L'intenzione di Biden è infatti quella di provocare lo sgonfiamento dei prezzi nel mercato Usa favorendo l'import dall'Ue dove i prezzi sono più bassi di circa 700 dollari la tonnellata. Il provvedimento ha grandi sostenitori anche in Europa tra cui le acciaierie attratte dai livelli di prezzi nel mercato americano. Tuttavia, il diavolo è nei dettagli. L'aver infatti inserito l'accordo commerciale all'interno dell'ampio dossier sul clima di fatto allontana l'ipotesi che Bruxelles possa a sua volta riformare il sistema delle quote all'import che impedisce oggi all'acciaio asiatico e turco di entrare in Europa, alimentando la grave carenza che contraddistingue il mercato. Si tratta di un cambio di paradigma di cui il governo italiano deve essere consapevole al fine di farsi portatore a Bruxelles di una revisione strutturale del sistema delle quote che da un lato soddisfi i requisiti del nuovo «corso climatico», ma dall'altro scongiuri quelle strozzature sul lato dell'offerta che rischiano di mettere sotto ulteriore stress il comparto manifatturiero italiano, a cui potrebbe non rimanere altra scelta se non quella di trasferirsi in paesi extra Ue.