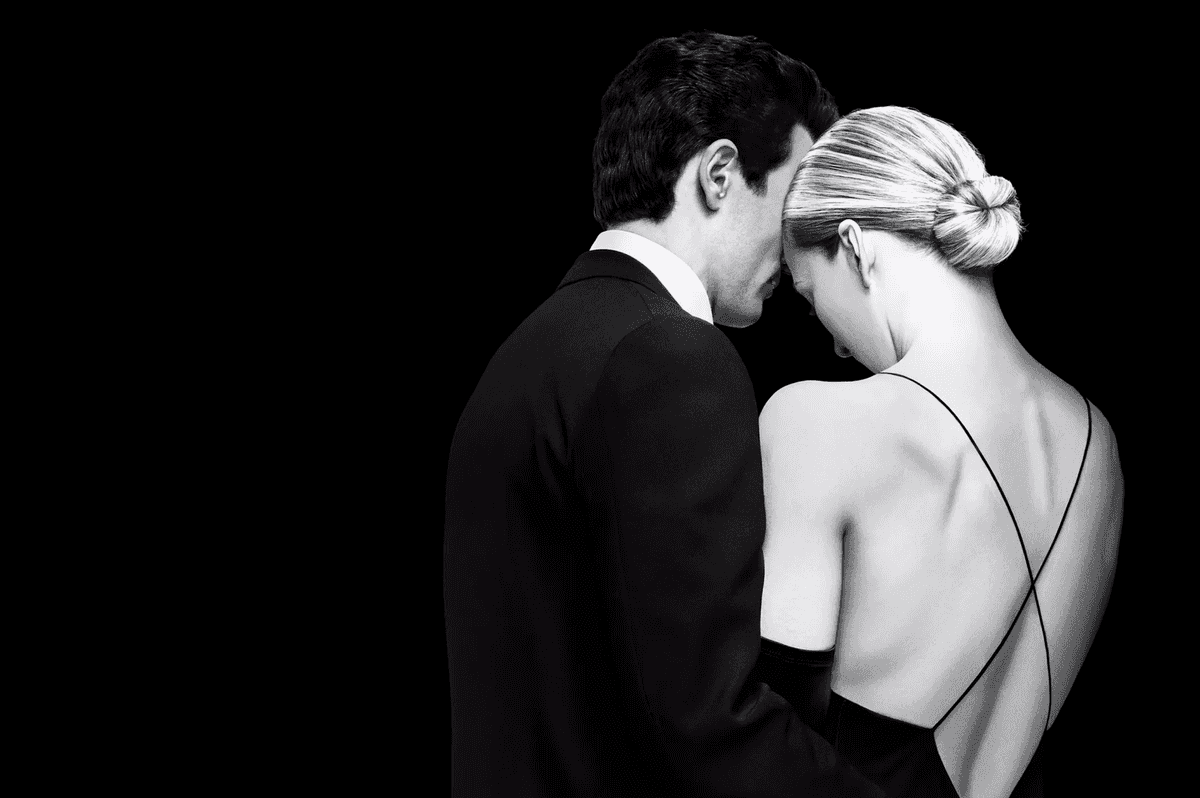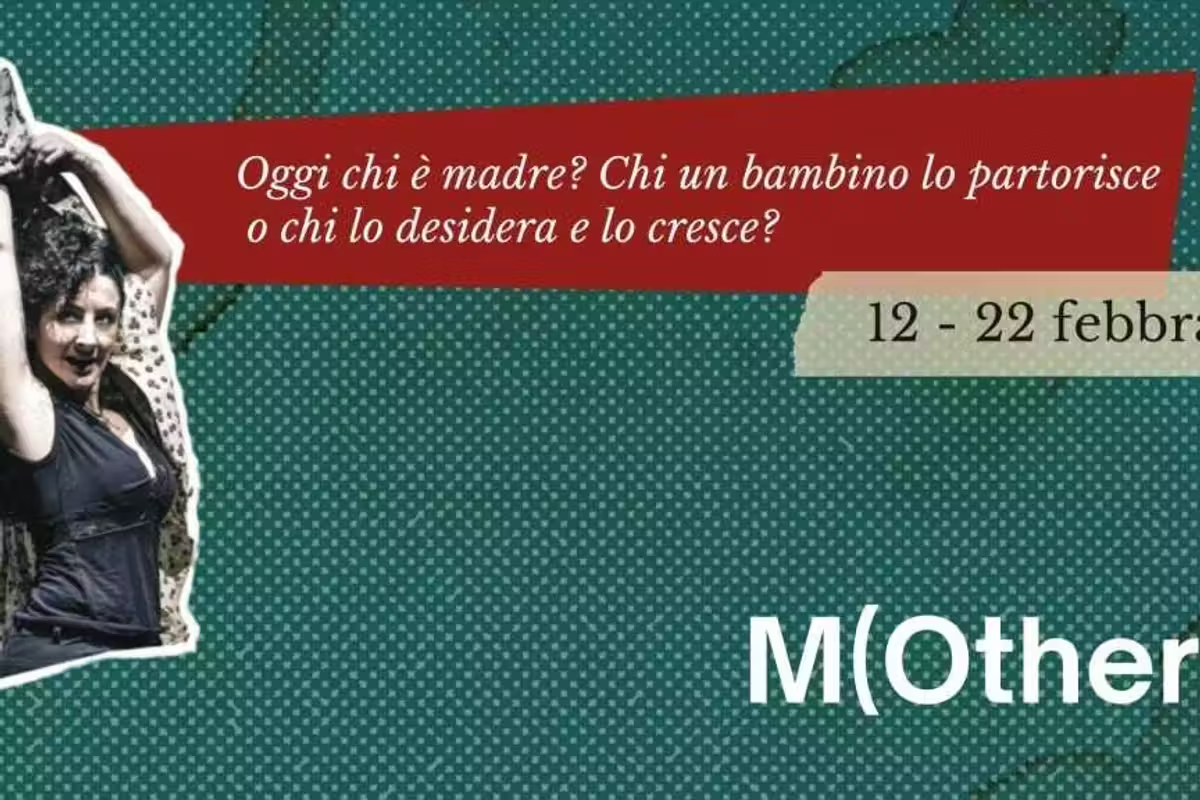Forse il miglior ricordo glielo ha dedicato recentemente Vittorio Feltri, che sin da ragazzino divorava la rubrica dell’Arcimatto, firma fuori spartito del direttore del Guerin sportivo, al secolo Gianni Brera: «Il più grande cronista di tutti i tempi». Pur se è ricordato come autorevole penna di cronache del pedatare (calcio) e pedalare (ciclismo) «i suoi articoli non erano collocabili in un ambito specifico, erano alta letteratura». In tempi non sospetti lapidario Giorgio Lago, storico direttore de Il Gazzettino. «Un grande sottovalutato, se ha vinto il Nobel Dario Fo, poteva tranquillamente vincerlo anche Gianni Brera».
Il 19 dicembre ricorre il trentesimo della scomparsa, occasione per ricordarne lo straordinario talento e la rara capacità divulgativa in ambiti diversi, gastromondo compreso. L’imprinting familiare la dice lunga, posto che mamma Marietta era cuoca abile e sopraffina nel far tesoro di quanto dispensa poteva offrire. «A colazione l’odore del caffè e del latte mi ripugnava al punto che preferivo le sberle», ma si rifaceva a pranzo con «il brodo per la zuppa, che ognuno si faceva da sé, sminuzzando il pane nella scodella. Una volta ammollato si spargeva formaggio grattugiato. Era il po’ di pepe aggiunto che ci differenziava dal cane, che certo non lo avrebbe gradito». Come inizio non c’è male, ma inquadra il momento storico di un’Italia tra le due guerre, a forte trazione rurale.
Nelle campagne di allora l’aia era popolata di creature diverse. Ad esempio i galletti, che subivano una selezione «castrante» da parte di una «levatrice» apposita, intesa come tagliatrice di attributi facilmente immaginabili. «Straniti, falliranno comici canti le prime mattine, poi, rassegnati, si daranno ad ingrassare per te». Ma attenzione perché «se resteranno troppo snelli per amor della corsa verso l’orto e i prati, le ultime due o tre settimane dovranno trascorrerle quasi immobili nella stia». L’alimentazione pennuta era rigorosamente biologica, paperi compresi, «che vengono ingollati di granoturco a manciate, poi gli si fa la grazia di immergergli la testa in un trugolo perché abbiano a bere. Compiuto il pasto coatto i paperi si rannicchiano in tanta beatitudine». Chiaro esempio che la nostalgia del passato, esemplare per certi aspetti legati alla tradizione, non seguiva sempre i canoni da monsignor Della Casa a dimensione di cortile. Ne sapevano qualcosa le povere oche, involontarie vittime sacrificali dei riti di San Martino, l’11 novembre. «La cerimonia della tirata del collo è breve», ma non sempre la nonna esperta ha la forza per agire e allora «qualche giovane le viene in soccorso, ma l’esuberanza giovanile, a volte, stacca pure la testa». Anche Ermanno Olmi, il poeta della civiltà contadina, si sarebbe rifiutato di montare poi tutta la storia. «Il rammarico della vecchia è sincero, solo perché ha perso il sangue per fare il rituale tortino con pangrattato e spezie». Un po’ splatter, non c’è che dire, anche se era la realtà quotidiana sotto gli occhi di tutti.
Eppure Giuan Brera era orgoglioso di queste radici, la sua cucina di popolo, contrapposta a quella borghese di Pellegrino Artusi, tanto che, una volta iniziato a frequentare il bel mondo della borghesia meneghina, ebbe così a commentare un teorico invito a cena con tovaglie di fiandra e posate d’argento. Ha di fronte a lui la padrona di casa, il marito intento a dare ordini alla servitù. «La guardi e finisci per convincerti che sia possibile sedurla semplicemente mostrandole un tozzo di micca ignorante» (pane rustico) «e una fetta di gorgonzola vero». Alla faccia dell’alitosamente corretto. Con effetto conseguente. «La povera signora, gli occhi persi, aspetta solo che tu le proponga quella merenda rozza ma naturale per fuggire con te».
Non sapremo mai come siano andate le cose, ma tornando a grufolare di stalla Brera testimonia come «il maiale è l’ospite più gradito della famiglia, quando si fa su è tale festa che si immagazzinano grassi e proteine per tutta la Quaresima». Con l’occhio attento a non strafare mai, ad esempio con il sale per la concia delle carni suine. «Chi lo rovescia va incontro a sicure disgrazie. La religione di casa è meno eccelsa ma più pragmatica di quella che si osserva in chiesa. I suoi tabù si rifanno a motivi pratici». Inattaccabile. Ma l’odissea porcella è solo agli inizi. «Lo ingannano fin da quando, maialino, viene sottratto alla madre scrofa e poi castrato». Lo coccolano con libagioni di pastoni a go go, che lui ingolla entusiasta «ma digerire è sempre più arduo, il ricambio si sballa e l’immobilità forzata completa lo scempio». Sembra la cronaca in diretta di Nicolò Carosio, ma era realtà quotidiana, di mutuo soccorso. L’uno ad alimentare l’altro, e poi viceversa, tanto che, in cantina «la rampineria (gli attacchi) per i salami sembrano il baldacchino di un vescovo».
Si viaggia di salumi e insaccati, ma su uno le memorie di Brera riaccendono il ricordo di un prodotto oramai disperso lungo i percorsi della modernità, ovvero la cervellata. Una preparazione del tutto particolare, a base di tagli e ritagli, suini e bovini, oltre che di formaggio e spezie varie. Vale la sosta curiosa. Già sul nome si sono confrontate ipotesi diverse. Per alcuni dovuta al fatto che, nell’impasto, ci fossero cervella tritate del divin porcello. Anche se Francesco Cherubini, estensore nel 1839 del Vocabolario milanese-italiano, già allora notava «forse in antico i nostri padri usarono le cervella porcine» ma, con la quantità di prodotti che si trovavano dal cervellee (il macellaio dell’epoca), «troppi maiali si sarebbe dovuti ammazzare», in numero ben superiore a quelli che grufolavano abitualmente nelle case contadine. Della cervellata si trovano tracce sin dal Rinascimento, nei ricettari di Maestro Martino e poi di Vincenzo Corrado, con ingredienti che potevano variare su alcuni dettagli, ma in cui il formaggio era presenza costante e. per chi poteva, spezie, in primis zafferano, a dare spessore. Probabilmente la spiegazione al di là delle possibili teorie, era molto pratica. Il formaggio grasso favoriva le fermentazioni utili alla maturazione del prodotto, vicariando quelle del grasso animale, usato in altri contesti, tanto è vero che la cervellata era considerato l’ingrediente ideale per dare quel tocco in più al risotto alla milanese.
Brera aveva molti amici tra i cacciatori e ogni anno rinnovava scrupolosamente la sua licenza di canna e cartucce, anche se poi i suoi fucili dormivano docilmente negli astucci di cuoio. L’esperienza non gli mancava, al seguito delle spedizioni cui si aggregava curioso, e non solo per mettere nel carniere le golose e prelibate beccacce migratorie. C’era tutto un mondo che ruotava attorno a queste avventure in cui a prendere la mira verso il cielo erano in molti, pochi per diletto, la maggior parte per necessità. Come quelli che, ad esempio, fin da piccoli, avevano in testa una perfetta mappatura della collocazione dei nidi e nelle nidiate lungo i faggeti attorno alle rive del Po. Aspettavano il tempo giusto per far man bassa delle uova e friggerle in padella. E poi c’erano «autentiche bande per uccellare di frodo». Brera puntuale testimone di come sia nata «dal bracconaggio dei paludaschi l’invenzione dell’anatra o della gallina alla creta», frutto di un mix di fame e paura. «Nessuna guardia poteva intuire che un fuoco di boscaioli nascondesse esemplari di fauna proibita» nelle terre dei latifondisti del tempo. «Poi si toglieva dal fuoco e si batteva con il bastone. I cocci si staccavano con piume e pelle, restava la carne, neppur tanto asciutta». Queste e millanta altre storie giunte a noi, sul versante goloso, da parte di Gianni Brera, colui che battezzò «Nuvola Rossa» Felice Gimondi, omaggio ad un leggendario capo indiano, quando vinse il suo ultimo Giro d’Italia dopo un duello infinito con Eddy Merck, il cannibale.