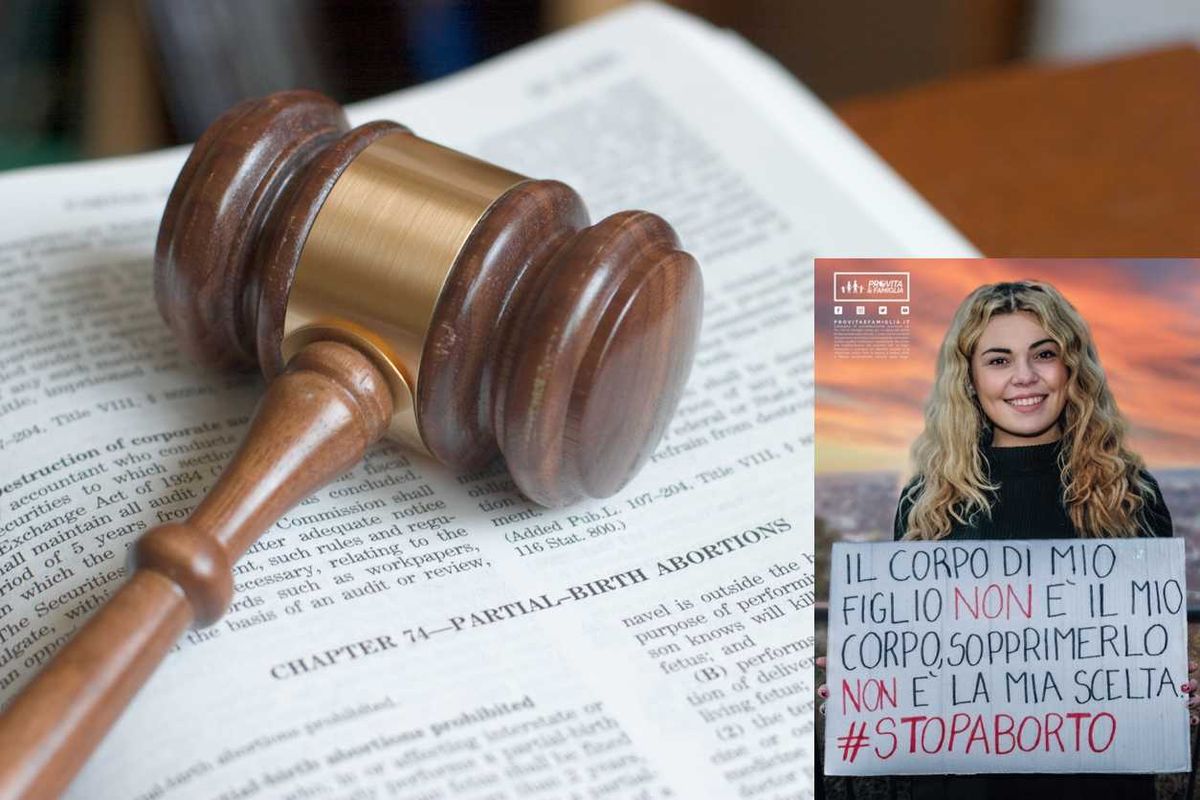Cristina Cattaneo: «Aumentano i suicidi tra i ragazzi piegati dagli anni del Covid»

Due lauree, un master e una carriera internazionale, l’antropologa forense e medico legale Cristina Cattaneo è anche professore ordinario di medicina legale all’università degli studi di Milano e direttore e anima del Labanof (Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’università degli studi di Milano). Il suo nome è spesso associato ai più terribili delitti commessi in Italia. Ha seguito, per esempio, il caso di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa nel nulla una sera del novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011. Sulla vicenda ha fatto molto scalpore, nelle ultime settimane, la ricostruzione fatta da Netflix nel documentario Yara. Oltre ogni ragionevole dubbio. Uno speciale che segue e per certi versi canonizza la moda con cui vengono affrontati oggi i true crime: non c’è più la ricostruzione della caccia al colpevole ma si insinua il dubbio che la verità accertata «oltre ogni ragionevole dubbio», nel caso specifico la colpevolezza di Massimo Bossetti, sia invece fallace e che il mostro sia ancora libero.
Dottoressa Cattaneo, anche lei ha partecipato alla docuserie di Netflix sul caso di Yara Gambirasio, che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensa del risultato finale?
«Non ho visto tutta la serie, solo qualche frame e ho ricevuto commenti dai miei colleghi. Mi spiace che sia andata così: avevo acconsentito a fare un’intervista, come avevo già fatto per la Bbc, a caso chiuso, con l’accordo che non si doveva rifare il processo ma raccontare in generale cosa la scienza può portare a casi terribili come questi. Io chiedo questo ogni volta che accetto di parlare di un caso chiuso e sono favorevole a parlarne solo nell’ottica di far capire come la medicina legale abbia spesso un ruolo importante nelle indagini. Questa era la condizione. Non avevo capito, invece, che fosse di parte. A un certo punto ho quasi interrotto tutto ma poi, forse troppo ingenuamente, ho concluso l’intervista. Comunque, più invecchio, più vedo quello che gira a volte in televisione e più rimango solidamente convinta delle nostre ricostruzioni scientifiche».
Cosa si ricorda di quei giorni? È vero che in quel caso è cambiato il modo di portare avanti l’indagine?
«Quello di Yara è un caso che ha cambiato il modo di fare autopsia e ricerche tra ambiente e corpo. Ci sono casi di questo tipo, che fanno virare il progresso dell’applicazione della scienza alla giustizia. Penso al caso delle Bestie di Satana, ad esempio: per la prima volta in Italia abbiamo, in quel contesto, applicato l’archeologia e l’antropologia forense. Grazie alla Procura, che ha permesso di creare il collegio giusto, si è creata l’opportunità di verificare che certe procedure o metodi d’indagine non sono solamente “da romanzo”. Questi casi hanno aperto un mondo: l’attenzione per l’importanza della vittima fa sì che si creino cambiamenti epocali nella gestione dei morti. Sarebbe bello, poi, che questi cambiamenti venissero applicati a tutti i morti. Ma questo non sta succedendo, purtroppo».
Perché non succede con tutti?
«A fronte di una scienza che si sta sviluppando sempre più, sta diminuendo il numero di autopsie richieste dalla giustizia. I problemi sono diversi: la Procura, forse, ha perso fiducia in quello che la scienza può fare, che è paradossale perché ci sono tantissime prove, non solo il Dna, che possono arrivare da un corpo. Poi c’è una certa mancanza di comunicazione tra le nuove generazioni di giuristi e di medici legali. Infine, c’è anche un problema di finanze, economico. Il medico legale, in Italia, è quasi un libero professionista, che lavora una tantum su un caso e, quindi, non può vivere soltanto “del morto”. In Francia hanno fatto una riforma una quindicina di anni fa: gli istituti di medicina legale sono allestiti dal governo per avere tutto quello che serve in caso di necessità e per consentire ai giovani di fare quel mestiere lì e di farlo bene. In Italia manca il riconoscimento istituzionale della figura del medico legale ancorata al territorio. Pensiamo all’altra tipologia di vittima nostra, il “vivo”. Un bambino maltrattato arriva in pronto soccorso con la mamma che dice che è caduto dalla scala ma può farlo solamente il medico legale».
Quindi state cercando di portare questa riforma francese anche in Italia?
«Stiamo tentando, parlando con i vari ministeri, come Società italiana di medicina legale di fare la stessa cosa che hanno fatto in Francia qui da noi. Tutti i morti verrebbero trattati come è stata trattata Elisa Claps, ad esempio. Si riuscirebbe perfino a fare un triage, nei pronto soccorso, per le vittime di violenza. Lavorando sui vivi, si riuscirebbe a intervenire, con questa riforma, prima che possa accadere il peggio, tutelando vita e salute delle vittime. Mettere i medici legali nei pronto soccorso è fondamentale per aiutare i vivi. Abbiamo avuto interlocuzioni con il governo, sono stata in audizione il mese scorso nella commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio presieduta da Martina Semenzato. È un argomento molto trasversale, è una lotta per la giustizia e per tutelare i vivi. Mi sembra che stiamo andando nella direzione giusta».
Com’è cambiato il suo lavoro da quando lei ha iniziato a oggi?
«È cambiato tantissimo. Però la grande rivoluzione non è stata solamente tecnologica, ma culturale. Un medico legale, oggi, non si sognerebbe mai di andare in tribunale con un cadavere che è stato trovato in un ambiente boschivo senza coinvolgere, come suoi pari grado, un botanico e un entomologo. Il passo decisivo di questi anni è stato far capire ai medici legali che sono dei manager del corpo e che, per rispondere alla classiche domande “Quando è morto?” e “Come è morto?”, devono avvalersi di un ventaglio di professionisti che prima non c’erano. Il medico legale che non è più un tuttologo, ma il gestore del corpo».
Cosa l’ha spinta a intraprendere il suo lavoro?
«Io adoro il mio lavoro. Io leggo il corpo, in tutte le sue forme, per ricostruire un’identità e capire se c’è stata violenza o discriminazione. I corpi, tutti i corpi, ci raccontano di noi e del nostro rapporto con la violenza. Le fonti scritte raccontano quello che vogliono, i corpi non mentono. E la storia puoi riscriverla».
Le vittime di un fatto di sangue, i corpi di chi non ce l’ha fatta ad attraversare il Mediterraneo per raggiungere le nostre coste, gli scheletri conservati nel sepolcreto della Ca’ Granda: l’approccio a queste persone morte in circostanze diverse è sempre lo stesso oppure cambia?
«Il morto ammazzato in un bosco, magari una ragazza vittima di violenza, e il morto del barcone per me sono uguali. Ci sono mille sfaccettature, per quelli annegati sul barcone potrei dire che è più difficile lavorarci perché ci sono sfide tecniche ancora più marcate. Ma sono due tragedie da raccontare. Quello che succede è che, certe volte, il senso di ingiustizia per il primo caso si trasforma subito in una caccia al colpevole, si vuole subito fare giustizia. Mentre il migrante o il senzatetto che muore ai margini della società o la prostituta albanese uccisa ai lati di una strada, sono morti di serie B. Oltre all’ingiustizia che hanno subito, ne subiscono un’altra che è altrettanto grave: il disinteresse, l’oblio. Le vittime del Seicento? Malgrado i millenni che passano, si vedono per esempio i segni, sul corpo di un ragazzo, della tortura subita sulla ruota. I millenni non riescono a cancellare l’empatia e la tenerezza. So che è incredibile, uno dovrebbe provarci per credere. Senti in maniera urgente di voler dar voce e giustizia a quella storia del passato».
Qual è il caso che l’ha maggiormente coinvolta, a livello emotivo?
«Diversi casi ti restano addosso. Penso al mio primo caso, un ragazzo morto di overdose trovato in completo stato di decomposizione. È stato il mio primo contatto con questo tipo di morte, in quella massa informe c’era una persona. Poi c’è quello che ti rimane più impresso perché dici: “Vedi, lì abbiamo insistito per applicare quella tecnica e ha funzionato”. Poi c’è quello che ti resta addosso perché, invece, “non sono riuscita a convincere i giudici di questa cosa”. C’è quello in cui ti ricordi della madre che è venuta a implorarti di non andare più avanti perché voleva seppellire il corpo del figlio. Non so scegliere, davvero. Sicuramente quelli che ti lasciano un amaro in bocca che ti segna, sono le vittime dell’oblio».
Come fa a conciliare il suo lavoro con la vita normale?
«La mia fortuna è che vivo in università. Prima di essere un consulente della Procura o di qualunque agenzia, sono un’insegnante. Io insegno la mia materia, quindi sono a contatto tutto il giorno con giovani tra i 18 e i 30 anni, che hanno voglia e che hanno la stessa carica che avevi tu, 30 anni prima, di cambiare il mondo con la scienza. E questo vale tutto il bagaglio di sofferenza e di tragedia che uno vede. È uno scambio alla pari».
Il Covid ha impattato anche sul suo lavoro?
«Stiamo assistendo a un brusco aumento dei suicidi adolescenziali, che è una delle cose che più ti levano ogni ragionamento. Confrontandomi con altri medici legali, pediatri e neuropsichiatri infantili, stiamo cercando di capire cosa stia succedendo. Ma tutti siamo d’accordo nell’affermare che il Covid ha dato una botta pazzesca a questi ragazzi. Questi due anni di vuoto (dal 2020 al 2022, ndr) hanno tolto loro qualsiasi riferimento, hanno creato uno sfacelo, soprattutto su quelli più fragili. Noi facciamo 800 autopsie l’anno e abbiamo il polso del tipo di morto che arriva e, negli ultimi due anni, adolescenti ma anche giovani tra i 22 e i 24 anni sono troppo frequenti nella sala. Ed è una cosa che non ti spieghi».