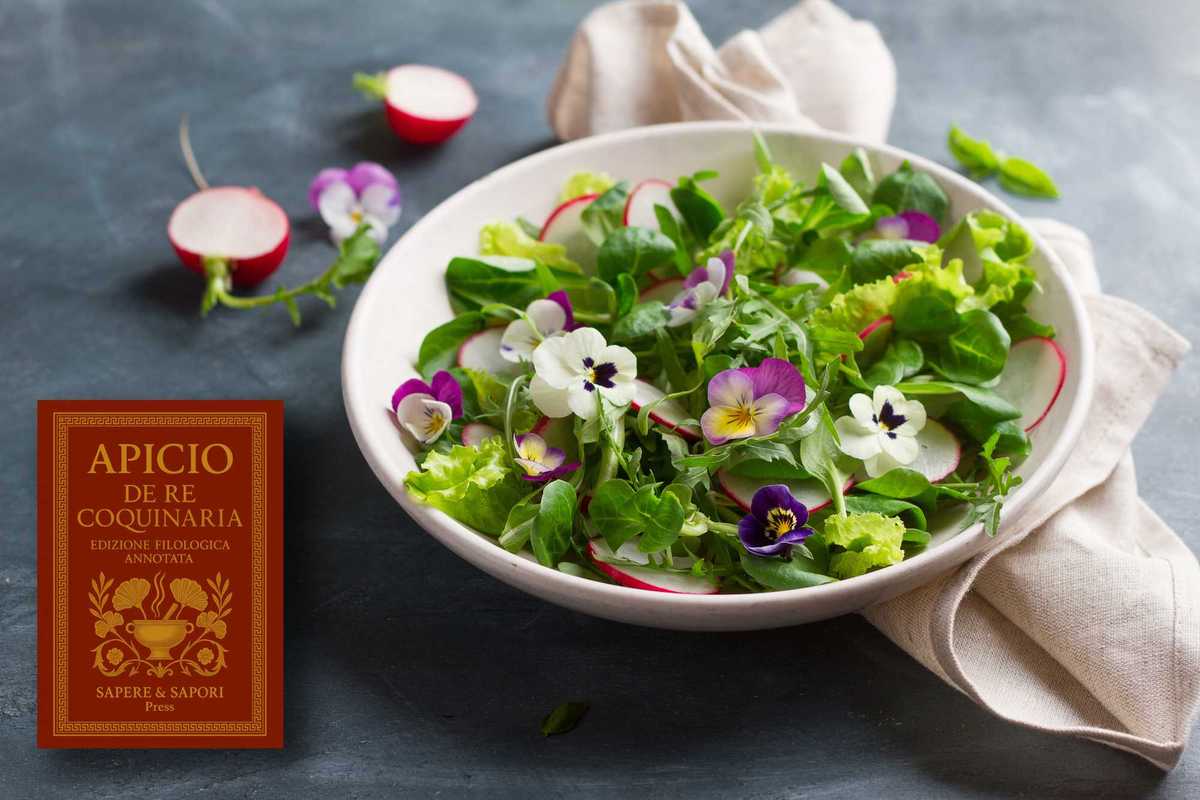I banchieri centrali dovrebbero prevenire prima che curare. Il condizionale è voluto perché spesso le analisi arrivano a guai già iniziati e il risveglio spesso è tardivo. È successo con l’inflazione: Christine Lagarde non l’aveva vista arrivare, e ha comunque temporeggiato facendo diventare la lotta sanguinosa e ancora più lunga. Il problema è che ancora oggi la traiettoria tracciata dai vertici della Bce è prudente ma non chiara e che i dati cui si aggrappa Lagarde (mantra ripetuto anche lo scorso 6 giugno) riflettono il passato ma è come rinunciare a dare una guida per il futuro e a dare una prospettiva. Il copione purtroppo sembra simile per un’industria, quella dell’automotive, che non è il core business della banca centrale ma del cui impatto Francoforte non può non tenere conto perché contribuisce con una quota significativa al valore aggiunto dell’economia dell’area dell’euro. Il settore automobilistico dell’area euro si riprenderà? È questa la domanda che si sono posti gli economisti della Bce, Roberto A. De Santis, Virginia Di Nino, Nina Furbach, Ulla Neumann e Pedro Neves. Le risposte, illustrate in uno studio pubblicato dall’istituto di Francoforte, non ci sorprendono perché ne scriviamo ormai dai mesi. Anzi, ci conforta che gli allarmi siano finalmente suonati anche nelle stanze dell’Eurotower. Cosa si legge nel «paper»? Gli esperti partono ricordando che la quota dell’industria automobilistica nel valore aggiunto reale del settore manifatturiero ammonta al 10% e la quota nel Pil reale è leggermente inferiore al 2%. Il comparto rappresenta l’1% dell’occupazione totale dell’area dell’euro e il 4% delle esportazioni dell’area extra-euro. «Quando si prendono in considerazione i collegamenti intersettoriali, il valore aggiunto quasi raddoppia, evidenziando l’ampia portata del settore all’interno dell’economia», viene aggiunto.
Dopo il picco raggiunto all’inizio del 2018, però, l’industria automobilistica dell’area euro ha dovuto affrontare sfide significative, con la produzione e le esportazioni in netto calo e rimaste al di sotto dei livelli pre-Covid. I volumi di produzione ed esportazione hanno faticato a riprendersi e sono rimasti indietro rispetto a quelli dei concorrenti internazionali, attestandosi a circa un decimo al di sotto dei livelli pre-Covid e a un quinto rispetto ai picchi raggiunti all’inizio del 2018. I concorrenti – prosegue lo studio - se la sono cavata molto meglio: l’industria automobilistica in Paesi come Cina, Giappone, Stati Uniti e Corea ha registrato risultati più robusti, con la Cina che sta gradualmente emergendo come un importante esportatore verso l’area dell’euro. Ed eccoci, al punto. Anche gli economisti della Bce hanno realizzato che «questo calo dell’attività è stato innescato da un calo delle vendite di auto con motore a combustione, solo in parte compensato dalla crescente domanda di auto ibride ed elettriche». E che «gli standard normativi dell’Ue per i veicoli a motore sono cambiati a metà del 2018, imponendo standard più severi sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) e test sulle emissioni più severi, che hanno disincentivato l’acquisto di auto a combustione». Per gli esperti della banca centrale il problema riguarda però tutte le auto. Nel primo trimestre del 2024 le immatricolazioni di automobili nell’area dell’euro sono state inferiori di circa il 20% rispetto all’inizio del 2018. Colpa anche degli «aumenti dei prezzi innescati dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, dell’aumento dei costi energetici e delle rigide condizioni di finanziamento». «Inoltre, da settembre 2021 i picchi dei prezzi dell’energia si sono trasmessi ai prezzi alla produzione e ai prezzi finali delle automobili. Infine, l’aumento dei tassi di interesse derivante dall’inasprimento della politica monetaria ha scoraggiato il leasing e il credito per l’acquisto di automobili, riducendo così la domanda di automobili sia nazionali che straniere». Colpa anche della politica della Bce sui tassi, dunque. Ma gli economisti di Francoforte sono ottimisti e parlando di «resilienza» delle case automobilistiche dell’area euro che «si sono storicamente specializzate nel segmento di mercato di fascia alta, beneficiando di una domanda relativamente anelastica rispetto ai prezzi». Tuttavia, le imprese dell’area dell’euro sono in ritardo nella registrazione dei brevetti per la comunicazione digitale. E si profilano «rischi significativi». Sarà fondamentale «integrare i processi digitali con quelli tradizionali, nell’accelerare l’innovazione e nel lanciare tecnologie che ottengano il favore del mercato». Inoltre, «la forte dipendenza delle case automobilistiche dell’area dell’euro da fornitori concentrati in poche località (ad esempio, semiconduttori e batterie prodotti in un piccolo numero di paesi asiatici) pone rischi per la catena di approvvigionamento, soprattutto in tempi di accresciuta tensione geopolitica». Poi, ecco la conclusione dello studio: «Anche le politiche industriali, in particolare quelle legate alla transizione verde, come le infrastrutture di ricarica, determineranno le prospettive del settore automobilistico dell’area euro». Il problema è che sarebbe stato meglio realizzarlo prima di arrivare a questo punto. Come dimostra anche la recente raccomandazione della Corte dei Conti europea sul ritardo dell’industria europea delle batterie rispetto ai concorrenti asiatici che rischia di non far raggiungere i target al 2035 fissati da Bruxelles in termini di utilizzo di auto elettriche.