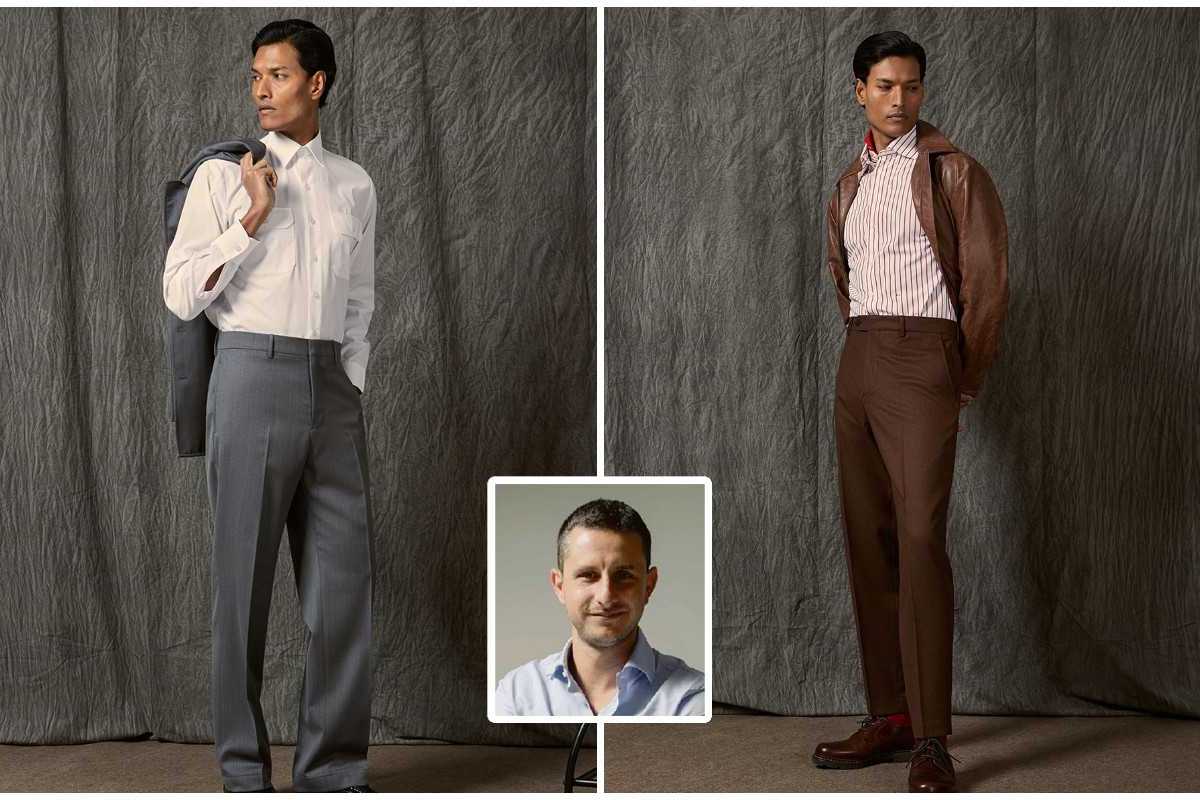È una delle capitali indiscusse dell’arco alpino, come l’austriaca Innsbruck o la svizzera St.Moritz; sede olimpica e di altre svariate discipline sportive; vetrina di ciak cinematografici e del vedere e farsi vedere del jet set a dimensione international. Eppure un tempo, per Cortina, non era tutto così scontato. Se ora è frequentata da oltre un milione di turisti all’anno, nel 1869 si contavano sulla punta delle dita, duecentotrentasei. Quattromila nel 1894. Un alpinista francese, Jules Leclercq, nei suoi diari di arrampicate, una volta giunto a Cortina nel 1880, commentando la reazione dei locali li descrisse così «i selvaggi dell’Africa centrale provano meno stupore di loro alla vista di uno straniero». Non gli era stata da meno la giramondo londinese Amelia Edwards, autrice nel 1872 di Vagabondaggi di mezza estate nelle Dolomiti. Entrata in una delle poche locande allora presenti così la descrive «frequentata da mandriani, contadini e viaggiatori, quando entri vieni immersa in un’atmosfera densa di aglio e tabacco», tuttavia locale democratico a modo suo, in quanto «il viaggiatore più ricco ed esigente ottiene gli stessi piatti e li paga come l’ospite meno abbiente». Entrata in cucina, nonostante «una collezione di pentole in rame e ottone lucide come specchi, il pane è secco e, a parte burro e uova, vi è un immangiabile formaggio locale». Di necessità si può far virtù. L’Amelia giunta dalla perfida Albione si fa prestare un grembiule e prepara sotto gli occhi curiosi delle maestranze delle personali uova al burro.
In quell’economia di resistenza alpina quando le mamme ammonivano i figli prima di entrare nel bosco non era con lo scontato «attenti al lupo», ma con un più pratico «e non tornate mai a casa a mani vuote». Vario il bottino, oltre agli scontati fragole e mirtilli. Ad esempio le bacche di rosa canina, per marmellate, come lo «scarpin», scarpino, una sfida raccoglierli tra le molte spine, un po’ acidi al gusto, ma ricchissimi di vitamine, così come le pigne lasciate maturare nel fieno per tostarne poi i pinoli alla brace. Colture ecologiche mele e albicocche, piantate addossate ai muri delle case.
Ambasciatore delle patate nell’Ampezzo il parroco di San Vito, don Francesco Ciasella che ne accompagnò la coltivazione presso i locali con una piccola pubblicazione scritta. All’inizio vi fu una certa resistenza, ma dopo i devastanti saccheggi di alcuni briganti tirolesi, gli autoctoni le adottarono via via sempre più convinti dalla resa al raccolto senza richiedere troppo impegno. Valorizzate con il grostl, un tortino assemblato con avanzi di carni varie. Tra le architetture delle campagne ampezzane spiccavano all’orizzonte le arfe, sorta di alti graticci sui quali venivano posti gli steli delle fave, dato che, al raccolto, non erano mai sufficientemente mature. Venivano chiamate «barata», una menda, ovvero soprannome autoctono, in quanto spesso erano oggetto di scambio tra famiglie a seconda delle reciproche necessità della dispensa. Sul fare dell’inverno i piccoli cortinesi andavano a scuola con le fave arrostite nelle tasche del cappotto. Avevano una doppia funzione, scaldavano le mani e consolavano poi il palato una volta seduti al banco.
Sempre restando in ambito pediatrico una radicata tradizione pasquale era il bete voo, una sorta di duello a mani nude, armati di debite uova sode, con una certezza. Vinceva chi rompeva le uova al concorrente (detto senza chiavi di rilettura goliardica). Specialmente nelle comunità di un tempo vi era uno stretto legame fra tradizione e ars culinaria. I ragazzi crescono ed iniziano i corteggiamenti della bellezza di turno. Il pretendente cercava di incrociare i suoi occhi dal balcone il giovedì ed il sabato. Dopo i primi approcci era conseguente presentarsi ai genitori e qui arriva il bello. Se l’inevitabile suocera all’orizzonte si presentava con un fumante piatto di zufa da late (un cremoso di farina e latte, condito con zigar - sorta di ricotta salata - e burro) non era un segno di calorosa accoglienza, bensì una sorta di liquidazione a non farsi più rivedere. Diversamente, a digiuno di zufa, si aprivano dolci scenari, ad esempio con i carafoi, sfogliatelle di pasta dolce fritte nell’olio, molto eclettici. Sancivano il fidanzamento ufficiale dei futuri sposi. Erano offerti agli invitati prima di andare in chiesa per le nozze, ma accompagnavano la coppia anche dopo, nella zarcogna, il cesto che veniva portato in omaggio alla neomamma, assieme a uova fresche, burro e marsala. Carafoi dall’uso eclettico tanto che, se girate per Cortina e qualcuno vi dice «vieni a mangiare i carafoi» è un invito di assoluto riguardo. Sono anche il simbolo della ricorrenza della Madonna del Voto (o della difesa), il 19 gennaio. Leggenda vuole che, nel VII secolo, l’ampezzano era devastato dalle invasioni dei barbari Goti. Nella battaglia cruciale si provvide dall’alto. La Vergine oscurò il cielo con nuvoloni che rendevano impenetrabile la vista laggiù in terra e quindi furono gli stessi Goti a menarsi di lancia e spada tra di loro. Abbinata ai carafoi la brazora, una sorta di grande ciambella decorata con palline di zucchero, arricchita al centro da confetti e gli onnipresenti carafoi.
Molto caratteristiche le fartaies, un decorativo groviglio di strisce fritte a base di latte, uova e farina. Maestro riconosciuto Marco Verzi, accompagnandole poi con marmellata di mirtilli e panna montata. A Cortina c’è una delle storiche delegazioni dell’Accademia italiana della cucina, fondata nel 1964 da Clara Agnelli, che assieme al suo Giovanni Nuvoletti stabilì come fosse necessario «offrire un sostegno alle antiche tradizioni gastronomiche affinché lo spirito ampezzano non venga mai tradito», missione tenuta viva con le varie iniziative di cui è testimone oggi Monica De Mattia, delegata in carica. Si potrebbe raccontare dei casunziei, sorta di ravioli che cambiano di colore, cioè ingrediente, al variar di stagione o dei canederli, grossi gnocchi di pane variamente assemblati che, attenzione, non vanno mai tagliati con il coltello.
Sui titoli di coda il doveroso omaggio a Rachele Padovan, con la quale abbiamo iniziato il viaggio. La sua casa, il larin di Salieto, è stata per decenni ambito ostello goloso di vari protagonisti del Novecento. Di lei si era infatuato Giovanni Comisso che, come ricorda Isabella Panfido, era stato conquistato «da una intelligenza formata dalla solitudine delle montagne». Lei, «dalla voce bassa come Marlene Dietrich», testimone Giorgio Soavi. Rachele metteva a fuoco i gusti e le inclinazioni gastronomiche dei singoli ospiti, rielaborandole a modo suo. Qualche esempio? Mentre il napoletano Riccardo Muti era venuto da lei per festeggiare il Natale, gli servì la pastiera, che all’ombra del Vesuvio è tradizione pasquale. Quel toscanaccio di Indro Montanelli sapeva che solo da lei poteva trovare quel certo risotto alle erbe selvatiche, mentre Vittorio Gassman aveva un debole per la zuppa ai porcini. Il capolavoro con Andrea Zanzotto, perennemente a dieta, che chiedeva «risi longhi» (una minestrina insapore), ma non aveva fatto i conti con la regina del larin (il focolare). Rachele gli servì una sera pasta e fagioli, l’altra spaghetti alla puttanesca. In entrambe le occasioni, al risveglio, ammise di aver dormito bene. Larin di Salieto nido d’amore per Marcello Mastroianni e Faye Dunaway, che si erano incrociati coerentemente sul set di Amanti di Vittorio De Sica, ai quali Rachele serviva in esclusiva un arrosto fatto con amore, come la loro storia.