Campagna vaccinale come «valore etico»: ricatto per ottenere il controllo sociale
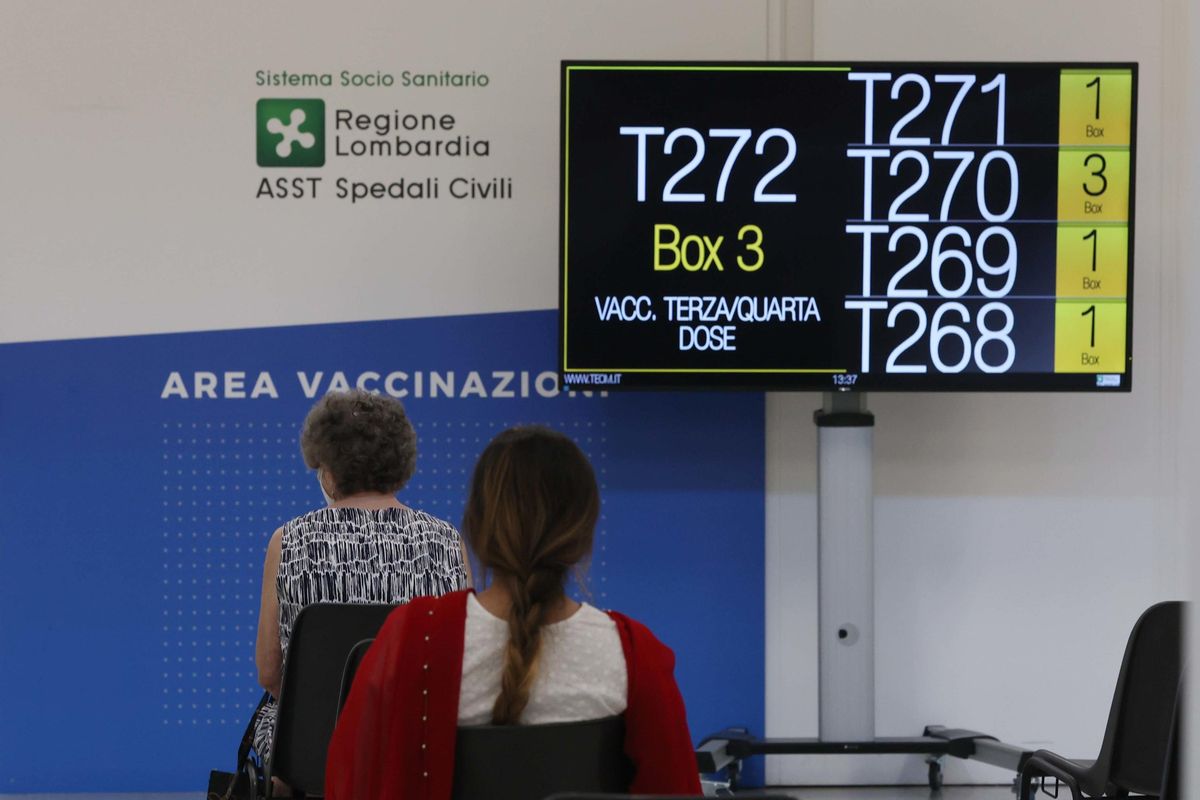
Della mala gestione pandemica, le cui evidenze continuano ad emergere nella generale e sospetta indifferenza del sistema politico-giuridico-mediatico, il passaggio moralmente più grave è stato quello di avere trasformato una discutibile campagna vaccinale in un fatto etico. Da questa ambigua operazione discendono infatti le decisioni di milioni di persone prese sulla pelle propria e altrui, a cominciare da quella dei bambini, vaccinati a tappeto perché - così fu detto - avrebbero protetto i nonni.
A precedere e affiancare le costrizioni fisiche che hanno tolto a chi non era in regola con i diktat vaccinali pseudo-scientifici di volta in volta stabiliti, libertà di movimento, vita sociale e financo diritto al lavoro, c’è stata infatti fin dall’inizio la forte pressione psicologica derivante dall’aver presentato la questione sotto un’aura di «bene comune», «altruismo», senso di «responsabilità» sociale. Il dovere morale della vaccinazione anti Covid è stato sottolineato in modo martellante da tutte le autorità, dalla più alta carica dello Stato in giù. Risuona ancora nelle orecchie il memento dell’allora presidente del Consiglio, Mario Draghi, che in conferenza stampa dichiarò: «se non ti vaccini ti ammali, muori e fai morire». Parole gravissime - e infondate - per le quali non si è mai udita una pubblica ammenda e mai c’è stata una richiesta di chiarimento.
Che si sia trattato di un’operazione condotta in piena malafede, lo dimostra non solo il fatto che chi invocava la vaccinazione per proteggere il prossimo già sapeva che in realtà questi prodotti non impedivano il contagio (come si evince dai contenuti di chat e mail pubblicate in questi giorni), ma anche perché era scorretto ed ingiusto invocare le categorie morali che sono state usate e - è il caso di dirlo - abusate. Il «bene comune», ad esempio, non è uno solo, non è uguale per tutti e lo Stato non ne ha l’esclusiva. C’è invece un bene comune per ogni singolo consorzio umano, ed ogni gruppo umano è chiamato a perseguire il proprio bene comune, che è diverso l’uno dall’altro. «Discernimento» è la parola chiave, dunque, che evidentemente nella vicenda Covid è mancata a vari livelli e in più momenti.
Come spiegano nel docufilm Covid-19, dodici mesi di pensiero critico due sacerdoti che sono tra i protagonisti della rassegna ragionata su quanto accaduto durante la pandemia, il bene comune fa la sintesi tra bene della collettività e bene della singola persona, libera di esprimersi secondo la propria coscienza; coscienza che deve sempre essere pienamente informata. Entrambe condizioni che non sono mai state presenti: sia perché non c’è mai stato equilibrio fra diritti collettivi e individuali ma costrizione frontale di questi ultimi in nome di una ragion di Stato; sia perché le coscienze non sono mai state pienamente in-formate: mancando una corretta informazione, e in presenza di una costante azione di censura di determinate notizie (in primis quelle sugli eventi avversi causati da questi specifici vaccini), le coscienze erano impossibilitate a decidere e dunque a scegliere liberamente che cosa fosse bene e cosa fosse male, per sé e per gli altri.
D’altronde, come ci si può richiamare al bene comune quando in suo nome si fanno confliggere lavoro e salute? E come si può imporre il bene comune quando si è cancellato ogni riferimento alla legge naturale, e quindi a un bene oggettivo valido per tutti? Nella società del relativismo rampante in cui «uno vale uno» e ogni persona è legge a sé stessa, all’improvviso ci è stato chiesto di accettare come bene comune qualcosa che è stato stabilito tale da uno Stato etico a sua volta «ispirato» da una scienza dogmatica, foraggiata da interessi privati e controllata da organismi internazionali.
Anche su questi aspetti, come su tutto il resto, sarebbe allora bastato fermarsi a riflettere: gli elementi c’erano tutti, e fin da subito, per comprendere che non è mai stata questione di bene comune e men che meno di altruismo. Ma quantomeno di controllo sociale, per ottenere il quale non si è esitato a far ricorso a un moralismo falso e aggressivo per colpevolizzare, costringere, gestire. Un’arma straordinariamente potente, che infatti si continua ad usare e a cui si fa abbondantemente ricorso nel nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 trasmesso dalla presidenza del Consiglio a Regioni, Province e ministero della Salute. Il documento, che replica termini e contenuti della recente gestione pandemica e non mostra traccia di discontinuità con le male pratiche degli ultimi tre anni, fin dalle prime pagine sottolinea il «valore etico e sociale delle vaccinazioni» appoggiandosi proprio su alcuni pareri del Comitato nazionale di bioetica (che a sua volta si richiama all’Organizzazione mondiale della sanità). Citando alcuni testi del Comitato risalenti al 2015 - come se nel frattempo non si fosse verificata una pandemia che ha comportato l’uso su larga scala di una nuova generazione di farmaci - e senza operare alcun distinguo tra i vari vaccini, il Piano calca la mano sui «benefici della vaccinazione nel proteggere il singolo e la collettività», sul «valore di un’assunzione di responsabilità personale e sociale» e sulle «motivazioni di carattere solidaristico e cooperativo», per caldeggiare l’osservanza dell’obbligo alla profilassi vaccinale per operatori sanitari e personale scolastico e giustificare un monitoraggio continuo e «granulare» che contrasti l’esitazione vaccinale.
Nonostante i danni compiuti, il ricatto morale dunque subdolamente continua. E torna alla mente la profezia di Ivan Illich, che in Nemesi medica, descriveva un mondo in cui la salute non sarebbe stata più «una proprietà naturale di cui si presume che ogni essere umano sia dotato fino a quando non si dimostra che è malato», ma una «meta permanentemente lontana cui si ha diritto di aspirare in virtù dei principi di giustizia sociale».





