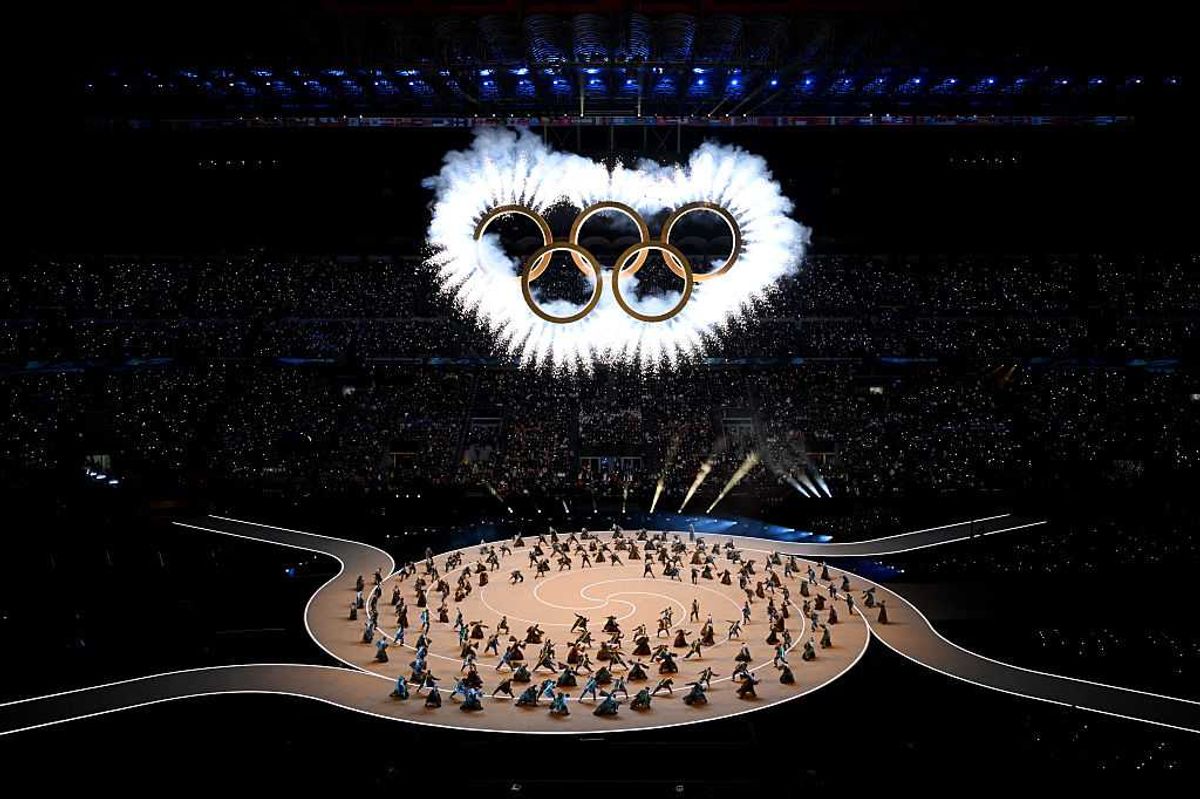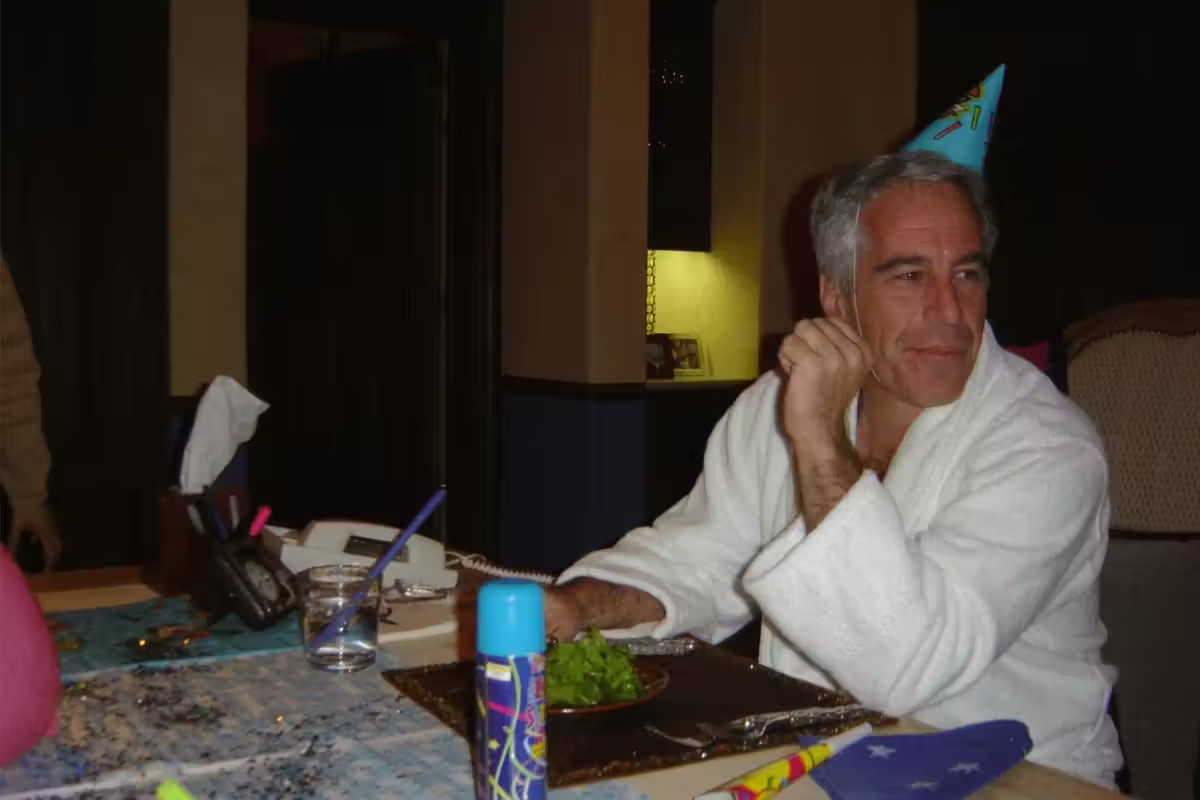Era solo questione di tempo. Ma che gli effetti dell'energy crunch si sarebbero fatti sentire presto sul comparto industriale europeo non è certo una sorpresa, D'altronde, l'impennata dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale non è stata altro che il culmine di una fase rialzista dei prezzi inaugurata lo scorso anno e che probabilmente andrà a sgonfiarsi molto più lentamente di quanto previsto dai policymakers. I quali non ne hanno forse compreso ancora le ricadute sul fronte occupazionale. Inizialmente il focus si è concentrato sul Regno Unito dove effettivamente si registra tutt'oggi una situazione di allarme se pensiamo che da agosto sono 13 le compagnie di utilities saltate lasciando esposti 2 milioni di clienti. Ma l'onda della crisi energetica è già arrivata al di là della Manica. Il primo Paese a essere investito è stato l'Olanda il cui principale produttore di alluminio primario, Aldel, ha annunciato l'interruzione delle attività. Ma è stato quando la Nystar ha comunicato di aver dimezzato la produzione di zinco in Olanda, Belgio e Francia che il mercato ha iniziato a comprendere. L'impatto sui prezzi dell'alluminio e dello zinco è stato immediato con i future a tre mesi scambiati al London metal exchange sui massimi da 14 anni.
Sarebbe da ingenui pensare che l'Italia possa essere esentata. Il «sorvegliato speciale» è il comparto siderurgico: l'80% dell'acciaio proviene da forno elettrico e non da altoforno. Secondo fonti di mercato, a novembre è atteso un calo del 15% della produzione con un effetto immediate sulle richieste di casse integrazioni. Il fortissimo rialzo dei prezzi dei beni energetici ha lasciato disorientato l'intero settore manifatturiero italiano che a giugno e settembre, quando si sono chiusi i contratti di fornitura rispettivamente per l'elettricità e il gas naturale, ha preferito optare (generalmente) per i contratti a componente variabile. Quando all'inizio dell'estate, le compagnie di utilities hanno proposto un prezzo medio per il 2022 di 80 euro a megawattora, la generale reazione delle aziende è stata infatti di rigetto, perché si pensava che la fiammata dei prezzi fosse temporanea. I prezzi invece hanno continuano a salire fino a 300 euro al megawattora due settimane fa. Un errore madornale che però va contestualizzato nell'abitudine maturata negli anni di rapportarsi a un mercato stabile. Ma oggi le condizioni sono strutturalmente diverse. Al punto da non lasciare altra scelta se non ridurre la produzione. Insomma, dall'euforia della crescita al +6%, si rischia di chiudere l'anno con aspettative di ben più contenute con effetti potenzialmente negativi sui titoli di Stato.
E la Ue? Le istituzioni comunitarie continuano a guardare il dito che indica la luna, autorizzando gli Stati ad adottare riduzioni di tasse o tributi e annunciando una fantomatica centrale unica per l'acquisto di gas. Misure, queste, che, se nel primo caso sono di breve termine nel secondo caso non colgono il problema di fondo, e cioè che una parte importante della responsabilità dietro la crisi energetica deriva dalla gestione fallimentare da parte di Bruxelles. Che ha pensato di poter ridimensionare le forniture di lungo termine dalla Russia, compensandole con gli acquisti spot di shale gas americano e la generazione di energia da rinnovabili. Peccato però che nell'ultimo anno gli operatori statunitensi hanno preferito dirottare il gas in Asia e che l'estate sia stata caratterizzata da venti deboli e siccità che hanno compromesso la produzione di pale eoliche e fonti idroelettriche. Insomma, Bruxelles ha perseguito una strategia scellerata perché ha anteposto le questioni economiche e ambientali alla sicurezza energetica. A peggiorare il quadro è poi giunto lo zelo con cui si perseguono le politiche climatiche che hanno disincentivato le compagnie petrolifere a investire in nuova capacità produttiva. La Commissione per il momento continua tuttavia indefessa nel perseguire la strada green inconsapevole che, così facendo, pone le condizioni per uno shock energetico, senza tra l'altro rendersi conto che i Paesi che hanno ispirato le politiche climatiche, come la Cina, hanno già ingranato la retromarcia, ordinando la riapertura delle miniere di carbone per 160 milioni di tonnellate.