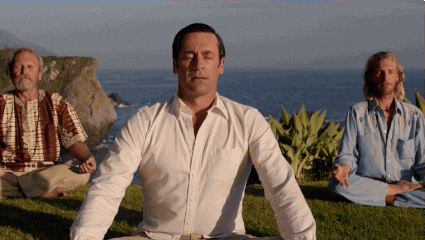
Abbiamo sentito tanto, davvero tanto e così sguaiato chiasso durante i giorni del Congresso delle famiglie, proveniente dalle bocche di chi lo osteggiava, altresì dileggiando la triade «Dio, patria, famiglia». Secondo costoro, avere fede, amare le proprie radici e credere nella famiglia naturale sarebbero costumi retrogradi da sottoporre a rieducazione (Monica Cirinnà). In realtà, si tratta di punti di riferimento che, anche intesi in chiave più simbolica ed estensiva che letterale, possono aiutare parecchio a contrastare quello che Ernesto Calindri, ripreso nella nota pubblicità del digestivo a base di carciofo degli anni Sessanta, definiva «il logorio della vita moderna». Soprattutto Dio, cioè la religione. Diceva Cesare Pavese che «è religione anche non credere in niente» e, in effetti, vige nei progressisti una sorta di ossessione per la cosiddetta laicità dello Stato che muta in isteria non appena si nomina la fede. E invece no, non è così. Non credere in niente è nichilismo. Scrisse Anna Frank: «Coloro che hanno una religione possono ritenersi felici, perché non a tutti è dato credere a cose sopraterrene. Non è neppure necessario credere alla punizione dopo la morte; il purgatorio, l'inferno e il paradiso sono cose che molti possono non ammettere; però una religione, non importa quale essa sia, mette l'uomo sulla buona strada. Non si tratta di temere Iddio, ma di tener alto il proprio onore e la propria coscienza».
Coscienza, anche nel senso di consapevolezza, è la parola chiave. Nell'epoca in cui tutto l'incosciente diventa prassi, non è un caso la moltiplicazione, in libreria, di testi che vanno a cercare proprio nelle religioni i suggerimenti per quella salute e quel benessere che una vita acriticamente supina nei confronti dei diktat contemporanei del pensiero dominante minano. Tra i libri bestseller del New York Times campeggia Il monaco urbano, scritto da Pedram Shojai e volto a insegnare «saggezza orientale e rimedi moderni per fermare il tempo e trovare il successo, la felicità e la pace». Shojai spiega come l'uomo contemporaneo viva in uno stato di continua sollecitazione del sistema nervoso simpatico (quello che attiva il meccanismo «lotta e fuggi» in situazione di pericolo). E di conseguente inibizione del versante opposto di questo interruttore, il sistema nervoso parasimpatico, regolatore della modalità «riposa e digerisci» che in condizioni di esistenza serena perequa il primo, nelle condizioni contrarie non ci riesce.
Lo stress, soprattutto cronico, fa sì che si la modalità «lotta e fuggi» diventi una pericolosa quotidianità, mentre invece dovrebbe essere solo temporanea e collegata a un pericolo vero (come un terremoto o un maremoto). Le conseguenze sono serie: riduzione dell'energia destinata al sistema immunitario, taglio dell'energia destinata all'apparato digerente e agli organi interni, innesco di un ottovolante glicemico, scoppio del caos nel sistema endocrino. Serie e, alla lunga, disastrose: «i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) - importanti organismi di controllo sulla sanità pubblica statunitensi - imputano allo stress la causa del 90% delle malattie croniche». Un aspetto assai preoccupante, secondo Shojai, è la riduzione del flusso sanguigno alla corteccia prefrontale, con successiva difficoltà nella negazione degli impulsi, diffidenza, reattività, minore empatia e incapacità di prendere decisioni a lungo termine e assennate.
Rimedi? Innanzitutto meditare: «Vari studi dimostrano che perfino i meditanti principianti sviluppano una maggiore densità di neuroni corticali nella corteccia prefrontale». Spiega Shojai che non bisogna ricorrere alla meditazione quando lo stress è ingestibile, ma prevenirlo meditando quando siamo sereni: «Imprimere segnali di calma», lasciando andare quei pensieri che rendono reattivi e mettono a disagio. Altro insegnamento monacale è sottrarsi alla schiavitù del denaro, uno dei motivi per i quali ci affanniamo tanto: il senso di sé poggia prima su solide fondamenta interiori che sull'estratto conto. Altro bel suggerimento è vigilare sulle informazioni che riceviamo: «Guardare i notiziari televisivi vi convincerà che il mondo sia un luogo pericoloso e che dovete restare stressati. È un modo fantastico per accanirvi sulle ghiandole surrenali e per condurvi nell'ambulatorio di un medico». Il nostro consiglio non è di vivere fuori dal mondo, ma di ritrovare una misura nell'informazione, una, due volte al giorno. Importante anche dedicarsi con altrettanta ricettività a incamerare materiale di pensiero che sia positivo, immaginandolo come cibo, in questo caso della mente e dell'animo. Libri, musica, arte, hobby: nutrirsi di qualsiasi cosa che interessi e faccia sorridere.
I suggerimenti di Shojai sono davvero tanti: dagli esercizi qigong all'impostazione sul cellulare di promemoria per prendersi cura di sé stessi, dallo sporcarsi le mani di terra partecipando al processo di crescita del cibo - anche solo con un vasetto di piante aromatiche sul piano di lavoro della cucina, suggeriamo noi - al mangiare con consapevolezza, dall'imparare abilità primitive come accendere un fuoco - non bisogna diventare Tarzan, anche fare un barbecue ci riporta al contatto col fuoco - al camminare in silenzio nella natura (fosse anche solo al parco). Insomma, fondamentale è riprendersi dal «disturbo da deficit di natura». La natura, torniamo sempre lì. E si capisce, poiché la natura è considerata l'habitat originario ed elettivo dell'uomo da pressoché tutte le religioni. Lo stile di vita del monaco, che in una società opulenta e barocca come la nostra diventa semplicemente lo stile di vita di un saggio (per esempio, Shojai non criminalizza il denaro, dice che dobbiamo saperlo difendere, non farne un'ossessione ma nemmeno dilapidarlo e vivere come asceti), non è peculiare del solo Oriente - Shojai è un ex monaco taoista, oltre che medico di medicina cinese. Anzi.
C'è anche il monaco urbano occidentale, per la precisione cattolico. Ne La felicità del meno. Le dieci regole dei monaci per vivere meglio di Maria Chiara Giorda e Sara Hejazi raccontano come la vita monastica non sia affatto una rinuncia. Le due autrici, rispettivamente una storica delle religioni e un'antropologa, non sono credenti. Specificano: «Nessuna di noi due si è convertita alle religioni dei monaci con cui siamo entrate in contatto, anche se in fondo ci sarebbe piaciuto molto. Una delle nostre frasi preferite, uscite dai monasteri, era sempre la stessa: “Beati loro che credono!". Purtroppo ci siamo giocate un simile privilegio anni fa, studiando le religioni e l'antropologia delle religioni, il che non aiuta ad avere una fede salda. Sarà colpa di Jacques Derrida, Edgar Morin, Max Weber, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, Marvin Harris». Ispirarsi ai segreti di vita dei monaci non vuol dire farsi monaci, né vivere 24 ore su 24 come i monaci, ma carpirne la saggezza per utilizzarla come tecnica di resilienza della nostra vita. Esplorate nei capitoli del libro - Tutti soli appassionatamente, Chi dorme non piglia pesci, Bellezza, Tutti per tutto e tutto per tutti, No grazie. Le donne e il multitasking, Aspetta (e non sperare), Lavora! Ma non troppo, Sii un buon ospite, Studia (non importa cosa ma come), Non cercare la felicità - queste suggestioni non sono così dissimili da quelle orientali e, come quelle, illustrano come riscoprire lo stile di vita dei monaci nostrani aiuti lo spirito e il corpo.
Paolo Rumiz, nel libro Il filo invisibile, compie un viaggio attraverso i monasteri europei. Un viaggio dichiaratamente laico. A Norcia scrive: «Fu lì che vidi la statua, illuminata a giorno al centro della piazza. Mostrava un uomo dalla barba venerabile e dalla larga tunica, sollevava il braccio destro come per indicare qualcosa fra cielo e Terra. Era intatta in mezzo alla distruzione, e portava la scritta San Benedetto, patrono d'Europa. Fu un tuffo al cuore. Fino a quel momento non avevo minimamente pensato al santo e al suo rapporto con Norcia, con il terremoto, con la terra madre del Continente cui appartenevo». Rumiz rileva come «i monaci rifondarono l'Europa sotto l'urto delle invasioni barbariche. Come i padri fondatori dell'Unione che dopo due guerre mondiali ridiedero dignità e ricchezza a un continente in ginocchio». L'Europa… In realtà, le critiche dei sovranisti all'Europa non riguardano l'Europa in sé, ma il fatto che debba essere a tutti i costi un'Europa progressista, con tutti i suoi limiti, le sue contraddizioni e i danni per le nazioni che ne fanno parte e auspicano una maggiore autarchia. Inoltre, San Benedetto è patrono d'Europa in quanto santo della religione cattolica, la diffusione dei monasteri aveva una ragione innanzitutto evangelizzatrice, dunque una lettura così forzatamente laico-europeista-progressista di San Benedetto, a nostro avviso, è un po' inopportuna.
Basta leggere la Regola di San Benedetto per capire come il santo, sebbene le sue parole e i suoi gesti possano ispirare anche chi, non essendo né un monaco né un fedele, non intende quelle regole come preciso esercizio di fede, comunque scrivesse un testo precisamente religioso, non un manuale di wellness. Trascriviamo il capitolo quarto, Gli strumenti delle buone opere: «Prima di tutto amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze; poi il prossimo come sé stesso. Quindi non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non avere desideri illeciti, non mentire; onorare tutti gli uomini, e non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Rinnegare completamente se stesso per seguire Cristo; mortificare il proprio corpo, non cercare le comodità, amare il digiuno. Soccorrere i poveri, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, seppellire i morti; alleviare tutte le sofferenze, consolare quelli che sono nell'afflizione. Rendersi estraneo alla mentalità del mondo; non anteporre nulla all'amore di Cristo. Non dare sfogo all'ira, non serbare rancore, non covare inganni nel cuore, non dare un falso saluto di pace, non abbandonare la carità. Non giurare per evitare spergiuri, dire la verità con il cuore e con la bocca, non rendere male per male, non fare torti a nessuno, ma sopportare pazientemente quelli che vengono fatti a noi; amare i nemici, non ricambiare le ingiurie e le calunnie, ma piuttosto rispondere con la benevolenza verso i nostri offensori, sopportare persecuzioni per la giustizia. Non essere superbo, non dedito al vino, né vorace, non dormiglione, né pigro; non mormoratore, né maldicente. Riporre in Dio la propria speranza, attribuire a Lui e non a sé quanto di buono scopriamo in noi, ma essere consapevoli che il male viene da noi e accettarne la responsabilità. Temere il giorno del giudizio, tremare al pensiero dell'inferno, anelare con tutta l'anima alla vita eterna, prospettarsi sempre la possibilità della morte. Vigilare continuamente sulle proprie azioni, essere convinti che Dio ci guarda dovunque. Spezzare subito in Cristo tutti i cattivi pensieri che ci sorgono in cuore e manifestarli al padre spirituale. Guardarsi dai discorsi cattivi o sconvenienti, non amare di parlar molto, non dire parole leggere o ridicole, non ridere spesso e smodatamente. Ascoltare volentieri la lettura della parola di Dio, dedicarsi con frequenza alla preghiera; in questa confessare ogni giorno a Dio con profondo dolore le colpe passate e cercare di emendarsene per l'avvenire. Non appagare i desideri della natura corrotta, odiare la volontà propria, obbedire in tutto agli ordini dell'abate, anche se - Dio non voglia! - questi agisse diversamente da come parla, ricordando quel precetto del Signore: «Fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno». Non voler esser detto santo prima di esserlo, ma diventare veramente tale, in modo che poi si possa dirlo con più fondamento. Adempiere quotidianamente i comandamenti di Dio. Amare la castità, non odiare nessuno, non essere geloso, non coltivare l'invidia, non amare le contese, fuggire l'alterigia e rispettare gli anziani, amare i giovani, pregare per i nemici nell'amore di Cristo, nell'eventualità di un contrasto con un fratello, stabilire la pace prima del tramonto del sole. E non disperare mai della misericordia di Dio. Ecco, questi sono gli strumenti dell'arte spirituale!».
Di una rigorosità che è innanzitutto saggezza sono anche gli insegnamenti alimentari dei monaci. Abbiamo scelto quelli dei frati della Certosa di Calci in provincia di Pisa, che oggi è un Museo nazionale ma fino al 1969 era abitata dai frati stessi, appartenenti all'Ordine certosino fondato da San Bruno. Secondo Angela Zinnai, docente alla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, la dieta tipica dei frati era salutare. Pesce bianco, più di fiume che di mare, carne solo per i laici, latte di pecora, capra e mucca e formaggi derivati, uova, legumi, ortaggi, frutta, olio, vino, pasta, pane, piante officinali, dolci come buccellato, schiacciata di Pasqua, bocca di dama, paste di mandorle. Secondo la docente «il consumo di ortaggi e frutta fresca, un limitato utilizzo dei grassi e l'assunzione di una modica quantità di vino rosso, rappresenta la via efficace per alimentarsi correttamente assicurando la necessaria presenza di antiossidanti nella nostra dieta. I pesci, in genere, oltre ad apportare proteine ad alto valore biologico, contengono buone quantità di acidi grassi polinsaturi, importanti nella formazione di tutte le membrane cellulari (in particolare di quelle proprie delle cellule nervose) ma capaci anche di evitare o rallentare il processo di accumulo di grassi all'interno dei vasi sanguigni. Evitando o diminuendo l'incidenza dell'insorgenza delle malattie cardiovascolari». Secondo l'agricoltore pisano e produttore biologico Alessandro Bonamici, i certosini coltivavano biologico: «Non ho studiato a fondo le tecniche di lavorazione della terra utilizzate dai frati certosini tre secoli fa, ma immagino che non fossero diverse da quelle seguite dai laici del loro tempo. Significativa la filosofia che ispirava il lavoro della terra: il terreno è un dono di Dio, dato in prestito dai predecessori e che dovrà essere affidato a chi verrà dopo di noi. Per questo si seguiva il principio della fertilità del terreno e il suo utilizzo a rotazione». E per tutelare le piante dai parassiti: «I certosini avevano studiato erbe per curare le malattie dell'uomo e per proteggere le piante: infusi di ortica, ad esempio. Oggi i produttori biologici non si discostano molto da quelle soluzioni». Non dite ad amici progressisti naturalmente laici che i monaci hanno inventato il bio e l'ecologismo prima di loro. Non credono in Dio, ma fanno di Greta Thurnberg un nuovo dio. Oppure, se glielo volete proprio rivelare, ricordate cosa diceva San Benedetto e fatelo con «benevolenza verso gli offensori».




 Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)
Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)

