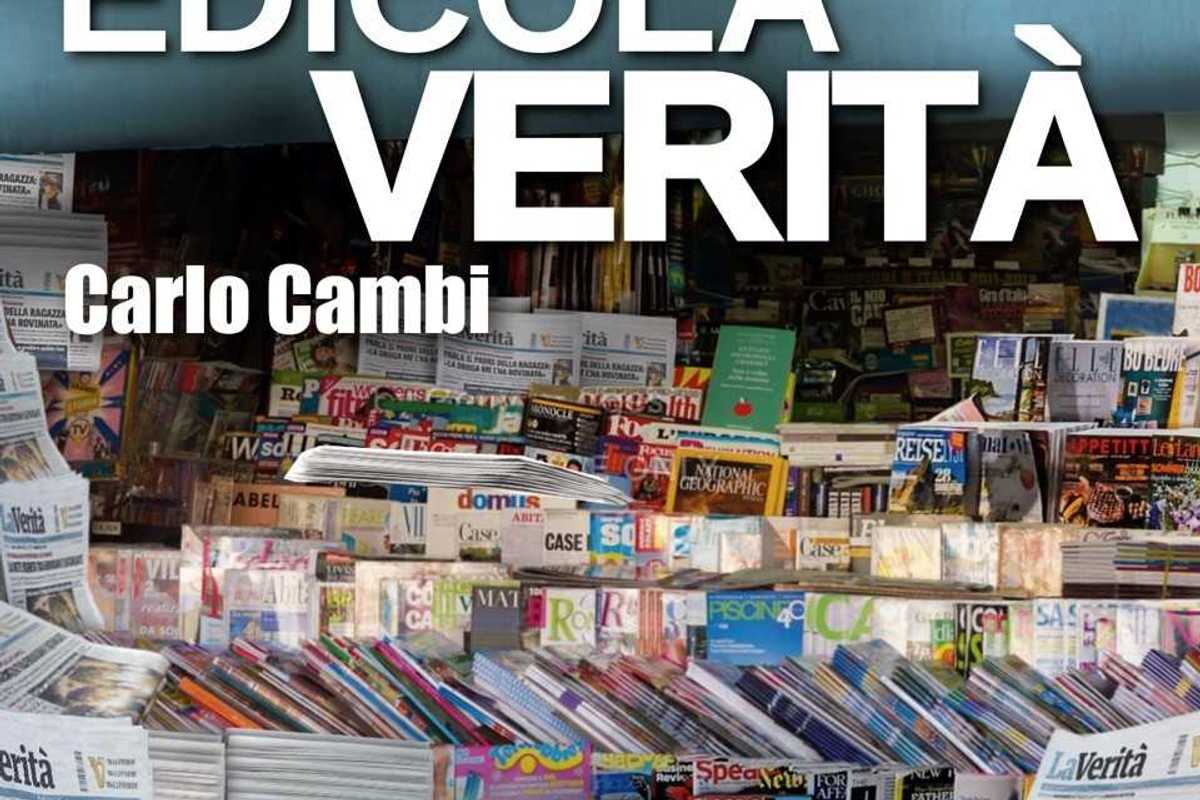Finalmente il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, l'ha detto chiaro e tondo. «Le bollette sono aumentate lo scorso trimestre del 20% e il prossimo aumenteranno fino al 40». In pratica, se le previsioni sono giuste - e lo saranno - l'anno prossimo rispetto alla primavera appena trascorsa pagheremo il 68% in più per riscaldare le nostre abitazioni, per avviare i nostri pc o i macchinari delle fabbriche. «Il rincaro del gas ha una ragione semplice», ha detto il ministro durante un convegno organizzato dalla Cgil, «Mentre la pandemia viene debellata, l'economia mondiale si riprende. Le aziende tornano a lavorare a pieno regime, e la domanda di energia si impenna. Ergo, il costo del gas, fonte principale dell'elettricità, aumenta. Poi c'è l'altro elemento, l'aumento del prezzo della CO2. E questo ha a che fare con la necessità di decarbonizzare l'economia, per combattere la crisi climatica. Le aziende che producono anidride carbonica (il principale gas serra), fra le quali quelle energetiche, nella Ue devono pagare per questo, comprando quote di emissioni nel sistema europeo Ets. Il prezzo di queste quote viene aumentato gradualmente, per spingere le aziende a decarbonizzare. Ma questo porta anche a un aumento dei costi di produzione, e quindi delle tariffe in bolletta».
La sintesi è perfetta. Bisogna aggiungere però qualche elemento. Ieri a partire dai sindacalisti presenti e poi da altri politici, in molti si sono stupiti delle dichiarazioni di Cingolani. Purtroppo non c'è nulla di cui stupirsi. L'incremento non è per niente qualcosa di improvviso. Ne abbiamo scritto numerose volte denunciando il trend e soprattutto le scelte dell'Unione europea. Quando ieri il ministro si è soffermato sui costi del trading della CO2 ha spiegato, come riportiamo sopra, che essi vengono aumentati gradualmente. Purtroppo non è così. La Borsa degli Ets, i certificati che prezzano questo mercato, ha visto l'asticella passare dai 33 euro a tonnellata dello scorso gennaio alle attuali 63. Questo perché l'Unione europea ha fortemente voluto il Fit for 55, un pacchetto che impone obiettivi di transizione ecologica totalmente fuori dalla realtà. Il risultato è che una buona fetta di aziende Ue si troverà fuori mercato già nei prossimi due anni e la spinta politica sta alzando i prezzi di gestione di chi, secondo i nuovi criteri, inquina. Il tutto mentre l'Ue è responsabile di poco più del 9% di tutte le emissioni mondiali. Niente rispetto alle quote di Cina, Asia e persino Usa. Eppure sembra una scelta irreversibile.
Lo stesso Cingolani ha fatto due dichiarazioni di buon senso ed è stato mangiato vivo dai fautori dell'Europa a tutti i costi. Ha invitato il governo e pure gli stakeholder a ragionare su una transizione più moderata se non si vuole sacrificare l'industria dell'auto o altre eccellenze italiane ed è stato messo in croce. Peggio quando ha aperto a nuove vie sul nucleare. Ha ricordato che non possiamo affidarci soltanto alle rinnovabili, ma che ci vuole l'atomo di ultima generazione affiancato a gas e semmai pure l'idrogeno. Anche in questo caso le sue dichiarazioni sono state accolte come se fosse un esponente del centrodestra che critica l'Ue. Cingolani ha solo infilato il dito nella piaga che Bruxelles si ostina a definire in altro modo. Per la Commissione il green estremo è progresso. Sarà invece solo povertà se non lo si gestisce in base alle proprie caratteristiche economiche.
Ieri anche in Polonia hanno ricevuto la stessa notizia che ha diramato Cingolani al convegno Cgil. I polacchi hanno appreso che il prossimo anno le loro bollette aumenteranno del 40%. Il governo di Varsavia intende inserire una voce apposita per calcolare il margine di aumento imputabile direttamente alle politiche green della Ue. In Polonia il tema tiene banco. Ieri, passando alla Danimarca, il principale trader energetico Nordstrom Invest ha fatto bancarotta. Non è risucito a sostenere gli aumenti. Da noi ancora tutto tace. Eppure in Italia le aziende non energivore pagano già un differenziale del 30% rispetto alla media Ue. Colpe delle tasse. Il problema è complesso. Purtroppo, non c'è solo la follia green da domare. C'è il tema dei colli di bottiglia dei consumi dovuti alla ripresa dell'economia post Covid, ma c'è anche un tema più articolato che chiama in causa le Banche centrali.
L'enorme massa di liquidità immessa sui mercati dalla Fed, la Banca centrale Usa, e dalla nostra Bce non è un atto senza conseguenza. Da un lato si genera deficit commerciale e dall'altro debito. Le Banche centrali non possono far esplodere la bolla, cosa che avverrebbe vendendo gli asset patrimoniali acquistati a partire dal 2009. Per questo l'inflazione indotta sulle materie prime è un ottimo sistema per sgonfiare i debiti pubblici ed evitare che la bolla scoppi tra le mani degli investitori. Certo, la pagheranno i più poveri e coloro che vivono con il reddito da lavoro. A tutte queste dinamiche complesse si somma la situazione peculiare dell'Italia. È un Paese indebitato, con scarsa produttività (e quindi gli stipendi faticano a stare al passo con l'inflazione) e con una industria manifatturiera ridotta all'osso (basti pensare all'Ilva ma anche al settore dell'automotive). Il Parlamento dovrebbe discutere dell'inflazione tutti i giorni. Altro che ius soli, ddl Zan o decreti anti delocalizzazioni. Questa è la sfida dei prossimi due anni. La sfida di questo governo. Noi lo denunciamo da mesi e continueremo a farlo.