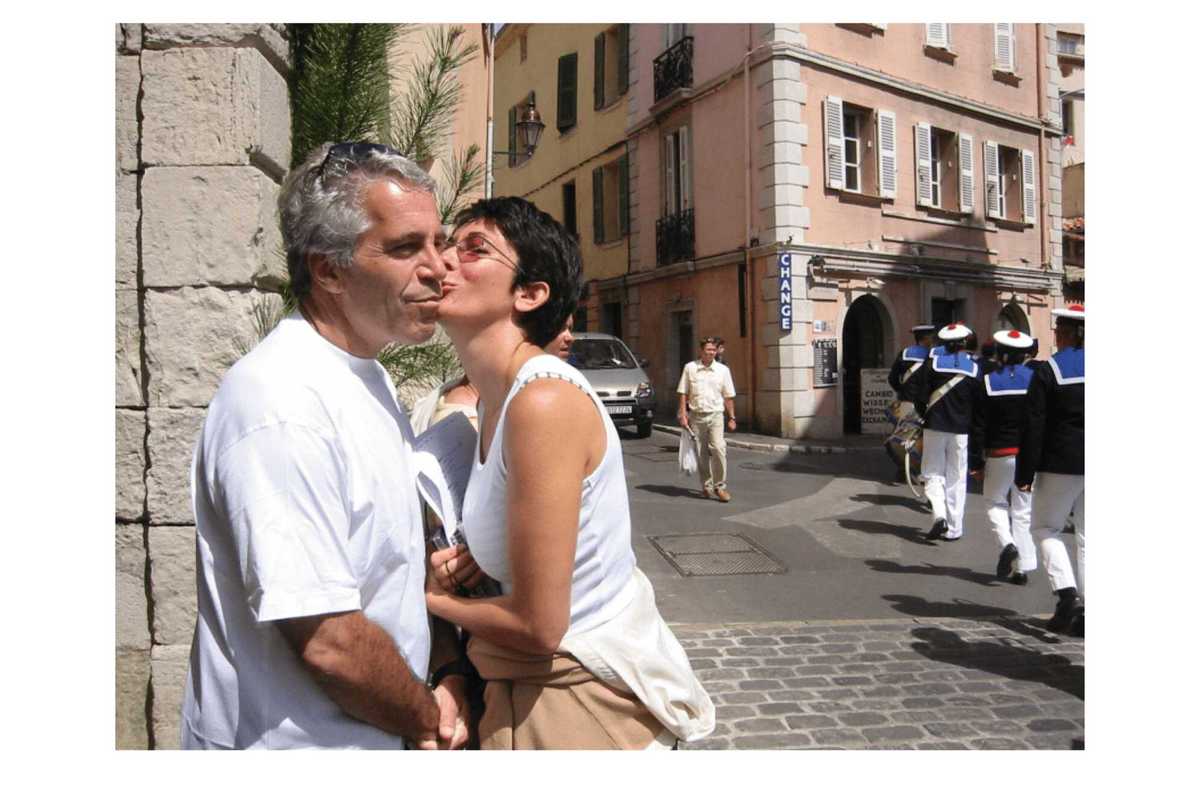Perché stiamo vivendo una nuova stagione liturgica della Chiesa? La liturgia della messa è sostanza non solo forma, ma ciò non è così chiaro a tutti gli osservatori e commentatori. Il recente motu proprio Traditionis Custodes si direbbe serva ad abrogare non solo il Summorum Pontificum, ma anche e definitivamente lo spirito del Messale Tridentino che era stato promulgato da papa san Pio V nel 1570 per negare le tesi protestanti. Papa san Pio V con san Carlo Borromeo e sant'Ignazio di Loyola (fondatore della Compagnia di Gesù), fu promotore della Controriforma, cioè del rinnovamento teologico e liturgico a seguito del Concilio di Trento, convocato per arginare la dottrina protestante di Lutero.
Quest'ultimo motu proprio Traditionis Custodes di fatto decreta quale deve essere il rito per celebrare la messa d'ora in avanti. Curiosamente, nel tono e nello stile sintetico e impositivo, sembra essersi ispirato in sostanza proprio alla Bolla di Pio V che decretava: «Uno solo sia il rito per celebrare la messa». In realtà questo motu proprio sembrerebbe anche delegare ai vescovi le decisioni su come regolare la messa, conformemente alle indicazioni della Sede apostolica. In Italia i vescovi diocesani sono 226 e nel mondo sono più di 4.000, pertanto non sarà facilissimo ottenere il risultato auspicato nella introduzione al motu proprio, cioè avere un solo rito e promuovere concordia e unità nella Chiesa onde evitare divisioni. Intuirei piuttosto che una forma delegata possa incoraggiare una certa «creatività», facilitando rischi di omissioni o interpretazioni soggettive nella liturgia e possa implicitamente compromettere in vari casi la natura unica della messa. Mi pongo due domande.
Perché tanta avversione al Summorum Pontificum? L'intenzione di Benedetto XVI nel Summorum Pontificum era quella, con intento unitivo e non certo divisivo, di render disponibile la cosiddetta messa tradizionale (vetus ordo) per permettere di comprendere il collegamento con quella del novus ordo, e facilitare la comprensione del senso della liturgia come qualcosa radicato nella tradizione, non un capriccio o una preferenza secondo mode.
Perché tanta attenzione alla liturgia? Perché la liturgia della messa non è forma, è sostanza. Il suo scopo non è esser celebrata, è cambiare l'uomo arricchendolo moralmente e soprattutto aprendolo alla Grazia attraverso la ritualità della liturgia. Perché ciò possa avvenire la messa deve trasmettere ai fedeli gli stessi sentimenti di Cristo sulla Croce, permettendogli di identificarsi con Lui. E ciò avviene grazie alla «partecipazione interiore» alla messa. Ogni gesto nella messa è finalizzato a questo, perciò sono importanti gli atti della liturgia, le posizioni (in ginocchio, in piedi, seduti), le preghiere, la musica e i canti. E soprattutto la Consacrazione delle specie (pane e vino), le parole pronunciate e l'intenzione a rinnovare il sacrificio. Chissà se i detrattori del vetus ordo sanno cosa è «partecipazione interiore». L'attenzione alla liturgia, secondo me, non è affatto originata da una disputa sulla divisione tra «chiesa dei fedeli contrapposta a chiesa dei preti» o sull'uso del latino, dei canti gregoriani o sull'attaccamento a una rigida tradizione formale che per taluni non facilita la partecipazione alla messa. Con grande sorpresa leggo che si vorrebbe giustificare l'esigenza di cancellare il vecchio rito perché utilizzato in senso «anticonciliare».
Cancellare il Sommurum Pontificum perché provoca divisioni, in pratica equivarrebbe a cancellare un diritto lecito solo perché qualcuno ne abusa o è sospettato di utilizzarlo per fini diversi e malvagi. Si colpisca semmai l'abuso, ma non il diritto. Semmai ci si domandi perché provoca divisioni, se queste siano preesistenti e non prescindano dal Summorum Pontificum. Qualcuno ritiene che nel vetus ordo, differentemente dal novus ordo, non si celebri il sacrificio della Croce?
La disputa vera è un'altra. È, è sempre stata e sarà, sulla sostanza, cioè sui dogmi del Santo sacrificio, della Presenza reale, della Transustansazione, del Sacramento dell'ordine (del celebrante).
La riforma protestante pretese di sopprimere il Sacrificio della messa trasformandola in una cena simbolica, un memoriale, mettendo in discussione o confondendo la Presenza reale, la realtà del Sacrificio eucaristico, il valore sacramentale. Domando: colpevolizzare il Summorum Pontificum non lascia intendere una volontà di clericalizzare e luteranizzare la messa, con il sospetto che si voglia confondere la liturgia, ma soprattutto il suo fine? Ma non voglio certo fare processi alle intenzioni, solo domande.