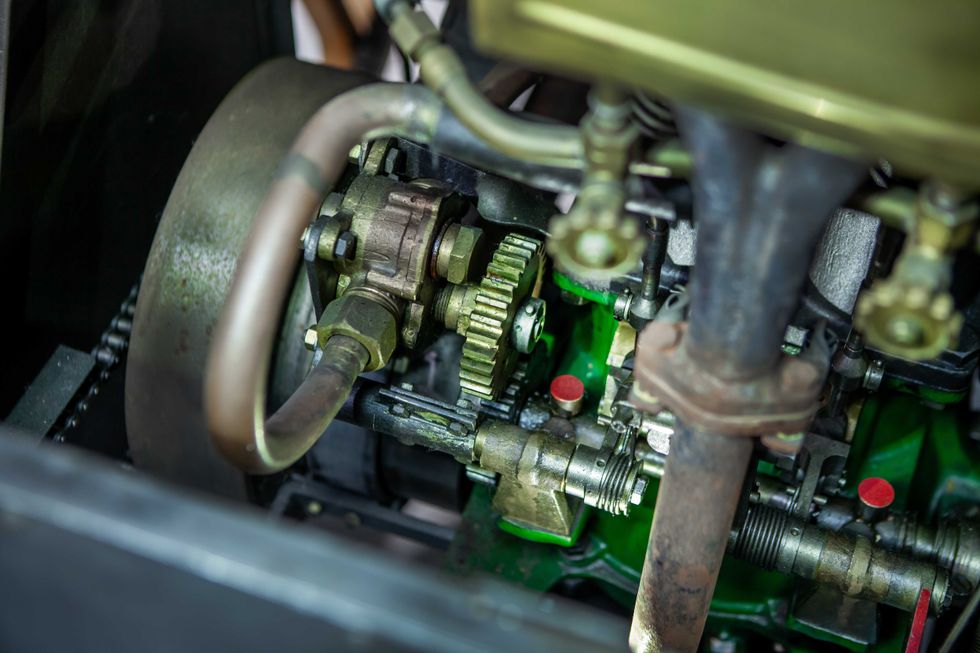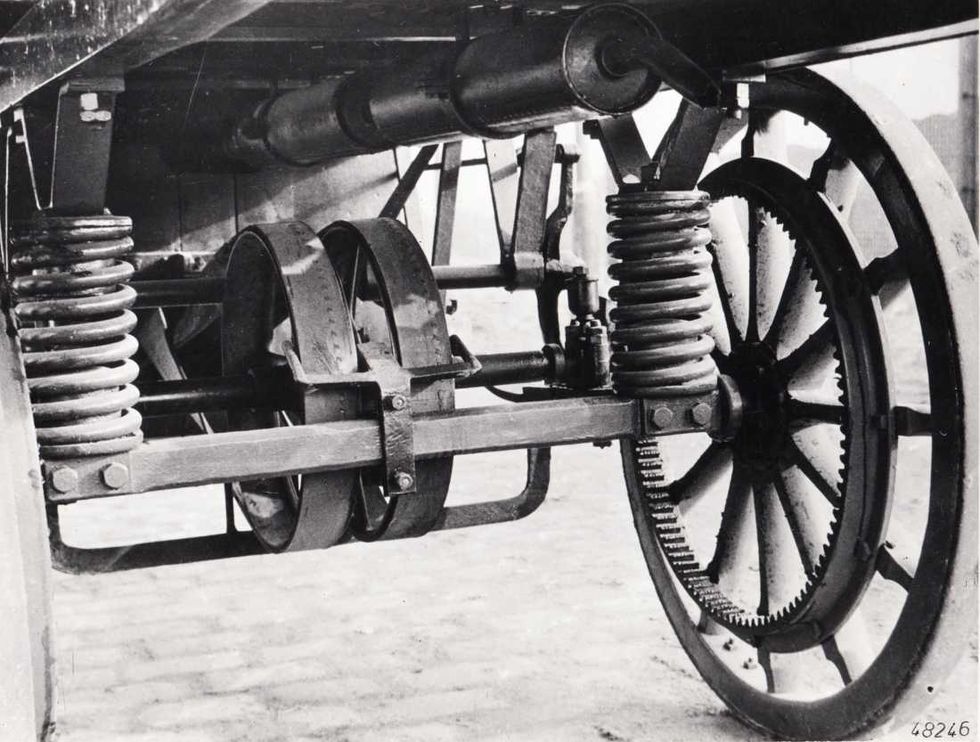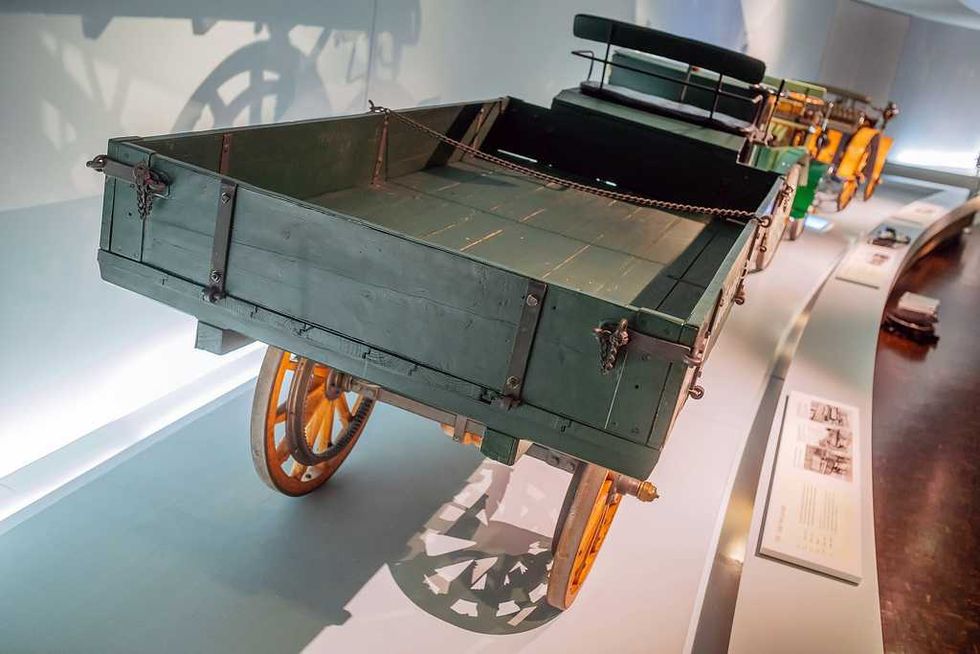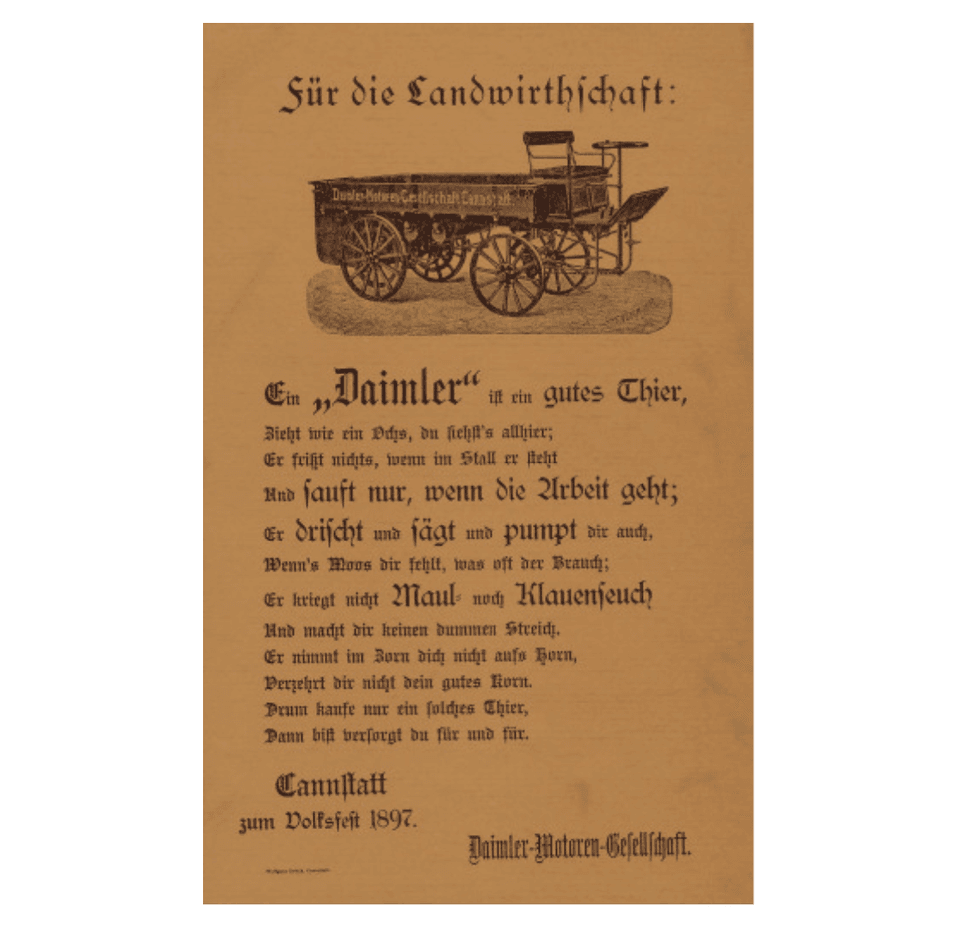È Giorgio Armani a far scendere la clair sulla Settimana della moda milanese dedicata alle collezioni del prossimo inverno. È un vero re il «nostro» grande Giorgio, capace di essere sempre al passo con i tempi, con le voglie della gente, con le necessità quotidiane e con il piacere di essere vestiti bene dalla mattina alla sera. «La passerella per me è una proposta: la mia visione del momento attuale, che questa stagione è particolarmente libera da costrizioni e convenzioni», ha spiegato lo stilista, «E mi piace immaginare gli abiti che entrano nei guardaroba e nelle vite di uomini diversi per età e atteggiamento, e che vengono interpretati da ciascuno secondo la propria personalità. Fare moda, per me, significa creare strumenti che accompagnano la vita, rendendola idealmente più bella e confortevole». Il tocco inconfondibile finisce in una eleganza senza costrizioni e imposizioni. Tutto è morbido, avvolgente, dalle forme ai tessuti e alle maglie. Le silhouette si modificano: i cappotti e le giacche si amplificano, le camicie e i pantaloni diventano più sciolti e confortevoli; gilet zippati dal piglio sportivo finiscono anche sotto il tuxedo. Il formale si mescola all’informale: lane fini, sete e cashmere si uniscono a materie più consistenti. Fino ad arrivare ai montoni che diventano cappe, gilet, sciarpe. Il grigio prevale ma spiccano i tocchi di rosso rubino, verde smeraldo e blu giadeite.
Seduzione come denominatore comune anche da Emporio Armani. Il fascino finisce in giacche in velluto lucido, pantaloni ampi e a vita alta, cappe e cappotti larghi e una sera dai tocchi orientali. «Ho voluto creare una collezione allo stesso tempo vivace e misurata. Mi piace l’idea di giocare con elementi estremi, come il metallo e i maculati, i tessuti a pelo lungo e i broccati, sempre visti attraverso la mia personale visione dello stile», conclude Armani.
Se si vuole vedere il domani della moda bisogna guardare le sfilate di Prada. Questa volta è andata in scena la collezione uomo del futuro inverno 2025/2026. Ma anche le prossime volte sarà così: che si parli al maschile o al femminile, ciò che sale in passerella è sempre qualcosa che non ti aspetti, spiazzante. Miuccia Prada e Raf Simons hanno ridefinito il concetto di lusso ribelle che tradotto vuol dire essere sofisticati e veramente fighi in un modo completamente diverso da quello che si poteva immaginare prima. Un esempio? Timothée Chalamet alla presentazione del film A Complete Unknown, completo di velluto color caramello con la camicia lasciata fuori (che in sfilata è di pelle), gli occhiali con piccoli cristalli e stivaletti texani stile Bob Dylan. Dettagli che fanno tutto. Look dopo look sono mille i pensieri che si rincorrono: possono essere studenti universitari, veri esteti, magari studiosi di greco antico e filosofia; possono essere gli uomini che si vogliono distinguere con altezzosa indifferenza. Tanta è la distanza dalla normalità con quei cappotti classici di sartoria, quei pantaloni stretti che faticano a stare sopra gli stivali, spesso in colori forti e in tessuti setosi. Quelle pelli di montone che sembrano appena uscite da una conceria e che diventano grandi colli a volte sciallati, gilet, balaclava. Una nuova raffinatezza e un’eleganza intima, selvaggia. «Il romanticismo inteso come qualcosa di emotivo e immediato, la creatività senza troppe riflessioni e come qualcosa di profondamente umano», spiega Miuccia Prada. Liberate la mente e lasciatevi andare, in pratica. Una collezione che indaga la natura umana. E forse è proprio da lì che bisogna partire.
Cosa si chiede oggi alla moda? Alessandro Sartori, direttore artistico di Zegna, risponde con un evento che ha fatto la differenza. «Nel 1963, Ermenegildo Zegna, il fondatore, istituì i Wool trophy awards in Australia per supportare gli allevatori nella loro ricerca della lana più sottile al mondo. A oggi, il record mondiale vellus aureum per la singola fibra di lana è stato raggiunto nel 2023 con una finezza di 9,4 micron». Il tessuto della collezione. «Il modo in cui abiti, storia personale e atteggiamenti si fondono è per noi centrale», continua Alessandro Sartori, «In questa collezione i capi sono scelti con nonchalance e mescolati spontaneamente raccontando un incontro di generazioni nel nome dello stile italiano. Lavorando con lane lavate e vellus aureum siamo stati in grado di trasferire la vita vissuta sui capi. C’è qualcosa di tipicamente torinese in questa collezione, nell’atteggiamento colto che le forme suggeriscono e nel modo noncurante in cui vengono indossate, che è una maniera peculiare di essere italiani». «Abbiamo aperto l’armadio del nonno Zegna e lo abbiamo rielaborato».
Volumi più ampi, proporzioni ripensate. Blazer destrutturati con chiusure basse a due bottoni; cappotti oversize con colli in pelliccia di cashmere che arrivano fino al ginocchio. Parla di «esperienza sensoriale», Matteo Tamburini, direttore creativo di Tod’s che celebra lo stile discreto e senza tempo così come la qualità incomparabile della manifattura artigianale italiana del marchio di Diego Della Valle. Va in scena il design italiano tra Gio Ponti e Vico Magistretti, l’arte e il progetto Pashmy, massima espressione dell’eccellenza nella ricerca e selezione dei pellami più pregiati. Ecco il bomber e la shirt jacket nei toni naturali della terra; il Gommino in scamosciati, nappe e pellami spazzolati a mano dagli artigiani del brand. Fay, del gruppo Tod’s e capitanato da Andrea Della Valle, ha puntato su un allestimento museale per raccontare i propri capi iconici con un progetto a tappe affidato al fotografo Michael Avedon, nipote del leggendario Richard, e a James Dylan, nipote del cantautore premio Nobel Bob Dylan.