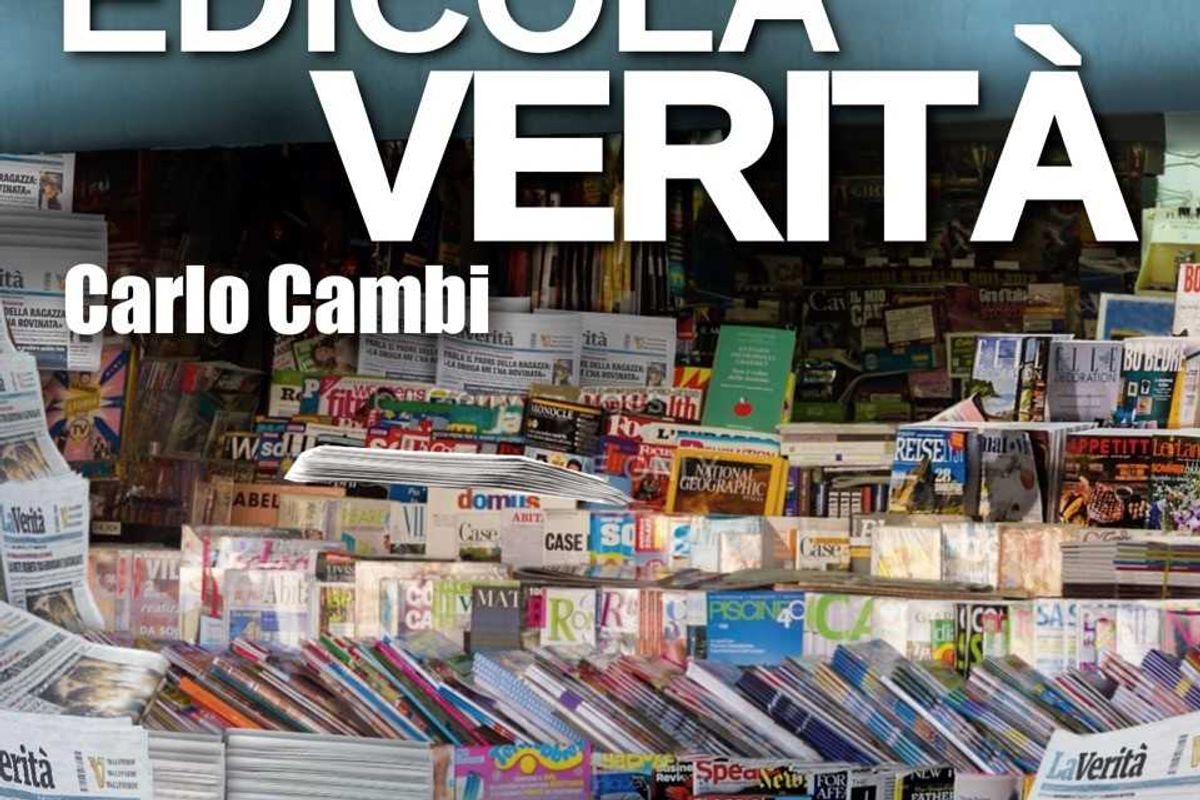«Caro Pd, la coscienza non vale solo quando il voto è del tutto ininfluente»

«Forse come Pd dovremmo parlare dei 25 voti mancati a Luca Zaia, più che della mia astensione». Difende il suo gesto Anna Maria Bigon, il consigliere regionale del Veneto che non ha condiviso il voto a favore del gruppo dem sul suicidio medicalmente assistito, contribuendo alla bocciatura della proposta di legge di iniziativa popolare appoggiata dal governatore Zaia.
Ribadisce che era necessario prendere quella posizione, anche se le è costata l’allontanamento dal direttivo. Il segretario provinciale del Pd veronese, Franco Bonfante, l’ha destituita dall’incarico di vicesegretario perché «non si poteva far finta di nulla». Va bene «la libertà di voto» per motivi di coscienza, ha detto Bonfante, «ma chi la pratica deve essere consapevole delle conseguenze politiche, a maggior ragione se vi erano alternative». Ieri, in un’intervista all’Huffington Post, il segretario dem ha fatto sapere: «Se ho sbagliato su Bigon, mi dimetto. Ma me lo dirà il Pd, non Graziano Delrio».
Intanto, si è trattata di una sorta di purga staliniana che Bigon subisce, dopo essere stata accusata dalla segretaria del suo partito, Elly Schlein, di avere procurato una «ferita» al Pd. Avvocato specializzato in diritto di famiglia con studio a Villafranca di Verona, 55 anni, sposata, mamma di Angela, 26 anni e Mattia Edoardo di 20, vive a Povegliano Veronese dove è stata sindaco per dieci anni. Dal 2019 è consigliere regionale del Veneto, mentre la nomina a vicesegretario provinciale del Pd veronese era arrivata un anno fa.
Avvocato, l’hanno rimossa perché non in linea con il partito. Quella ferita dovrebbe essere lei.
«Prendo atto della decisione, vado avanti con le battaglie che ho sempre fatto. Sono nel Pd non per avere l’incarico di vicesegretario, ma per i principi e valori che lo statuto sancisce e che vorrei fossero riconosciuti. Non voglio parlare dell’amarezza, ma della soddisfazione per la tanta solidarietà che ho ricevuto: credo che buona parte del partito ritenga che abbia fatto bene a votare secondo coscienza».
Si è astenuta dal voto per quale motivo?
«Il progetto di legge prevedeva di uniformare tempi e procedure tra le varie Ulss, ma non si parlava di accesso alle cure palliative, che vanno potenziate, come afferma la stessa sentenza della Corte costituzionale. Invece è fondamentale, perché solo in questo modo si possono abbassare le richieste di suicidio assistito di persone con dolori inauditi, ma senza disponibilità economica per avere il sostegno totale e che non vogliono gravare sui loro familiari».
Come esperto in materia, ha anche sollevato un problema di competenze legislative.
«Certo, una legge sul fine vita deve essere nazionale, non regionale, in quanto va a incidere su una materia di competenza statale. C’è anche un parere a riguardo dell’avvocatura dello Stato. Inoltre, deve essere uniformata, altrimenti ci possiamo ritrovare con 20 leggi diverse. Se in Veneto bastano 20 giorni per accedere al suicidio assistito, dovremmo aspettarci arrivi da altre Regioni dove magari i tempi sono più lunghi. Una differenziazione di trattamento sul territorio impensabile».
I sostenitori della proposta dell’associazione Coscioni affermano che si trattava di approvare solo delle procedure.
«Allora perché una legge? Bastava un altro atto, erano sufficienti delibere sanitarie specifiche. Tutte domande che ho posto».
Alla fine ha preferito astenersi.
«Quando mi sono accorta che per la maggioranza del mio gruppo la linea era diversa, ho preferito agire in libertà di coscienza».
Le rimproverano di non aver scelto di uscire dall’aula.
«In quel caso, avrei ridotto il mio comportamento alla dimensione di pura testimonianza. Invece ho ritenuto opportuno esprimere il mio voto. Non è che possiamo avere libertà di pensiero solo quando il voto è ininfluente».
La battaglia a favore del suicidio medicalmente assistito è una battaglia ideologica?
«Credo che le battaglie debbano essere piene di contenuti. In questo caso, dovevano fare riferimento a cure palliative, alla presa in carico della persona che sente di essere in una situazione insostenibile. Altrimenti, certo si rischia di fare una battaglia ideologica».
Lei è cattolica?
«Sì. Ma la mia astensione non è stata solo per principio religioso. Le motivazioni sono quelle che ho illustrato sopra».
Come fa il Pd a sostenere l’eliminazione dei deboli, dei depressi, dei non più produttivi? In una «prospettiva della selezione artificiale dei più adatti al progresso della società», come dichiarava Alfredo Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro studi Livatino.
«Il Partito democratico è a favore delle persone, però bisogna prendere atto della sentenza della Corte costituzionale».
Un suicidio, tra l’altro a carico del sistema sanitario nazionale. In un mero calcolo di esigenze di bilancio, costerebbe meno del mantenere in vita la persona.
«I Lea, i livelli essenziali di assistenza, sono forniti a tutti i cittadini per garantire condizioni di uniformità su tutto il territorio, anche per questo serviva una legge nazionale».