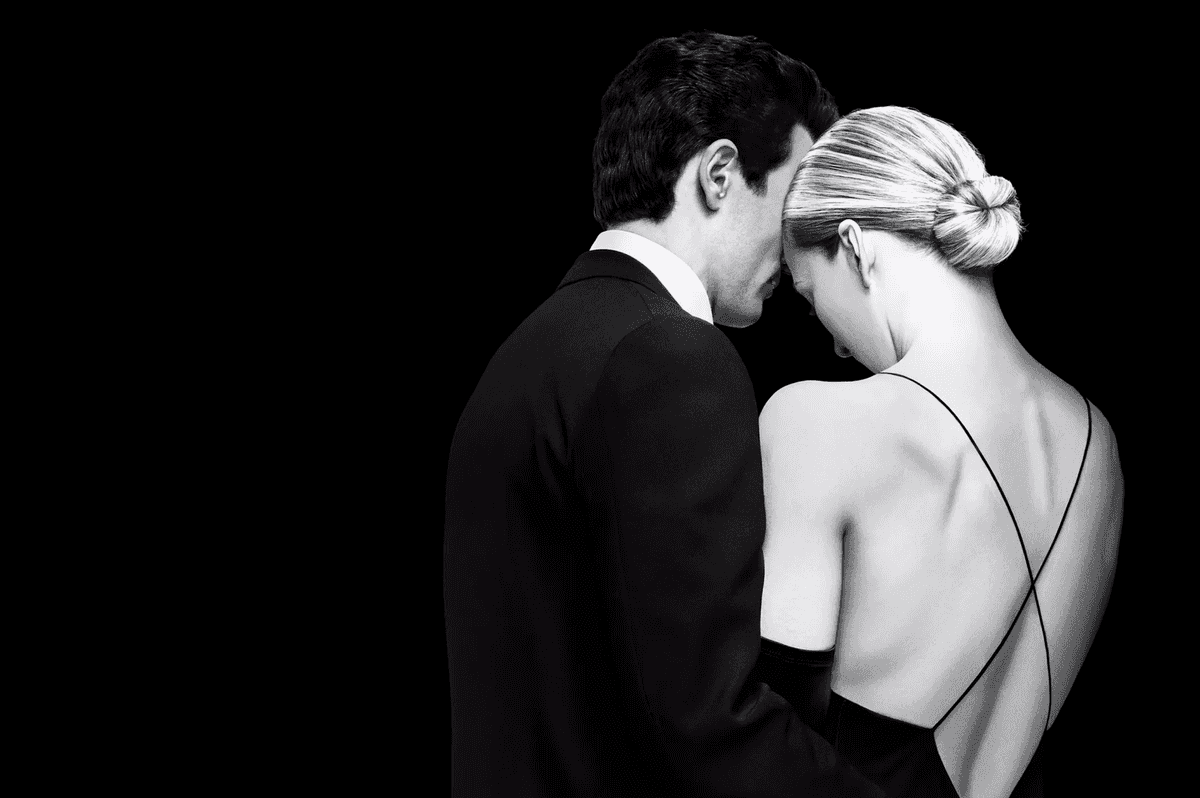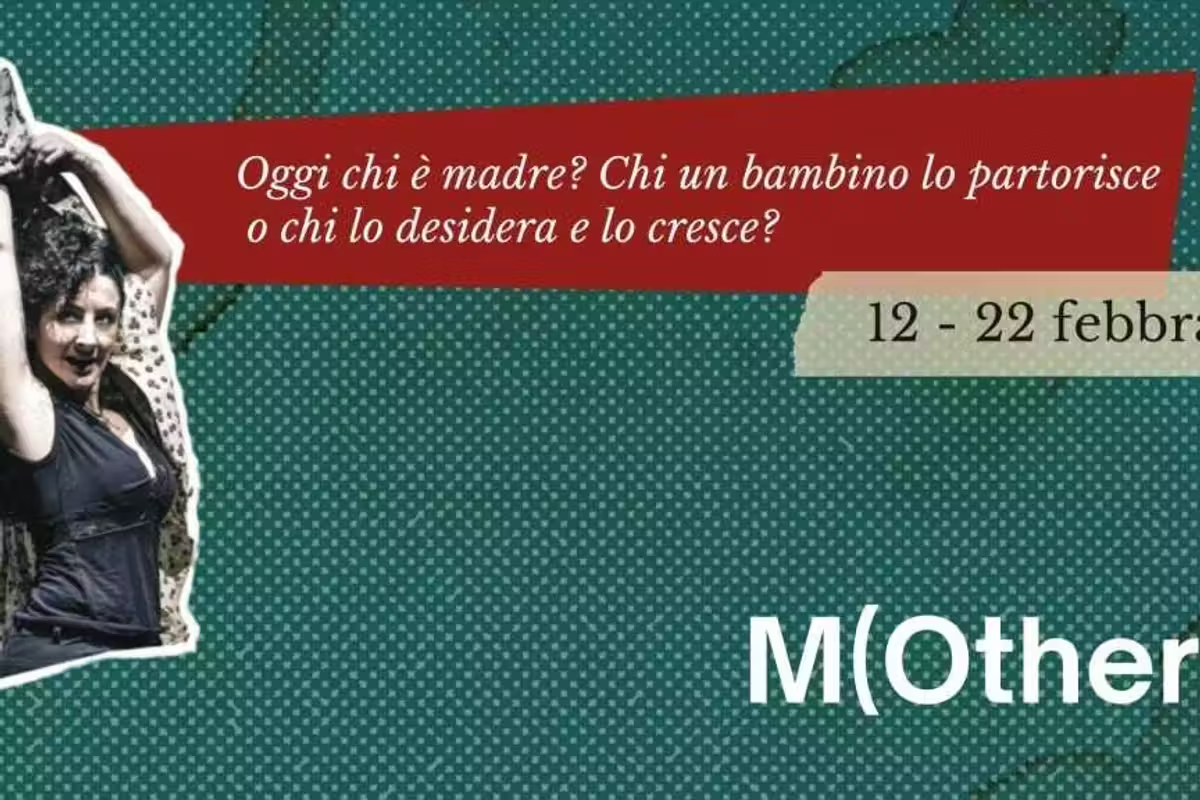L’Emilia di nuovo travolta dal fango. «Per 40 anni zero manutenzione»

Alle volte basterebbe, per capire il presente, conoscere un poco di storia del territorio. A Bologna via Riva Reno si chiama così perché lì si trovava, appunto, la riva del fiume Reno, le cui acque alimentavano tutti gli opifici circostanti. Nei primi anni del XX secolo - per motivi igienico sanitari - fu coperto il tratto fluviale tra via Nazario Sauro e via Galliera. Le operazioni di copertura proseguirono fino agli anni Cinquanta: nel 1956 davanti alla chiesa di Santa Maria della Visitazione fu posato il cemento. Nel giugno di quest’anno, il Comune di Bologna ha iniziato le operazioni di rimozione delle coperture per creare una sorta di naviglio in stile milanese. L’intervento è stato annunciato trionfalmente sui social ufficiali con una frase che riletta oggi fa impressione: «E acqua fu». Ebbene, acqua è stata. Dal cantiere aperto ieri è fuoriuscita una ondata rabbiosa di liquido marrone, che ha invaso tutte le zone circostanti, spargendosi per le vie (le quali hanno, guarda caso, nomi derivati dalla vicinanza al fiume: via della Grada, via delle Lame...). Bologna è stata sommersa, anche se il sindaco Matteo Lepore sostiene che la scopertura del canale in via Riva Reno abbia permesso addiritutra di ridurre i danni. Sarà pure, resta che il bilancio non è affatto dei migliori. Nel Paese di Pianoro, nella notte, un’onda di piena ha travolto l’auto su cui viaggiavano due ragazzi. Uno è riuscito a salvarsi ma il fratello, Simone Farinelli, appena ventenne, non ce l’ha fatta.
Sabato sera Lepore se la prendeva con il cielo ancora scuro: «Sono caduti circa 80 millimetri di pioggia in 4 ore. Stiamo parlando di una quantità molto superiore a quella del maggio dell’anno scorso, la situazione è seria, ma la stiamo gestendo. Dobbiamo resistere e ci dobbiamo organizzare, ma non uscite in strada non utilizzate l’automobile in nessuna zona di Bologna, se siete già in automobile e vi state muovendo, potete tornare a casa, ma ci sono una serie di zone che sono più critiche, come la zona collinare e le zone vicino ai torrenti e i fiumi».
Sabato era allerta rossa ovunque, soprattutto nelle zone già colpite da alluvione l’anno scorso e di nuovo a settembre. Nel Bolognese e in Romagna, in particolare a Ravenna e zone circostanti. La situazione, in effetti, era decisamente critica. Ma che le istituzioni la stessero gestendo, beh, purtroppo non corrisponde a realtà: l’hanno subita, come sempre, scaricando sulla popolazione la responsabilità di non mettersi in pericolo.
Ieri mattina il quotidiano locale Bologna Today contava «8 fiumi sopra il livello 3, la soglia rossa di massima allerta. In totale sono ben 15 i corsi d’acqua che durante l’evento hanno superato la soglia di allarme. Si sono registrate piene ai massimi storici su Samoggia, Idice, Sillaro e Senio. Alcuni fiumi hanno fatto registrare livelli superiori a quelli del maggio 2023, come l’Idice a Castenaso e il Samoggia a Forcelli». Il quadro è drammatico: l’acqua stavolta ha coperto anche l’Emilia, i fiumi hanno tracimato a Reggio Emilia e provincia, dove il Crostolo ha rotto gli argini e un migliaio di persone hanno dovuto lasciare le proprie case a Cadelbosco (gli sfollati sono circa 3.000 in tutta la regione).
Irene Priolo, la presidente facente funzioni della Regione, ha avuto la reazione che fino a oggi ha caratterizzato tutti i politici locali: ha dato la colpa alla pioggia in eccesso. «La città di Bologna è l’esemplificazione dell’evento che si è scaricato in collina», ha detto commentando la situazione del fiume Ravone, «con l’indice di saturazione dei suoli dovuto all’evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d’acqua. Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti».
E sarà anche vero che piove tanto, tantissimo. Negli ultimi giorni il cielo ha martellato, e la terra annaspava, annegava. Il fatto, però, è che limitarsi a inveire contro le nuvole non è più accettabile. I cittadini, a prescindere dall’orientamento politico, sono spaventati e stanchi di scuse. Sono sfiancati dal continuo rimpallo di responsabilità fra Regione, Comuni e la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Qualche giorno fa, il presidente della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, Marcovalerio Pozzato, ha frustato le strutture regionali, accusandole di scarsa tempestività nella realizzazione dei lavori necessari a rimettere in sicurezza i fiumi: «Mi dispiace dire che è stato impegnato molto poco, sotto il 10% delle somme a disposizione per gli interventi», ha dichiarato. La Priolo ha risposto furente: «Quanto fatto dalla Regione è noto: 852 interventi fra cantieri di somme urgenze, urgenze e programmazione di fondi regionali, per 747,5 milioni di euro», ha scritto in una nota ufficiale, definendo «anomale e irrituali le esternazioni» del presidente.
Chi ha ragione? E poi: è davvero così importante dove questa ragione stia? Forse no. Forse davvero sarebbe ora di farla finita con gli scambi di accuse, di imporre una moratoria alle polemiche e procedere il prima possibile con le opere necessarie per evitare che altra gente perda la casa. O la vita.
Che i fiumi non siano stati adeguatamente puliti sembra una certezza: il Ravone non viene pulito da maggio del 2023, ed è ovvio anche ai profani che i detriti delle precedenti alluvioni non possano non aver lasciato un segno. Il punto, però, è che allo stato attuale le toppe - per quanto tempestive - non sono più sufficienti. È l’intero sistema che va ripensato.
È quello che sostiene da tempo il geologo Claudio Miccoli, per lunghi anni dipendente della Regione e da un po’ di tempo emerso come una delle principali voci critiche (tanto che gli ex datori di lavoro, mesi fa, lo hanno anche diffidato dal rilasciare dichiarazioni). «Ho lavorato per la Regione come geologo fino a 31 marzo 2021, ero il responsabile dell’area Reno Po e di Volano, che comprende la provincia di Bologna, la provincia di Ferrara e quasi i due terzi della provincia di Ravenna», ci dice. «Bisogna considerare il fatto che quando un sistema subisce i danni che ha subito nel maggio 2023 è ovvio che sia indebolito. Allora ci furono due alluvioni: una il 2 e il 3 di maggio che ha avuto come punto centrale la rotta del Lamone e quella del Sillaro. Poi il 17, 18, 19 maggio ce n’è stata un’altra con ulteriori 23 rotte. La Regione ha detto che il problema era la pioggia straordinaria. Vero: sono piogge importantissime, gravissime, ma che non possono essere additate come l’unico elemento che ha prodotto questa situazione».
Dove nasce, allora, il problema? «Questa situazione si è prodotta nel tempo perché la Regione da 40 anni ha lo stesso paradigma di difesa del suolo e non si resa conto che invece l’ambiente, il territorio, andava da un’altra parte. Finché non siamo arrivati al redde rationem nel maggio dell’anno scorso e nel settembre di quest’anno. Bisogna rendersi conto che i cambiamenti climatici fanno piovere in modo diverso, che le manutenzioni diventano fondamentali e che si deve smettere di vincolare a bosco e a zone Sic e Zps i fiumi, dove l’acqua deve invece transitare. I fiumi sono stati fatti per trasportare in sicurezza l’acqua, non per fare dei boschi».
Secondo Miccoli, «quando succede un disastro ci sono una serie di concause, di cui una - forse quelle maggiore - la pioggia così abbondante. Ma ci sono concause che sono colpa dell’uomo e che, se affrontate, avrebbero permesso o di evitare il problema o, quantomeno, di minimizzarne gli effetti. Ad esempio non si è fatto un progetto ad hoc per tutti i paesi frontalieri del fiume. Quando un fiume passa in mezzo a un paese è chiaro che il rischio potenziale si alza, e puoi tranquillamente avere dei morti. L’ultima rotta, quella di settembre, a Traversara a Ravenna, è stata emblematica: era una zona già segnalata come a rischio dal 2011 e ancora nel 2015. Ma i lavori non sono stati fatti, è stato ritenuto più importante farli da un’altra parte. Poi c’è stata la rotta, è successo un disastro in paese. Allora si è fatto un intervento ed è arrivata un’altra pienotta, una piena che noi definivamo ordinaria: l’opera di difesa è stata aggirata e non c’era nessuno a controllare, nonostante fosse stata emessa un’ordinanza, un’allerta rossa. Cose del genere non possono essere imputare alla natura o alle piogge».
A quanto pare, i problemi sono numerosi e complessi. In primo luogo il fatto «che la struttura regionale non è più in grado di gestire la situazione», sospira Miccoli. «L’hanno talmente sgonfiata dal punto di vista tecnico, poi hanno fatto confluire la difesa del suolo nell’agenzia di Protezione civile. Solo che la Protezione civile ha una filosofia di intervento ex post, mentre la difesa del suolo è un intervento preventivo. Bisogna cambiare il paradigma: le piene si formano in montagna, dove ormai è saltato per aria il banco. Lì negli ultimi 40 anni non si è fatta manutenzione, i privati sono andati via ed è venuta a mancare la loro micromanutenzione, che grazie alla presenza di tante persone diventava una macromanutenzione. Il pubblico non solo non ha surrogato a questo, ma non ha fatto neanche la sua parte e quindi alla fine è successo il disastro. Nessuno ha dice che il problema è solo la mancata manutenzione, c’è un problema generale diviso in tante parti: la pioggia, la manutenzione, le opere, le infrastrutture non fatte e così via... È venuto il momento di andare oltre, perché se ci limitiamo a ricostruire quello che c’era prima e torna una pioggia come quella di questi giorni, si fa il disastro un’altra volta». È esattamente ciò di cui tutti, qui, hanno timore: il disastro un’altra volta. Anche perché le volte, ormai, cominciano a essere troppe.