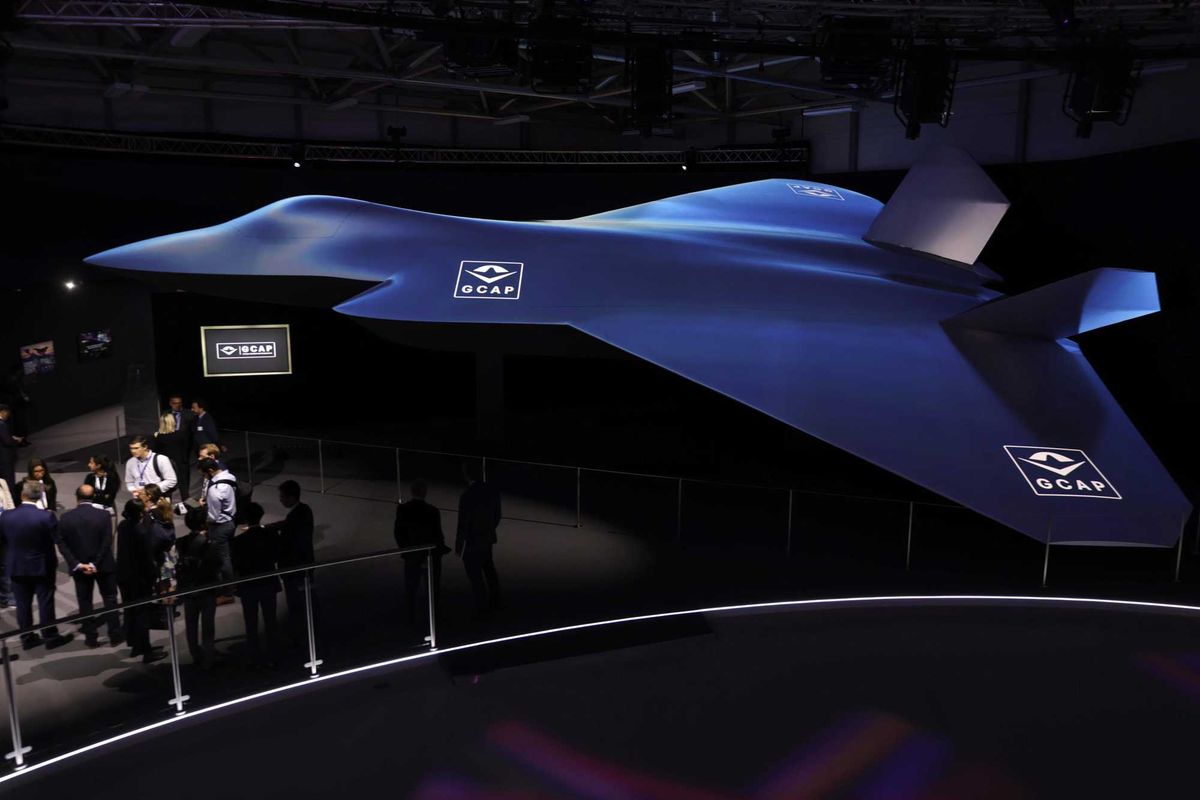Se n’è andato il nostro Aldo Forbice. Ecco l’ultimo articolo per «La Verità»

«È bastato uno spot televisivo per far emergere dall'oblio una meritoria iniziativa dello Stato contro la criminalità mafiosa». Per decenni però nessuno ci aveva pensato. A riassumere questo impegno pubblico è il prefetto Giovanna Stefania Cagliostro, calabrese, e super appassionata dell'incarico che assolve da sei mesi: quello di Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. È stata questa donna, superesperta di amministrazione pubblica (a giudicare dal suo nutrito curriculum), a pensare di far sapere, attraverso uno spot tv, che lo Stato è da sempre attivamente vicino alle vittime del racket e dell'usura.
Non soltanto, con le forze dell'ordine e la magistratura, ma anche con la concreta solidarietà economica con chi subisce gravi danni in conseguenza dei ricatti della criminalità organizzata. Sono trascorsi ormai più di trent'anni dalla prima costituzione di un'associazione antiracket, cioè di imprenditori che, spontaneamente, dopo i troppi delitti e violenze visti e subiti, si sono coraggiosamente ribellati alla criminalità. «È stato necessario», ha ricordato di recente il ministro Luciana Lamorgese, «ridare fiducia ai cittadini e alle imprese, con una chiara scelta di legalità, chiedendo loro di rifiutare il ricorso al credito illegale». Questo significa, osserva il prefetto Cagliostro, sollecitare sempre di più una stretta collaborazione dei cittadini per continuare a rompere «quel muro di omertà che è ancora presente in settori della società civile che, non denunciando, finiscono, nei fatti, contigui ed assuefatti ai quotidiani comportamenti di sopraffazione, corruzione e intimidazione». Ma, per raggiungere questi risultati, è necessario non lasciare le famiglie, i cittadini isolati dalle istituzioni. Abbiamo ben presenti tante vittime della criminalità, uomini simbolo della lotta alla mafia e alla camorra. Ne ricordiamo due: il siciliano Libero Grassi, imprenditore tessile, ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991, e Domenico Noviello, imprenditore di Castel Volturno, assassinato dalla camorra il 16 maggio 2008. Insieme a questi eroi civili ricordiamo anche un caso recente, quello di un imprenditore catanese, noto per essere l'uomo dei torroncini, Giuseppe Condorelli, che si è rifiutato di pagare il «pizzo», facendo arrestare più di quaranta mafiosi. Dai crimini di alcuni decenni fa la società civile reagisce ora in modo più coraggioso. Non a caso in questi anni sono sorte numerose associazioni antiracket e antiusura, prevalentemente nel Mezzogiorno. Ne abbiamo contate ben 114 (di cui 88 nel Mezzogiorno, 21 nel Centro e 5 nel Nord), ma probabilmente sono ancora di più. «Probabilmente sì, ma non tutte riescono a operare con continuità», ci risponde la commissaria. «Dovrebbero infatti sostenere sempre le vittime del racket, accompagnarli per riprendere il loro lavoro. Ma non sempre questo è possibile perché si tratta di un impegno difficile, richiede molta esperienza e una continuità costante nelle iniziative umanitarie». Aggiunge il prefetto: «Riscontriamo di frequente nelle associazioni, soprattutto in quelle del Nord, la difficoltà ad organizzarsi nel fronteggiare la criminalità, probabilmente perché hanno meno esperienza di quelle del Sud, anche se i reati di cui parliamo non sono più rari in Veneto, Lombardia, Piemonte Liguria ed Emilia Romagna».
Ma quanti sono i casi di racket e di usura? «Questo è più difficile conoscerlo esattamente perché molti per paura non denunciano i reati». Ormai conosciamo bene la natura di questi reati. Ad esempio, possiamo distinguere quattro tipi di estorsione di stampo mafioso:
1 Il cosiddetto pagamento del pizzo «concordato». Viene stabilita cioè all'inizio una cifra e poi si contrattano rate mensili in base al giro d'affari dell'attività dell'azienda.
2 Un «contributo all'organizzazione»: periodicamente due o più persone si presentano per chiedere un «pizzo», quasi sempre in occasione di qualche ricorrenza (la cifra è sempre di notevole entità) .
3 «Cavallo di ritorno». È un termine mafioso per indicare la restituzione di un'auto, un trattore o altri attrezzi agricoli, dopo averli preventivamente rubati, chiedendo il pagamento di una tangente.
4 Contributo in natura. La cosca o «famiglia mafiosa» chiede alla vittima prescelta prestazioni gratuite (in occasione di matrimoni, battesimi, feste di compleanni, ecc.).
Inoltre, secondo alcune sentenze della Cassazione, il reato di estorsione si può configurare anche mediante l'esercizio di azioni legali pretestuosi. Per questo reato è prevista una reclusione da cinque a dieci anni.
Come si è detto, è difficile quantificare con precisione i casi di estorsioni e di usura per la diffusa paura delle vittime, anche perché, come è noto, esistono ancora molte aree del Paese in cui sono pochissimi a ribellarsi, spesso preferiscono chiudere la propria attività professionale ed emigrare. Lo conferma anche la commissaria Cagliostro. «È questo un terreno minato, le prefetture devono agire in modo diplomatico, senza urtare suscettibilità e alimentare ancora di più il timore di subire attentati o danneggiamenti alle proprietà personali ed aziendali (case, auto, terreni, ecc.). C'è poi la questione dei mutui, un sistema che andrebbe tutto riformato. Il prestito agevolato spesso arriva troppo tardi, quando gli imprenditori vittime non sono più in grado di rimettersi al lavoro a pieno regime».
La commissaria precedente (il prefetto Annapaola Porzio) aveva infatti ipotizzato contributi a fondo perduto per venire incontro in tempi più ravvicinati alle vittime, tenendo conto che - secondo i dati raccolti - gli imprenditori «massacrati «dagli usurai non riescono a restituire più del 20 per cento delle somme ricevute alle banche (che sono comunque garantite dai ministeri di competenza). La situazione adesso si è ancora più aggravata, con la perdurante emergenza Covid. Non esistono ancora bilanci sull'incidenza dei reati di estorsioni e usura, ma - ci dice il prefetto - «i segnali che abbiamo percepito dalle prefetture sono allarmanti». Questo significa che lo Stato, attraverso i suoi strumenti (il Commissariato antiusura e antiracket del ministero dell'Interno e il Fondo per la prevenzione dell'usura del ministero dell'Economia) dovrà predisporre fondi adeguati per fronteggiare la nuova emergenza. Non basterà infatti l'incremento del Fondo di solidarietà del Mef di oltre 24 milioni di euro, deciso l'anno scorso. Sarà necessario infatti aumentare i contributi annuali agli enti impegnati nella prevenzione dell'usura (77 Confidi, consorzi di piccole e medie imprese e 36 associazioni e fondazioni) che stanno in questi giorni ricevendo contributi, compresi tra 280.000 euro e 600.000 euro. Questo Fondo (operativo dal 1998), alimentato dalle sanzioni antiriciclaggio e valutario, è stato rifinanziato con altri 10 milioni di euro, raggiungendo un importo complessivo di 32,7 milioni di euro. Un altro canale di finanziamento, com'è noto, viene dal Commissariato antiracket e antiusura, che ha assegnato nel 2020, 23.210.000 euro (19.689.000 per compensare le estorsioni e oltre 3.520.000 per l'usura). Il commissario ci ha anche comunicato una cifra inedita di finanziamenti: al 5 maggio risultavano già deliberati 4 milioni di euro, relativi ai primi quattro mesi 2021. «Il problema però», sottolinea il prefetto Cagliostro, «è che appare sempre più urgente la riforma dell'intero sistema pubblico antiracket e antiusura, non solo per accorciare i tempi delle istruttorie per la concessione dei mutui e degli altri contributi». Su questo tema è in fase di completamento una ricerca dell'Università Bocconi, i cui risultati saranno utilizzati per la prossima riforma dell'intero sistema. Una cosa però appare ormai acclarata: «Non sono più accettabili i tempi lunghi delle istruttorie; gli imprenditori vittime di estorsioni o dell'usura non possono cioè attendere due-tre anni, come avviene oggi, per accedere ai fondi pubblici». Purtroppo sono proprio questi ostacoli, che non è stato possibile superare per chiare responsabilità politiche, che hanno provocato, anche in anni recenti, tragedie note, come il suicidio di molti imprenditori o di loro parenti. Ora, fra le tante innovazioni in programma, vi è in fase di realizzazione, una nuova piattaforma informatica (si spera entro quest'anno) che taglierà sensibilmente i tempi di erogazione dei contributi. Fra le altre, vi è però una domanda che non trova ancora una risposta, anche in vista del Recovery fund (che dovrà razionalizzare anche questo settore, nel quadro del potenziamento della lotta alla criminalità): perché non pensare a unificare gli strumenti di intervento, attualmente separati (ed anche competitivi), tra il ministero dell'Interno e quello dell'Economia ?