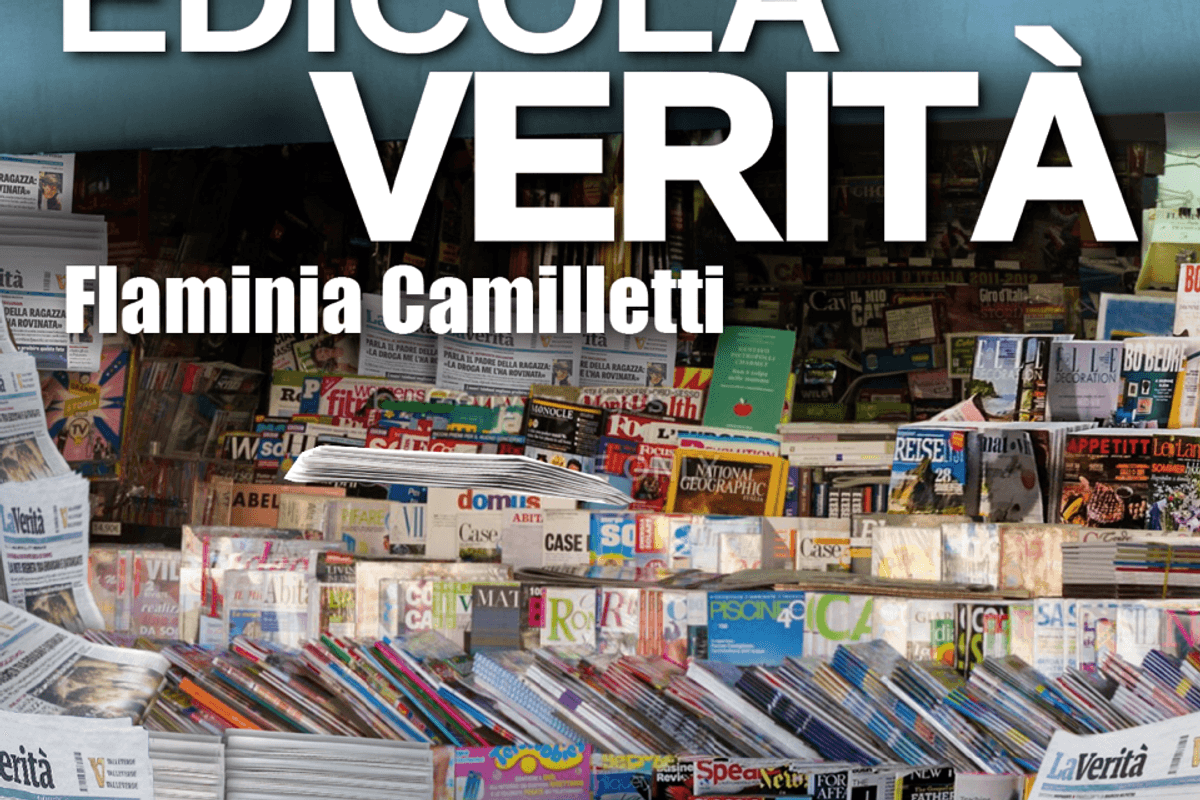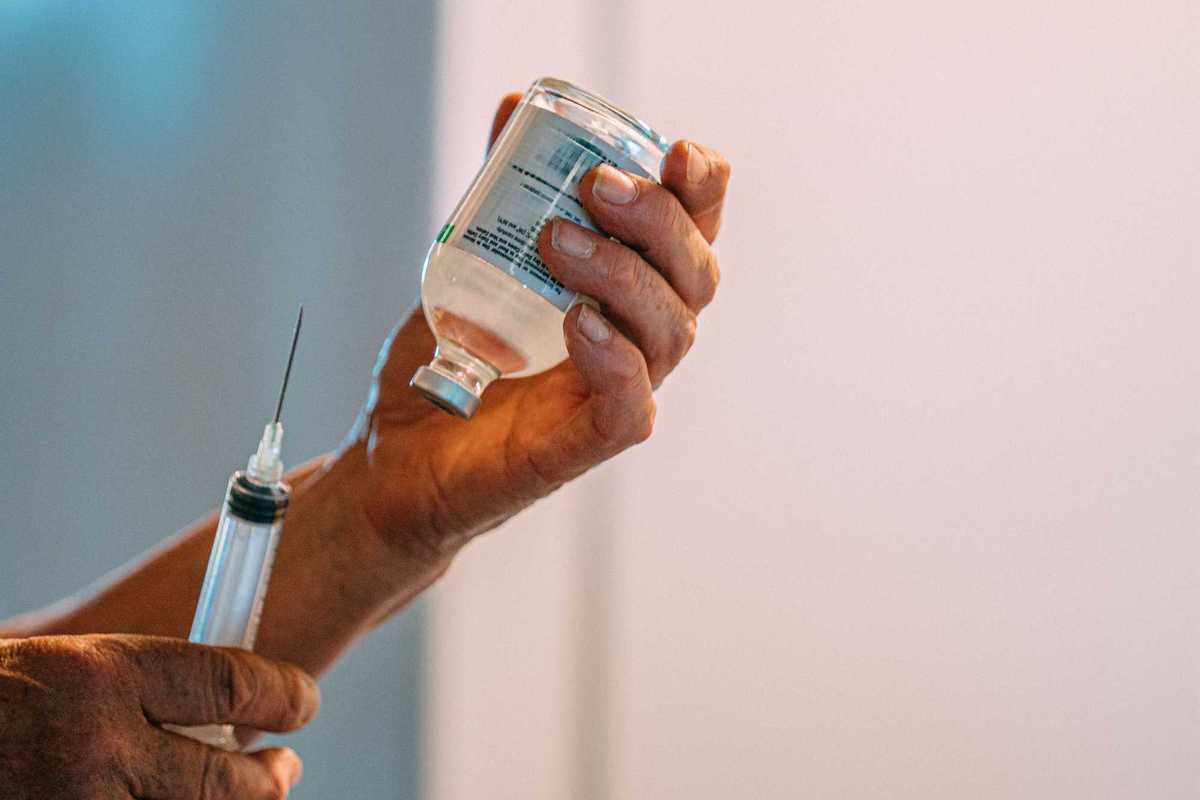L'antenato è il celeberrimo «Ah! Anche poeta…!» che Anna Mazzamauro, nei panni della signorina Silvani, diceva a Paolo Villaggio, in quelli del ragionier Ugo Fantozzi, dopo che costui aveva spacciato per suoi, definendoli «una cosetta giovanile», i versi appena modificati della Canzona di Bacco di Lorenzo de' Medici «Chi vuol esser lieto sia / che tanto domani... non c'è certezza!». Poi, è diventato di moda postare sui social network l'annotazione che si era «Oggi tutti virologi», «Oggi tutti epidemiologi», «Oggi tutti economisti», «Oggi tutti esperti di terrorismo internazionale» e così via. Al di là della capacità poetica di Ugo Fantozzi o della tendenza di Facebook & co. a trasformare tutti in tuttologi, cioè in nientologi, esistono figure con una vera competenza eclettica: monaci e monache.
Come spiegano Laurence & Gilles Laurendon nel bel volume Ricette e segreti dei monasteri. Orto, cucina, erbe, dolci, confetture, liquori & elisir (Guido Tommasi editore), «al riparo dei monasteri, durante i secoli, uomini e donne hanno elaborato un'arte di vivere unica. Chiusi nella solitudine interiore, condividendo la vita quotidiana della comunità, hanno inventato una diversa scansione del tempo. Hanno creato una cucina che rispecchia la loro vita semplice, gustosa, equilibrata e che coniuga qualità che ci parlano del mondo di oggi: colture basate su processi naturali, freschezza dei prodotti, preparazioni prive di artifici… Monaci e monache di clausura sono stati tra i primi ad abbinare verdure e salute, avendo una conoscenza straordinaria delle piante medicinali; hanno messo in atto e poi sviluppato un'agricoltura e una cucina che rispettano le stagioni e i ritmi della natura. Di volta in volta dissodatori, contadini, giardinieri, cuochi, apicoltori, mugnai, vivaisti, casari, pasticceri, viticoltori, distillatori… i monaci di clausura ci hanno lasciato un autentico patrimonio culinario». Il motivo di questa esistenza poliedrica è presto detto: il monastero doveva essere autosufficiente e quindi occorreva saper realizzare tutto ciò che serviva.
La parola «monastero» deriva dal latino tardo monasterium, a sua volta derivante dal greco antico monasterion, da monastés (monaco) e monakós (solitario, eremita) a sua volta da monos (solo, unico). Il monastero cristiano è l'edificio nel quale vive la comunità di monaci e monache sotto l'autorità dell'abate o della badessa, può non costituire un ordine religioso ma essere una comunità a parte e in questo differisce dal convento, che dal punto di vista architettonico non è molto diverso, ma da quello amministrativo sì: fu introdotto con l'avvento degli ordini mendicanti e ospita frati e suore. Particolare tipo di monastero è poi l'abbazia, che per il diritto canonico è un ente autonomo. Monastero, convento e abbazia hanno in comune di essere stati fin dai loro esordi, quando ancora lo Stato in senso contemporaneo non esisteva, delle microcittà che svolgevano importantissime funzioni sociali, anche per chi non vi apparteneva e ne viveva al di fuori.
L'autonomia monasteriale era stata stabilita anche dalla Regula monachorum, cioè la Regola dell'Ordine di San Benedetto. Dettata dal santo nel 534 per organizzare la vita monastica dei suoi seguaci, spiegava che «il monastero dev'essere organizzato in modo che al suo interno si trovi tutto l'occorrente, ossia l'acqua, il mulino, l'orto e i vari laboratori, per togliere ai monaci ogni necessità di girellare fuori, il che non giova affatto alle loro anime». Il monastero di Santa Scolastica a Subiaco, fondato nel 520 da San Benedetto, è il più antico monastero benedettino d'Italia e del mondo, uno dei 12 monasteri voluti nella valle sublacense e l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene. Anche l'abbazia di Montecassino è un monastero benedettino ed è quasi altrettanto antica, essendo stata fondata dal santo nel 529. Qui fu pensata e poi messa nero su bianco, nel 534, la Regola che, diffusasi grazie al sostegno del Papa, fu adottata in molti altri monasteri europei.
Quando oggi si parla di società a rifiuti zero, di medicina naturale, di semivegetarianesimo (chi si esprime più in inglese che in italiano lo chiama flexitarianesimo), pescetarianesimo (vegetariani che però mangiano pesce), pesco-veganesimo (vegani che però mangiano pesce) e anche veganesimo e vegetarianesimo, di do it yourself, di slowcooking, di allevamento sostenibile, di importanza della cultura, di memoria, soprattutto in area progressista, si dovrebbe avere l'onestà intellettuale di affermare che tutte queste idee non sono affatto di primo e di proprio pelo, essendo già state pensate e soprattutto realizzate nei monasteri.
Piccole città nelle future città, intorno al nucleo centrale con il dormitorio, la chiesa e la torre campanaria, fabbricati per la vita monastica, i monasteri presentavano una serie di locali topici. Per esempio, la biblioteca e lo scriptorium dove, soprattutto nei monasteri benedettini e cistercensi, la cultura classica, dopo la caduta dell'impero romano d'occidente, in epoca medioevale è stata tramandata al futuro trascrivendola, anche nei codici miniati. A volte, il monastero svolgeva una funzione di inconsapevole futuro museo: nell'abbazia di Montecassino, con altre 20.000 preziose pergamene, è conservato il noto Placito capuano del marzo 960, la prima testimonianza scritta della lingua italiana volgare (ovvero quando il latino trascolorava nell'italiano attuale): all'interno di una sentenza interamente redatta in latino è trascritta la testimonianza - sul diritto di usucapione dei monaci sull'abbazia - in volgare, parlato ma mai trascritto prima di allora su un documento amministrativo: «Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti».
Il monastero sembra davvero un prototipo di contemporaneità. Tavolo sociale di alcuni locali hipster? Nel monastero c'era il refettorio, si mangiava uno accanto all'altro e via… non col tango, ma col pasto. Hotel diffuso, scambio casa, airbnb e tutte le forme odierne di «turismo informale» alternativo all'albergo vero e proprio? Il monastero aveva la foresteria e l'ostello per i pellegrini - oggi molti monasteri, conventi e abbazie vi ospitano turisti, non importa che siano credenti, a pagamento - e poi gli alloggi per i conversi, cioè i fratelli laici. Cooperative di accoglienza? Il monastero aveva le «porte della carità». Potere delle erbe in cosmesi e medicina naturali? Chiunque, in confronto alle produzioni dei monaci in questi campi, può sembrare un dilettante. Orto in casa? Il monastero aveva il giardino dei semplici, terreno adibito alla coltivazione di erbe e piante officinali (appunto dette «semplici»). Ospedale? Il monastero aveva l'infermeria. E poi i fabbricati, locali facenti parte della costellazione monasteriale detti «fabbricerie» dove, appunto, si fabbricava l'autosostentamento: la fattoria con pollai, stalle e scuderie, il mulino, il granaio, l'azienda agricola, la dispensa, la cucina, la sartoria, il forno, il panificio, la lavanderia e, in generale, qualsiasi altro laboratorio per produrre o riparare cose.
Solitamente costruito vicino a un corso d'acqua, il complesso monastico sfruttava la fonte idrica direzionandola verso i locali che ne avevano bisogno, ma anche come fonte per l'acquacoltura. Spesso, infatti, il monastero affiancava all'allevamento di bestiame quello ittico, come fonte proteica animale per i «giorni di magro» della quaresima e del resto dell'anno sacro: se oggi la carpa è un pesce stabilmente presente nella fauna ittica europea, si deve anche al perfezionamento della specie attuato nelle vasche di allevamento monasteriale. Nei monasteri, grazie a monache e monaci, sono nati prodotti alimentari per noi ormai familiari. Efficienti e pazienti casari, spiega il sito Internet del Parmigiano reggiano che «nel Medioevo i monaci cistercensi e benedettini, spinti dalla ricerca di un formaggio in grado di durare nel tempo, furono i primi produttori» di quello che poi sarebbe stato chiamato Parmigiano reggiano «grazie al sale proveniente dalle saline di Salsomaggiore e al latte delle vacche allevate nelle grangie, le aziende agricole dei monasteri, ottennero un formaggio dalla pasta asciutta e dalle grandi forme, adatto alle lunghe conservazioni».
Nel libro L'Europa a tavola (Arnoldo Mondadori editore) Léo Moulin spiega che i conventi erano detentori di grandi tradizioni culinarie: «Il fatto è meno paradossale di quanto possa sembrare» perché «i monaci, costretti a una dieta rigida e a una vita monotona, impiegavano volentieri il loro tempo a perfezionare le tecniche di preparazione di quei pochi prodotti che erano loro permessi» e «si concedevano qualche golosità in occasione della celebrazione di feste religiose come la Pasqua, il Natale o il giorno del santo patrono». Oltre ai formaggi e ai latticini, anche alternativi, per esempio il latte di mandorla, come abbiamo visto sulla Verità dello scorso 1° marzo, nei monasteri si producevano birra (per un lungo periodo ebbero il monopolio), vino, anche aromatizzato, alcolici come grappe, acquaviti e altri liquori, dolciumi.
Il monastero non soltanto illumina il nostro presente, spiegandoci l'origine di molte cose. Estremamente attuale e norma alla quale ispirarsi appare il salubre rapporto con il cibo. Nella Regola si indicano la quantità e la qualità della nutrizione: due pasti al giorno durante i quali si consumano due piatti di cibo cotto ciascuno, più legumi e verdure, poi una libbra (circa 450 grammi) di pane e una hemina (un'antica unità di misura romana pari a circa un quarto di litro) di vino per ciascun monaco. La carne «di quadrupedi» è proibita a tutti, tranne che ai malati e a chi è debilitato fisicamente. L'abate può aumentare le porzioni quotidiane, se lo reputa necessario. Il Capitolo XLI prescrive l'orario per i pasti, che varia in funzione delle stagioni. Sommate alle altre citate in precedenza, in primo luogo la stagionalità dei prodotti e la semplicità delle preparazioni, si tratta di regole di igiene alimentare alle quali possiamo ispirarci per mangiare meno, ma meglio in questo periodo di quaresima e in generale.
I monaci ci ricordano anche che cucinare vuol dire nutrire il corpo ma anche lo spirito. Dimentichiamo per un momento la concezione della cucina come performance perfezionista da cooking tv show e ricordiamoci di quella monastica, ispirandoci - anche fuori dal discorso alimentare, riferendoci a un equilibrio generale - a quanto San Benedetto, nella Regola, consiglia per la scelta del cellerario, cioè il soprintendente alla cantina e alla dispensa del monastero: «Si scelga un fratello saggio, maturo, sobrio, che non ecceda nel mangiare e non abbia un carattere superbo, turbolento, facile alle male parole, indolente e prodigo, ma sia timorato di Dio e un vero padre per la comunità».