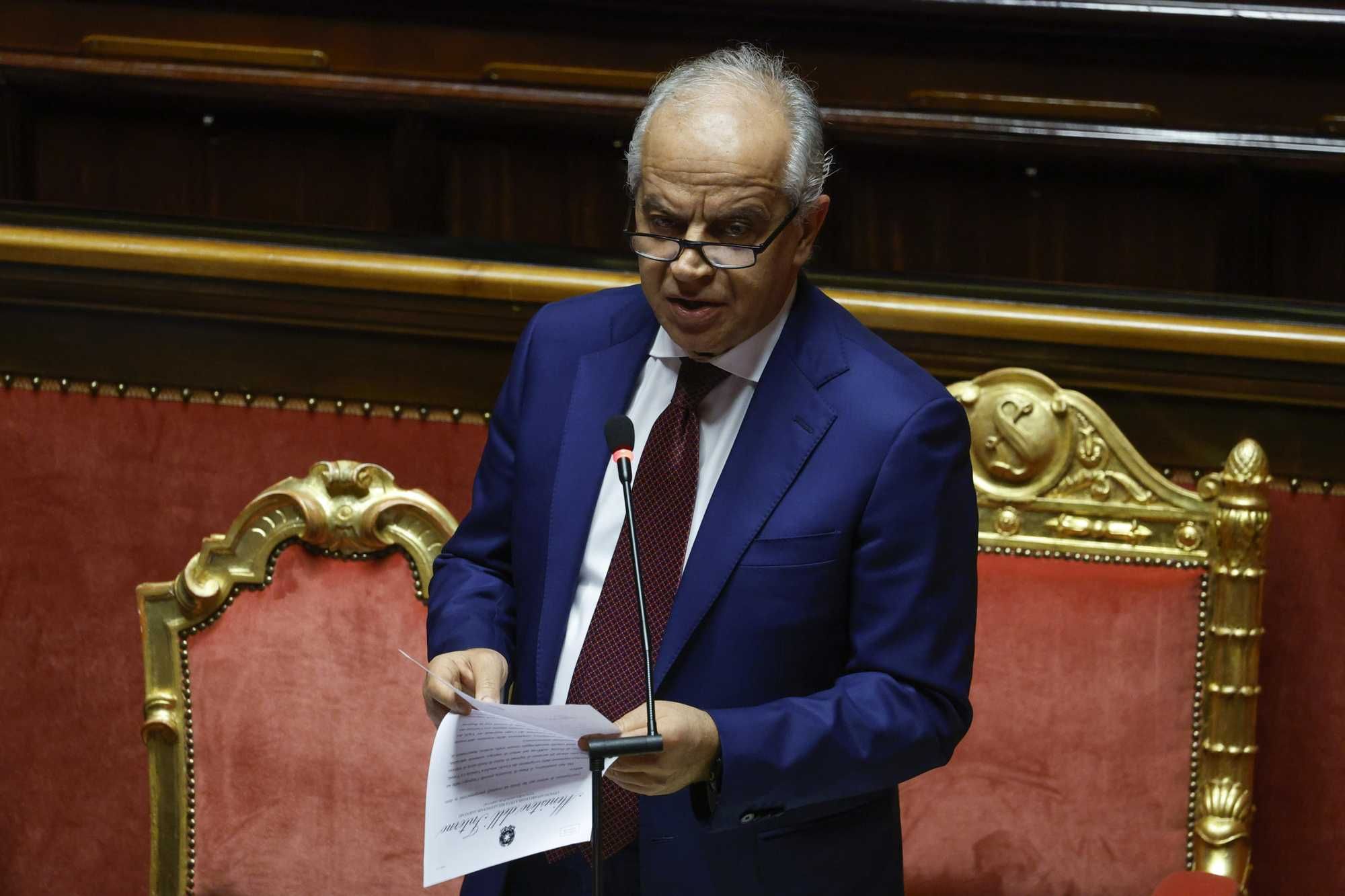Il meccanismo, ormai, è collaudato: per far accettare le infinite contraddizioni della convivenza forzata tra popoli e culture, non c'è niente di meglio che una «narrazione» edificante, una «storia che commuove il web» o anche semplicemente un bel raccontino pieno di speranza, reso inoffensivo dalla retorica, ma con la propaganda piazzata al punto giusto.
Accade così che la normalizzazione nelle nostre città del velo islamico, che stride visibilmente con la sensibilità della nostra cultura, anche e soprattutto con quel femminismo che pure, per altri versi, oggi sembrerebbe dominante, proceda esattamente nel modo descritto. Sull'edizione bolognese del Corriere della Sera, per esempio, abbiamo potuto scoprire che a nella città felsinea sta per aprire «Hijab paradise», negozio monotematico la cui specialità è didascalicamente riassunta nel nome dell'esercizio. Ad aprirlo, Keltoum Kamal Idrissi, 23 anni, referente della sezione femminile di Cesena dei Giovani musulmani.
Di origini marocchine, vive in Italia con la sua famiglia da quando frequentava la terza elementare. Ha tre sorelle, nessuna di loro indossa il velo. Il Corriere specifica che «lo porta la mamma che assieme al padre non l'hanno mai obbligata a portarlo». La giovane Keltoum, lo indossa, ma da poco tempo: «Io ho cominciato a metterlo tre anni fa, avevo da poco vent'anni e ho deciso di farlo perché credo nella mia religione. E poi la mia passione per la moda mi ha portato a immaginare un negozio mio che potesse vestire con stile le donne di fede musulmana». E già in questo modo di raccontare le cose c'è tutto un mondo: gli stessi ambienti che, nei mesi scorsi, hanno voluto farci credere che attrici milionarie fossero «costrette» ad andare a letto con ricchi produttori da invisibili coercizioni culturali, ora dipingono in modo idilliaco l'usanza del velo, ovviamente indossato senza obblighi, ci mancherebbe. Strano oggetto, il libero arbitrio femminile. Degna di nota anche la scelta di indossare il velo da parte di una giovane donna, cresciuta in Italia, da famiglia che pare non eccessivamente religiosa e quindi, si ipotizza, mediamente occidentalizzata. Eppure anche lei si vela. Perché? Per motivi religiosi. Eppure Bruno Nassim Aboudrar, nel suo saggio su Come il velo è diventato musulmano, ci ha spiegato che l'hijab è tutt'altro che centrale nei testi musulmani. Non è un fatto di religione, è un fatto politico.
Oggi, scrive Aboudrar, «ci sono donne - e penso in particolare alle musulmane occidentali - che appaiono distanti anni luce da questi estremismi reazionari, e nonostante ciò considerano il velo come un segno distintivo necessario (e magari sufficiente) per dimostrare la loro appartenenza all'islam». Si tratta, quindi, di una rivendicazione comunitaria. Ma andiamo avanti nell'esplorazione del fantastico mondo di «Hijab paradise», nome che peraltro meriterebbe una trattazione a sé. La giovane italomarocchina ci dice che sta mettendo su un presidio commerciale, ma soprattutto culturale, per le donne immigrate, ma attenzione: «Qualsiasi ragazza, non solo musulmana, e un po' curiosa potrebbe trovare qualche capo di suo interesse». Per anni l'Occidente si è illuso che bastasse far assaggiare un po' di diritti civili agli immigrati per farli diventare come noi.
La verità è che siamo noi a diventare progressivamente come loro. E qui viene in mente la famosa perla di Laura Boldrini secondo cui i migranti sarebbero l'avanguardia di uno stile di vita che un giorno sarà anche il nostro. Chi si integra con chi, quindi? Del resto, Keltoum ha le idee chiare: «Si parla sempre tanto di integrazione, ma secondo me è giusto parlare di inclusione». L'integrazione richiama alla mente uno sforzo in vista dell'accettazione nella società ospitante: per quanto si tratti di una visione irenistica e al fondo doppiamente sradicante, si parte se non altro dal presupposto che ci sia una differenza culturale che può «fare problema». «Inclusione», invece, significa prendersi tutto il pacchetto senza chiedere nulla in cambio: da un giorno all'altro «includi» nella tua società e nella tua cultura cose che fino a ieri vi erano escluse.
Ma, attenzione, non si tratta del famigerato «islam radicale». La fede c'è, ma è «moderata». Sul sito del negozio si legge: «La nostra fede è un punto fondamentale per offrirvi efficienza, professionalità e cortesia. La strada è ancora lunga, ma l'importante è correre su quella giusta, confidiamo nel vostro supporto dopo il supporto di Allah ta'ala, affinché ci mantenga salde sulla retta via a partire da uno stile d'abbigliamento conforme sia con la nostra fede che con l'ambiente che ci circonda». Inoltre, Keltoum ha deciso di non vendere il niqab o il burka, «non si sposa in nessun modo con la nostra filosofia». Per rendere accettabile qualcosa che fino a qualche anno fa non lo era, basta alzare l'asticella di ciò che potrebbe capitarci: state tranquilli, non è mica il cattivo burka, è solo il buon hijab.
Ma il vero colpo di genio arriva nel finale. «Crescendo a Cesena, lavorando a Bologna», spiega la giovane, «noi siamo parte della cittadinanza, anche se non l'abbiamo. E anche se mi sono arrabbiata tanto per non essere potuta andare a votare alle politiche. Ci avevo creduto allo ius culturae, ma così non è stato». Politici italiani bestie, avete distrutto il sogno di Keltoum, che voleva votare alle elezioni e partecipare alla nostra vita democratica. Ecco quindi che alla fine è la società italiana che finisce nella posizione di chi deve dare delle spiegazioni. Siamo noi a non essere alla loro altezza. Ma forse, un giorno, sforzandoci molto, anche gli italiani riusciranno a integrarsi con gli africani.