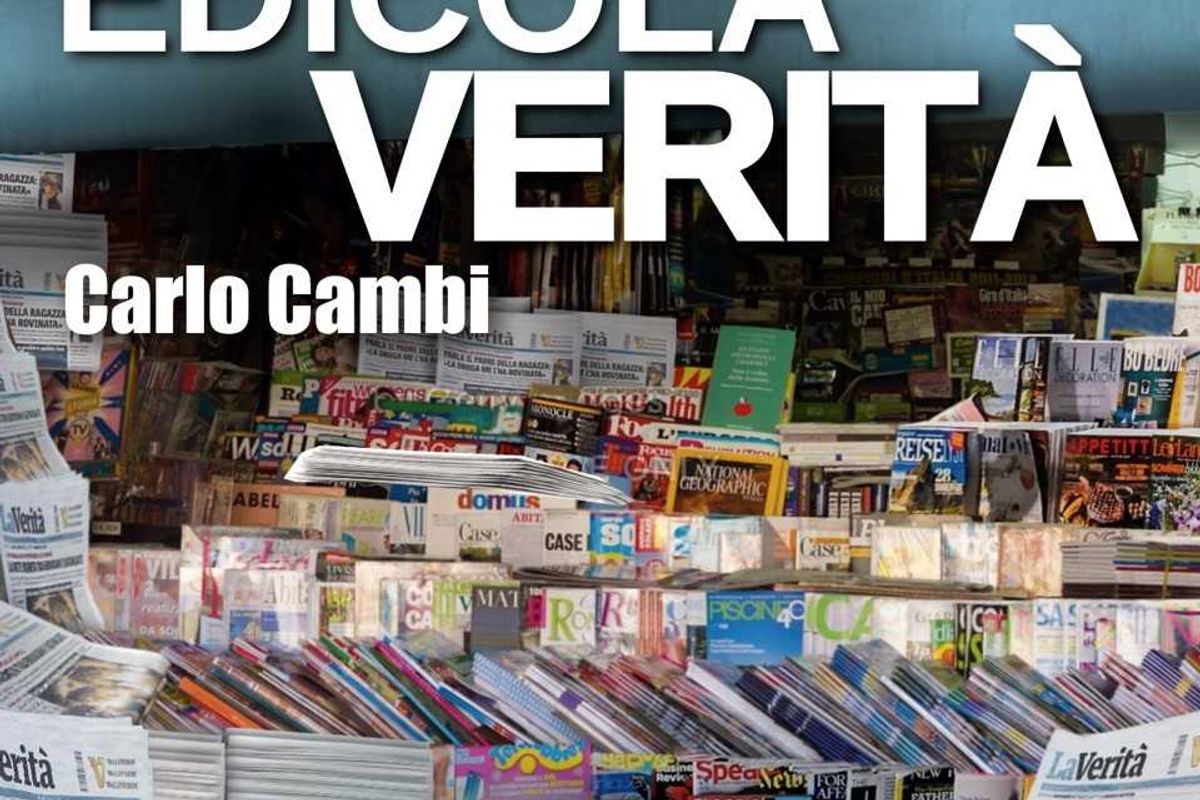2022-05-09
Vi siete meritati il carbone
La centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord, Civitavecchia (IStock)
Dopo decenni in cui, in nome del rispetto ambientale, è stata bloccata ogni innovazione, per sostituire il gas russo si torna a lui, il combustibile più inquinante. Era il male assoluto, ora è l’àncora di salvezza. E le centrali destinate a chiudere ripartono.Il ricercatore del Cnr Nicola Armaroli: «Difficile spingere gli impianti a pieno ritmo. Se le bollette continueranno a crescere scatterà un’autoregolamentazione tra i consumatori».Lo speciale contiene due articoli.E così dopo tante discussioni, dopo il no al nucleare perché fa paura, ai rigassificatori e ai termovalorizzatori perché inquinano, ai pozzi nell’Adriatico perché farebbero sprofondare Venezia, alle pale dell’eolico e ai pannelli del fotovoltaico perché deturpano il paesaggio, siamo tornati al punto di partenza. La guerra ucraina non solo ha evidenziato la centralità dell’energia fossile (solo i ciechi potevano dubitarne) ma ha anche rimesso in gioco l’uso del carbone. Come dire: con la politica del no siamo caduti dalla padella sulla brace. O meglio, sul carbone.Proprio il nemico numero uno della transizione ecologica è diventato l’asso nella manica di quei Paesi, Italia compresa, che lo avevano messo al bando puntando tutto sul gas. «Il ritorno al carbone non è più un tabù»: iI cambio di passo è in queste parole pronunciate alla Bbc dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, il promotore del Green deal europeo, cioè il piano strategico con cui il Parlamento europeo vuole la neutralità climatica entro il 2050. Una delle fasi di questo percorso è la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Il carbone è una fonte fossile a cui sono state addebitate ingenti emissioni di anidride carbonica. Ma ora i proclami di Cop26 sono sfumati. Le tappe della decarbonizzazione, di fatto, sono già saltate. Al momento nessuno se la sente di fare mea culpa per gli errori del passato, o di dire apertamente che la transizione ecologica avrà tempi più lunghi. Si parla di una situazione temporanea, ma l’emergenza rischia di durare a lungo. L’Europa ospita 322 centrali elettriche a carbone e nell’ambito delle riduzioni volute dalla Ue, entro il 2030 la metà di queste (161) dovrebbero essere dismesse o riconvertite. L’Italia, con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), si era proposta obiettivi da prima della classe, anticipando al 2025 la dismissione o riconversione delle sette centrali. Va ricordato che quelle di Civitavecchia (Roma) e Cerano (Brindisi) sono le più grandi d’Europa. Una prima marcia indietro si è avuta a dicembre 2021, quando le centrali di La Spezia (di Enel) e di Monfalcone (di A2A), appena chiuse, sono state riattivate per fronteggiare un rischio di blackout determinato da un improvviso aumento della domanda, dal rialzo del prezzo del gas e dal blocco di quattro centrali nucleari francesi. Il decreto energia prevede una norma per il periodo transitorio sul carbone. Le quattro centrali a carbone in funzione che andavano verso l’eliminazione graduale saranno utilizzate ancora per 18 mesi, massimo due anni, senza aprire quelle già spente e saranno mantenute in funzione con una deroga alle emissioni nazionali ma non a quelle europee. L’obiettivo è di avere un mix di fonti energetiche a disposizione, qualora ci fosse il blocco totale del gas russo.Nel 2019 la produzione degli impianti a carbone copriva il 4,4% del fabbisogno energetico nazionale grazie all’import di materia prima dall’estero. In Italia non ci sono giacimenti di carbone, eccetto il bacino sardo del Sulcis Iglesiente, attivo fino al 2015. Il 90% della materia prima che bruciamo viene quindi dall’estero. Secondo i dati del ministero della Transizione ecologica, nel 2020 l’Italia ha importato carbone principalmente da Russia, Stati Uniti, Canada, Australia e Colombia, raggiungendo in totale quasi 7,1 milioni di tonnellate.Nel nostro Paese funzionano ancora sette centrali a carbone. Una chiusura parziale di alcuni gruppi di produzione ha riguardato la centrale Andrea Palladio presso Venezia (dove però è stata autorizzato l’impiego di più carbone e bloccata la conversione a gas di due gruppi di bruciatori) e la Federico di Brindisi. Sono operativi gli impianti di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, la Grazia Deledda di Portovesme e quella di Fiumesanto vicino a Porto Torres in Sardegna, e quella di Monfalcone (Gorizia). L’attività estrattiva in Sardegna è cessata ma il percorso di chiusura, concordato con l’Unione europea nel 2014 per evitare la procedura d’infrazione sugli aiuti di Stato, non è ancora terminato: dovrebbe concludersi definitivamente nel 2027. Forza Italia in un’interrogazione al Senato ha chiesto di rivitalizzare il sito, facendo riconoscere alla miniera, gestita dalla partecipata della Regione Carbosulcis, lo status di «riserva strategica carbonifera del Paese». Nell’interrogazione si sollecita il governo a intervenire presso la Commissione europea per chieder la revisione del piano di chiusura che ha una potenzialità immediata di 25 milioni di tonnellate di carbone e di successiva «coltivazione» fino a 100 milioni. Nel sito attualmente sono impiegati 113 lavoratori. Il governo dovrebbe fissare in vent’anni «la verifica dell’opportunità del prolungamento dell’attività estrattiva» con un piano dettagliato che preveda l’individuazione delle attrezzature necessarie all’addestramento del personale. La qualità del carbone però non è delle migliori e potrebbe essere impiegato solo se mischiato ad altri tipi. L’iniziativa di Forza Italia è rimasta però senza seguito: per gli ambientalisti il carbone va solo importato. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/vi-siete-meritati-il-carbone-2657284676.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="costi-altissimi-per-le-riattivazioni" data-post-id="2657284676" data-published-at="1652076135" data-use-pagination="False"> «Costi altissimi per le riattivazioni» «Anche se le centrali a carbone andassero a pieno ritmo, cosa difficile, la produzione sarebbe comunque minimale rispetto ad altre fonti di energia. Inoltre va ricordato che l’Italia importa oltre al gas anche il carbone e i prezzi sul mercato, giacché è molto richiesto, stanno salendo». Nicola Armaroli, ricercatore del Cnr e membro dell’Accademia nazionale delle scienze, è scettico sull’uso del carbone come parte di un piano di emergenza. «I costi sarebbero altissimi a fronte di una produzione che coprirebbe solo una parte esigua del fabbisogno nazionale di elettricità», ripete. È un paradosso. Dopo anni di demonizzazione del carbone si sono create le condizioni per considerarlo una soluzione contro la crisi energetica. «Sì, devo riconoscere che è un paradosso. Ma da troppi anni rinviamo l’intensificazione dell’uso delle fonti rinnovabili, le uniche “nazionali” che ci consentirebbero di sottrarci alla dipendenza dei Paesi produttori di gas. Tornare al carbone sarebbe un disastro per l’ambiente. D’altronde il decreto energia dice di mantenere la produzione di questo combustibile fossile solo in via transitoria per affrontare l’emergenza». Mettiamo che tutte le centrali a carbone vadano al massimo delle loro capacità: quale quota del fabbisogno riuscirebbero a coprire? «Solo un massimo di 7.000 megawatt. Ma è un’ipotesi irrealistica. È difficile possano andare a pieno regime perché in alcuni impianti si è fermata la manutenzione in vista della dismissione imminente. Spingerli a piena potenza non è come accendere un interruttore. Richiede interventi costosi che è difficile sostenere, sapendo che sono per una situazione temporanea». Quale è la situazione dell’approvvigionamento energetico italiano? «La domanda di potenza di punta sulla rete va da 45.000 a 55.000 megawatt e il carbone coprirebbe, alle condizioni ottimali indicate prima, circa il 10% del fabbisogno elettrico. Il carbone sardo è di bassa qualità perché ricco di zolfo e può compromettere il funzionamento delle centrali. Resta però che al momento sul fronte del gas i rifornimenti dalla Russia continuano regolarmente. I gasdotti russi vanno in tre direzioni. Lo Yamal, che alimenta la Polonia, è chiuso in parte, la diramazione TurkStream sulla Bulgaria ha flussi ridotti, mentre la condotta che arriva a Tarvisio e alimenta Austria e Italia non si è interrotta. Per noi al momento non c’è emergenza». Dove andiamo a prendere il carbone? «I più grandi esportatori sono Russia, Indonesia e Australia, che hanno lo svantaggio di essere lontani. Il decreto, con il capitolo sul carbone, cerca di prevenire eventuali emergenze con l’uso delle poche centrali in funzione per massimo due anni, con una deroga alle emissioni nazionali. Nel frattempo si valuta la situazione nel periodo estivo, quando i consumi elettrici hanno un picco per l’accensione dei condizionatori. Sarà un test per verificare in che misura avremo bisogno del carbone nel prossimo inverno. Dipende dal clima: se ci sarà un’estate torrida e un inverno freddo, i consumi aumenteranno. Al momento è difficile fare previsioni. Le centrali a carbone possono garantire al massimo un risparmio di 5 miliardi di metri cubi, altri 5 miliardi potranno venire da nuovi fornitori come il Congo e altrettanti dall’Egitto. Occorre però far lavorare a pieno regime i rigassificatori attuali ed eventualmente attivarne uno o due nuovi. Penso comunque che scatterà un’autoregolamentazione dei consumi da parte degli italiani spaventati dal caro bollette». Intensificare la produzione di elettricità da carbone ha un costo. Le aziende sono disposte a maggiori investimenti? «Bella domanda. Il governo non può obbligare a far funzionare le centrali a carbone a pieno ritmo. La produzione di energia elettrica è gestita da aziende private soggette a condizioni tecniche e logiche di mercato. Chi investirà per spingere al massimo la produzione sapendo che entro pochi anni dovremo chiudere gli impianti? Se poi ci rivolgiamo ai grandi produttori esteri, non possiamo illuderci che ce lo regalino». Come se ne esce? «L’unica strada è quella delle rinnovabili. Il gas del Congo ha bisogno dei rigassificatori galleggianti, sul mercato internazionale ce ne sono pochissimi e sono molto richiesti. Chi li ha li mette all’asta, ed è ipotizzabile che la Germania sia pronta a pagarli a peso d’oro, non avendone neanche uno in funzione al momento. Se non andiamo con decisione verso le rinnovabili, alla prossima crisi energetica ci troveremo in una situazione peggiore. Se non cambiamo il sistema energetico, resteremo sempre dipendenti da qualcuno. È ora di cambiare strada».
Uomini del battaglione Azov (Ansa)
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 novembre con Carlo Cambi