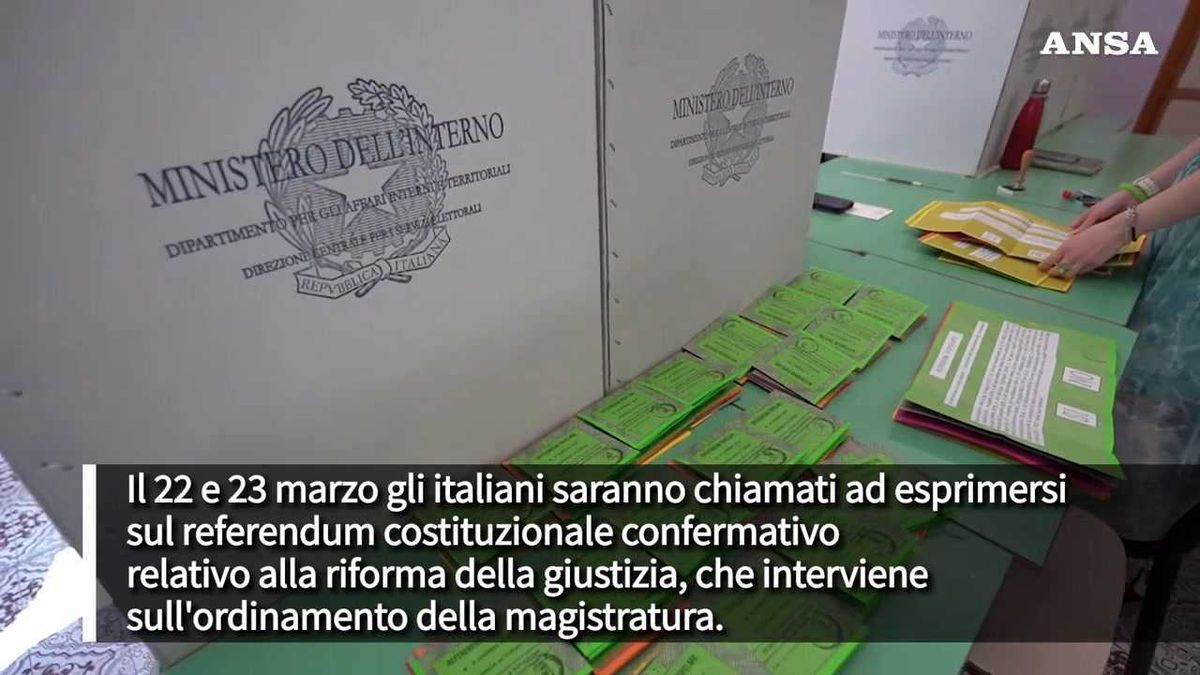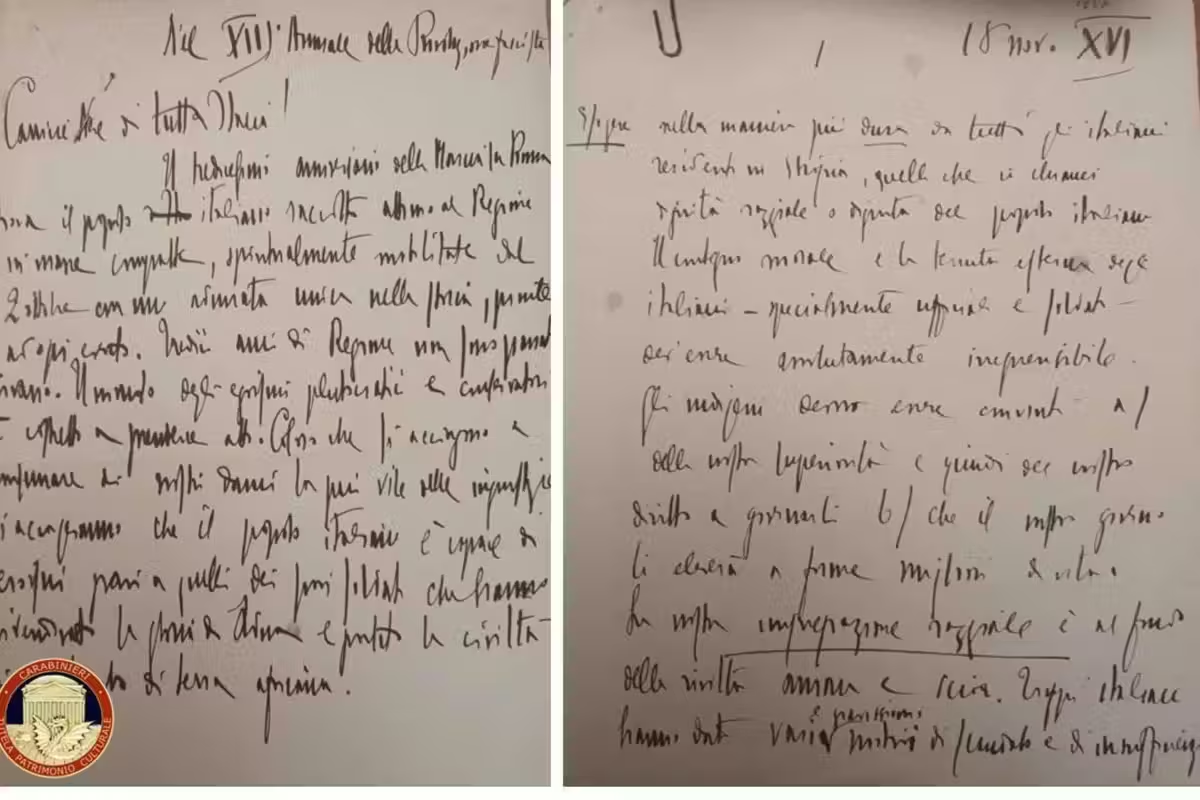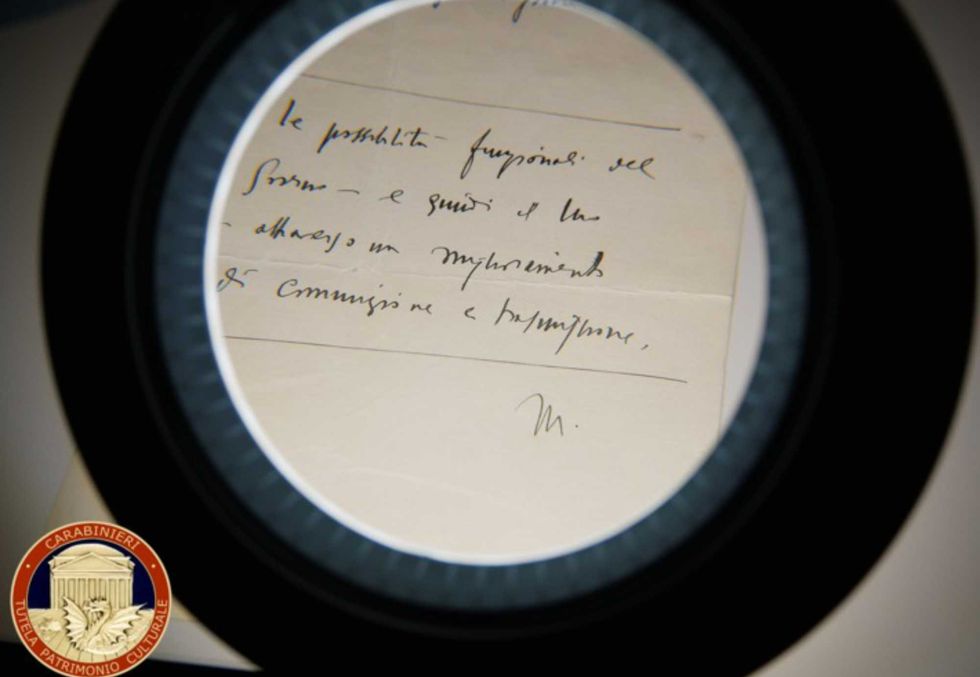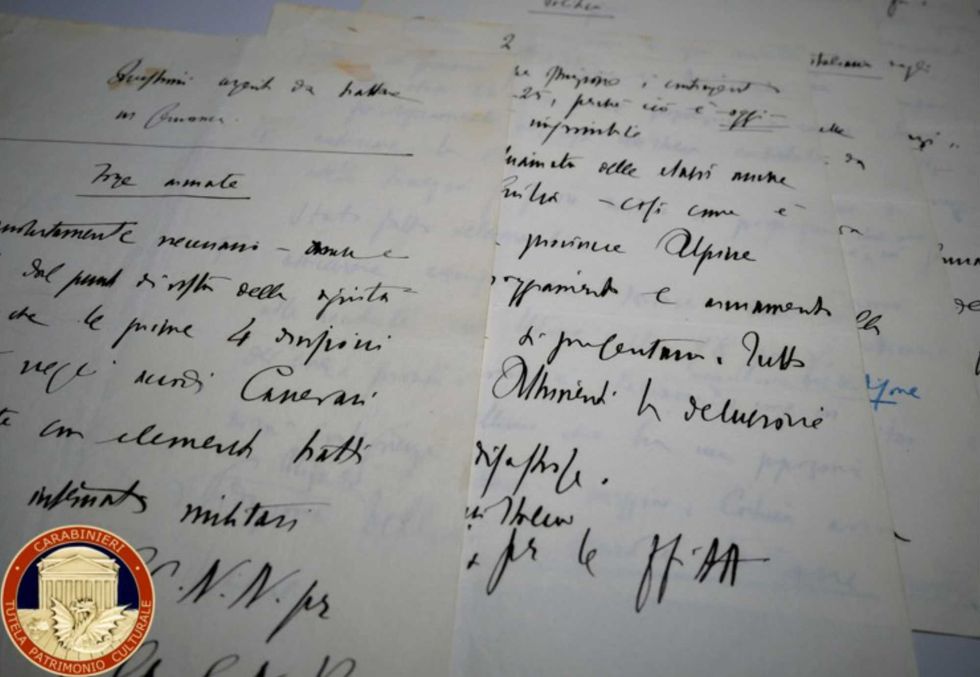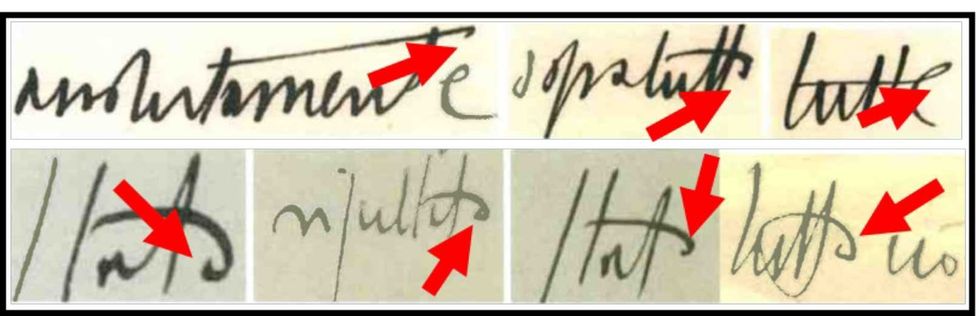La grande osteria dei popoli riapre le porte. Verona è pronta per la 55ª edizione del Vinitaly che si annuncia come la fiera del vino record del post Covid. Alla rassegna, aperta dal 2 al 5 aprile, sono attesi da oltre 4.000 cantine decine di migliaia di buyer di tutto il mondo, sommelier, giornalisti enoici. L’anno scorso, primo anno dopo la pandemia, gli acquirenti stranieri furono 25.000 provenienti da 139 paesi su un totale di 88 mila operatori del settore. Quest’anno a far volare il Vinitaly sarà il ritorno di Cina e Giappone e la presenza di oltre mille super buyer selezionati e invitati all’appuntamento di vino tra i più importanti del mondo. E in città si stanno lustrando i calici per accogliere altre decine di migliaia di winelover, amanti del vino. Stormi di Giulietta e Romeo da barricaia.
Ai 55 anni di vita del Vinitaly vanno sommati i 3000 e passa anni di vite e di vino nel territorio veronese. Fu Hans Barth, giornalista tedesco corrispondente da Roma del Berliner Tageblatt all’inizio del Novecento, immenso bevitore e poeta di vino, a chiamare Verona «l’osteria dei popoli» nella sua Guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri (1909). Ispirato da una musa ebbra di rime e versi, Barth cantò la città scaligera con gorgogliante entusiasmo: «Noi specialisti nel genere la chiamiamo la grande osteria dei popoli. Olimpo Walhalla, Eden a un tempo; un’osteria potente, coronata di lauro, aureolata di poesia: l’osteria d’Italia!». Versi di spirito e mito.
Non si visita Verona, non si accostano i veronesi, senza conoscerne l’anima. Urbs multibibens, enocapitale d’Italia, a Verona ci si arriva preparati. E non c’è niente di meglio per capire i veronesi, afferma Barth, che capire la loro sete. Lui la capì perché era anche la sua sete. Una sete storica, atavica. Una imperiale sete di vino che risale ai tempi di Cassiodoro e, giù giù nei secoli, fino ai Reti, fino ai sapiens dell’età del bronzo. Attenzione, però. La sete di Verona non è mai stata un bisogno corporale, ma sociale. Non per niente da secoli l’osteria è la seconda casa dei veronesi. Era, ed è, un’arte, un modo di essere, una filosofia esistenziale. Bibo, ergo sum? Puttanata. A Verona l’osteria era ed è ancora quella che per gli Ateniesi era l’agorà, per i Romani le terme, per i tedeschi le birrerie, per i francesi le garconnieres: un piacere civico.
La Magna Verona del vescovo medioevale Raterio, l’Urbs Picta rinascimentale, la Bella Verona di Shakespeare, ha trovato lungo i secula seculorum il minimo comune multiplo nell’osteria, il luogo parallelo, la seconda dimensione del vivere veronese quotidiano. Il gòto, il bicchiere di vino, nella città scaligera era ed è mosto di democrazia. Ha sempre favorito i rapporti, le amicizie. Il vino - assaporato, non ingollato - ha aiutato la ragione a risolvere i problemi, le difficoltà della vita. Da secoli l’osteria è stata (ed è) il luogo deputato alle confidenze, alle consolazioni reciproche. Il posto dove si mescolano lingue, dialetti e sentimenti. Non per niente gli stranieri si sono sempre trovati bene a Verona: i Goti (quelli di Teodorico, non i bicchieri) elevarono Verona a capitale, i Longobardi vi dimenticarono le originarie steppe, i francesi i loro chateaux, e gli austroungarici la lasciarono nel 1866 piangendo.
Tanto affetto per le osterie lo si deve anche agli osti, capaci di trattenere gli avventori apparecchiando sul bancone bocconcini da abbinare ai vini: Bardolino e sarde del Garda; baccalà e Durello di Monteforte; trippe e Valpolicella; pastissàda de cavàl e Amarone; alborelle e Soave; uova soda e broccoletti e Custoza... E così, tra una ciàcola e l’altra, tra una acciughina col cappero e l’altra, si fa presto a fusilàr, fucilare, tre o quattro goti tirando tardi e cementando nuove amicizie. Il dialetto è la colonna sonora del bere veronese, il lessico famigliare. Un verbo nato nelle osterie dell’ansa dell’Adige è cicàr. Corrisponde al masticare tabacco, ma si usa anche con i vini robusti. Cicàr un goto equivale a bere un bicchier di vino «mangiandolo».
A Verona fino ad un secolo fa prosperavano centinaia di osterie, perfino 12 in una sola strada. Ai nostri giorni non è più l’osteria dei popoli, ma si difende ancora bene. Locali dove si beve bene accompagnando il goto con un panino con la soppressa o il cotechino, con un piattino di testina o un’insalatina di nervetti, si trovano ancora. Il bicchiere è taumaturgico, filosofico. San Zeno, Platone e Freud declinati insieme. Aiuta a tirar fuori quello che si ha dentro, a fare amicizia, a ragionare con gli altri avventori di politica, di calcio dei casi della vita. E pazienza se qualche osteria è diventata una sas, se ha il www accanto al numero telefonico o è in facebook. Non sono i tributi alla modernità a fare l’osteria, ma la bevuta paziente, la conversazione con il calice in mano, la polpettina di carne, l’assaggio di rénga, l’aringa affumicata, il piatto di baccalà, di trippe o i superbi pasta e fasòi e pastissàda de cavàl. In certe osterie di campagna si trovano ancora piatti dimenticati: le verze rabbiose, le raìse (radici) col lesso, l’oco o il sisòn (oca o anatra muta) in umido.
Girare per le osterie di Verona è un itinerario alternativo, ma sempre legato a cultura, arte, storia. Accanto a loro ci sono sempre chiese magnifiche, piene di capolavori, edifici medievali, palazzi veneziani, architetture moderne: Pisanello e Scarpa, il Veronese e Libero Cecchini, Gerolamo dai Libri e Pier Luigi Nervi. È la Verona fascinosa e suggestiva dei veronesi. Purtroppo molte delle osterie di Hans Barth non ci sono più. Se si tracciasse sulla mappa della città scaligera una croce per ogni osteria scomparsa, Verona diventerebbe un cimitero monumentale. Nel quartiere popolare di San Zeno, quello di Papà del Gnoco, ce n’era un firmamento intero: l’Osteria al Sole, quella alla Stella, l’Osteria alla Luna celebrata da Barth per la bontà dei vini e il florido seno dell’ostessa: «Ecco Gina, la fiorente figlia della più provocante delle mamme! Scendi giù nella grotta e portaci la delizia dei colli veronesi, la delizia fresca e voluttuosa, dalla lieve schiuma frizzante, la rossa delizia nella cui capace e chiusa arca vorrei un giorno riposare come il duca di Clarence: “Dove avrai tu riposo/ o stanco pellegrino?/ Entro la bella Luna,/ nel più ricolmo tino”».
La Bottiglieria al Piccolo Mondo Antico dei fratelli Sterzi era in via Scudo di Francia, perpendicolare a via Mazzini. Alla loro corte si davano appuntamento gli intellettuali della città: poeti, giornalisti, pittori. Tra gli altri il pittore Angelo Dall’Oca Bianca e il poeta Berto Barbarani che mise in versi il potere curativo dell’osteria: «Se la fortuna la me fa i corni/ mastego amaro per tutto un dì/ me scondo drento de na ostaria/ nego la rabia drento al vin…/ torna l’allegra malinconia/ caval del mato del me destìn!».
L’osteria-farmacia, l’osteria-casa; l’ostessa madre, sorella, amante. Nel cuore più antico di Verona, in corticella San Marco, c’era il bettolino della Nina. Poco lontano, in corte Sgarzarie, c’era l’osteria della Màlia. L’osteria Scaligera era in uno dei palazzi che appartennero ai Della Scala, poco lontana dalle gotiche Arche, le loro tombe. Apriva la porta nel palazzo che, secondo la tradizione, era di Romeo Montecchi. Era anche salumeria e doveva essere davvero un ritrovo di grande fascino, con baldacchini di lardi e prosciutti appesi al soffitto, festoni di salsicce, piramidi di formaggi. Qui il bibace giornalista tedesco beveva un «buon vinello bianco frizzante, dall’aspetto chiacchierino». L’osteria alle Arche. «Fin che gh’è vin, ghe sarà Verona», dice un profetico proverbio veronese. Difficile smentirlo.